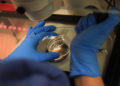«Come un poco di raggio si fu messo/ nel doloroso carcere, e io scorsi/ per quattro visi il mio aspetto stesso,/ ambo le man per lo dolor mi morsi» (Inferno, canto XXXIII)
«Come un poco di raggio si fu messo/ nel doloroso carcere, e io scorsi/ per quattro visi il mio aspetto stesso,/ ambo le man per lo dolor mi morsi» (Inferno, canto XXXIII)
I figli sono di chi se li merita – dicevano alla radio, citando un qualche saggio che ora non ricordo. Sarebbe bello se fosse così; e se fosse così, io di certo non sarei diventata madre. Poi ci ripenso: sarebbe davvero bello? Bello forse sì, ma inumano; perché dell’umano fa parte anche il brutto e il demerito.
Sono cresciuta in una famiglia a suo modo unica e assurda, con un padre altamente imperfetto e per questo insostituibile. A 37 anni lo ringrazio di avermi fatto sudare il nostro legame ogni singolo giorno, facendomelo anche detestare. Nostro malgrado, sappiamo bene entrambi che ci somigliamo profondamente. E questo ci costringe a non ignorarci, e talvolta anche a volerci bene. La cosa più misteriosa della famiglia è questa somiglianza, che ci lega a un padre e una madre ancora prima che ci sia un affetto. Che ci lega, qualsiasi tipo di affetto ne nasca o non ne nasca; assente o distorto che sia.
Andrea Loris Stival era proprio uguale a sua mamma Veronica; non ho potuto fare a meno di notarlo, mentre in tv continuano a inondarci delle loro foto. Come il conte Ugolino, anche lei non poteva che rivedere se stessa sul volto del figlio. E ora è in carcere, accompagnata dall’accusa più tremenda: quella di aver ucciso con crudeltà il proprio bimbo. E salta fuori tutto il vaso di Pandora del suo passato; un tentativo di suicidio alle spalle; ragazza violenta; figlia di una madre che le aveva detto che la sua nascita era un errore. Gli psicologi chiosano il tutto, dicendo: uccidere un figlio è un atto che implica uccidere anche se stessi. Ma ogni interpretazione, per quanto azzeccata, non basta a dare un senso al grumo di peccato e di virtù che è il cuore umano e che, di padre in figlio, batte in noi.
Rimasi colpita vedendo a teatro I promessi sposi alla prova di Giovanni Testori e quell’intuizione di unire in un unico personaggio Gertrude, la monaca di Monza, e la madre di Cecilia, quella che depone con ogni premura la figlia morta di peste sul carro dei monatti. Un monumento, lo definisce Testori: una statua che è il tutt’uno di un’assassina sventurata (Gertrude) e una pietosa santa (la mamma di Cecilia). A ricordare cosa? La speranza – dice sempre Testori.
La speranza non è nel merito, ma nella lotta. La speranza non è nel fluido passaggio di bravura in bravura, ma nella possibilità che questa somiglianza radicale che ci lega, padri-madri-figli, dia frutto in mezzo alle complicanze. E accade. A Manchester la giovane infermiera Leah si è messa a cercare sua madre, che l’abbandonò appena nata vent’anni fa. Vuole incontrarla solo per dirle che è diventata nonna e che ora ha una figlia e una nipote da amare. Ecco la forza della somiglianza viscerale: vedi te stessa riflessa nei lineamenti di tua figlia neonata, e questo ti spinge verso chi è sangue del tuo sangue, sebbene non ci sia mai stato affetto o merito o bontà di sorta. Leah chiede solo di poter passare il Natale con sua madre e sua figlia. E forse, al cospetto della Natività abbiamo anche questo da chiedere: lo sguardo attonito e semplice di Maria e Giuseppe, che – credo proprio – non sentissero di meritare quel Figlio.