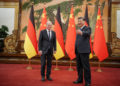È indubbiamente suggestiva l’idea espressa recentemente dal Capo dello Stato nell’ipotizzare una soluzione diplomatica all’attuale conflitto. Il modello da seguire – ha dichiarato a Strasburgo Sergio Mattarella – deve essere quello della conferenza di Helsinki. Non quello di Yalta. Quest’ultima, per quanto sia convinzione diffusa che abbia stabilito le sfere di influenza rispettivamente di Stati Uniti e Urss, si limitò a prendere atto dei territori raggiunti e occupati dai rispettivi eserciti, impegnati nel ricacciare i nazisti. Invece la conferenza del 1975, ospitata nella neutrale Finlandia, provò a superare le logiche del confronto/scontro di Yalta, alimentate altresì dalla deterrenza nucleare.
Cosa diceva l’Atto di Helsinki
Nata sulla scia della Ostpolitick del cancelliere socialdemocratico Willy Brandt, finalizzata a trovare una forma di convivenza tra la Germania dell’Ovest e la Ddr, Helsinki vide una trentina di paesi europei trovare insieme a statunitensi, canadesi e russi un terreno comune di cooperazione tra i cittadini e le società, pur divise dalla cortina di ferro, in cambio dell’inviolabilità dei confini. Certo, tale garanzia segnava in apparenza una vittoria dei sovietici, per cui molti furono i critici di quella conferenza e tante le accuse di cedimento all’interno del mondo libero. Eppure l’articolo 7 dell’Atto finale impegnò espressamente i firmatari a promuovere i «diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ivi compresa la libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di convinzione».
Di più: l’Atto confermò «che i culti religiosi e le istituzioni e organizzazioni religiose, agendo nel quadro costituzionale degli Stati partecipanti, e i loro rappresentanti possono, nell’ambito delle loro attività, avere fra di essi contatti ed incontri, e scambiarsi informazioni». La libertà religiosa non era più dunque un fatto privato del singolo (magari da vivere pure in clandestinità), ma qualcosa che si poteva esprimere in atti pubblici, in relazione con altri e al di là delle rigide divisioni geopolitiche.
Helsinki e i cambiamenti del 1989
Non è un caso che per la prima volta dal Congresso di Vienna del 1815 anche la Santa Sede partecipò alla conferenza internazionale. Come non fu un caso che i lavori furono segnati dall’intensa attività del delegato di Paolo VI, monsignor Agostino Casaroli, preoccupato di ridare respiro alla Chiesa del silenzio con la possibilità di riassegnare vescovi alle diocesi che ne erano state private dai regimi e di riattivare un sostegno operativo da parte delle comunità cattoliche occidentali. Ovviamente quelle enunciazioni rimasero per lo più tali all’interno del blocco sovietico. Tuttavia in forza di quegli impegni sanciti il movimento Charta 77, per esempio, rivendicò maggiore libertà in Cecoslovacchia.
Sempre su quelle stesse enunciazioni fece leva Giovanni Paolo II quando, sostenendo le lotte sindacali di Solidarnosc e di Lech Walesa, il primo settembre 1980 scrisse ai firmatari di Helsinki per ricordare che solo «il pieno rispetto dei diritti garantito effettivamente a tutti gli uomini può assicurare la pace completa». Non fu quindi Helsinki a determinare i cambiamenti epocali del 1989, ma nemmeno è vero che questi avvennero a dispetto della cristallizzazione dei confini sancita dagli accordi sottoscritti nel 1975: la conferenza sulla cooperazione e sicurezza contribuì a delimitare uno spazio pubblico perché venissero alla ribalta i veri protagonisti del cambiamento.
Intendersi sulla comune base di intesa
Da questo punto di vista la suggestione di Mattarella – a cui è seguita quella del segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Pietro Parolin, il quale ha chiesto di «tornare allo spirito di Helsinki» – può essere effettivamente un contributo per uscire da quello che pare sempre di più il pantano ucraino, dove nessuno sembra vincere davvero e per questo appare necessario agli attori coinvolti alzare la tensione con il rischio di una pericolosa escalation globale.
Tuttavia bisogna intendersi sulle fondamenta di una comune base d’intesa. I diritti umani nel mondo globalizzato hanno infatti assunto un significato troppo equivoco, quale esito di quella «dittatura del relativismo», come ebbe a dire Joseph Ratzinger nella celebre omelia della messa precedente al conclave che lo avrebbe eletto Pontefice, «che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie». Se voglio un figlio con un partner dello stesso sesso e posso tecnicamente ottenerlo, devo vedermi ricono
Che cosa si intende per diritti umani?
Così ogni nuovo diritto è interpretato nel senso di una legittima rivendicazione individuale, in ragione della quale sono sempre più rigettate espressioni religiose o visioni del mondo in potenziale conflitto con quella stessa pretesa. E l’esito è anche quello di gettare dalla finestra ciò che pure era entrato dalla porta proprio con Helsinki. Non stupisce quindi che un importante documento sulla libertà religiosa, firmato nell’aprile del 2019 da papa Francesco e redatto dalla commissione teologica internazionale, denunciava il rischio corso dalle democrazie occidentali di trasformarsi in una «imitazione laicista della concezione teocratica della religione».
Quando infatti in nome di una «ideologia egualitaria e a-valutativa» si finisce per escludere dallo spazio pubblico «un determinato ordine di preferenze, che associano la responsabilità morale e l’argomentazione etica ad una visione antropologica e sociale del bene comune», la società si impoverisce sempre di più e l’omologazione si impone.
L’importanza della libertà religiosa
Se si è costretti a compiere atti o a ricevere un’educazione contraria alla propria fede, allora si è anche impediti a informare di qualunque ideale sinceramente vissuto opere sociali, culturali, di formazione e di cura che arricchiscono e rendono plurale la società. L’esperienza del dissenso dell’est Europa negli anni Settanta e Ottanta testimonia ancora oggi quanto l’affermazione della libertà religiosa possa cambiare il corso della storia e ridisegnare assetti geopolitici.
Una nuova Helsinki quindi potrebbe aiutare a governare pacificamente il mondo multipolare dei prossimi decenni. Come potrebbe aiutare la società russa, che vede oggettivamente conculcata la libertà di pensiero, di espressione e persino la libertà religiosa a motivo dell’antico retaggio cesaropapista. Tuttavia anche l’Europa ne gioverebbe, se solo la sua classe dirigente avesse meno vergogna e si mostrasse meno ostile alla storia cristiana che ha reso la nostra parte di mondo ciò che è.