In questi giorni cupi tanti hanno tratto conforto dalle immagini dell’union sacrée francese: uomini e donne di tutti (quasi) i partiti politici, cristiani, musulmani e atei, che scendono in piazza insieme sotto le stesse bandiere, matite verso il cielo e “Je suis Charlie” scritto su di un cartello appeso al collo. Tanti si sono consolati pensando: «Quelli che vogliono la pace sono molti di più di quelli che vogliono la guerra». Ma la consolazione dura poco quando si ascoltano le voci che arrivano dai “territori perduti della repubblica”, come ebbe a definirli il titolo di un libro scritto nel 2002 da un collettivo di professori che raccontavano il razzismo, l’antisemitismo e il sessismo nelle scuole di banlieue. I quartieri periferici delle grandi città francesi sono pieni zeppi di potenziali emuli dei fratelli Kouachi. Bastava sintonizzarsi qualche sera fa sulla puntata di Servizio Pubblico di Michele Santoro (non esattamente una trasmissione populista xenofoba) per veder scorrere immagini riprese nel quartiere dei due terroristi. Si sentivano i loro compagni e coetanei prendere le loro difese ed esecrare come fascisti che se l’erano cercata i disegnatori di Charlie Hebdo trucidati. Il fallimento del modello francese dell’integrazione degli immigrati attraverso la scuola laica è apparso in tutta la sua enormità.
Lo spettatore in cerca di rassicurazioni avrà pensato: «Quella è la Francia, da noi per fortuna non è così». Errore. La differenza fra la Francia e l’Italia è solo di quantità (per ora), non di sostanza. In un altro filmato della stessa trasmissione santoriana, sono apparsi gli amici di Anas al-Italy (foto sotto a sinistra), l’ex rapper italo-marocchino di Vobarno (Brescia) che è andato a combattere e a morire con l’Isis in Siria l’anno scorso. Anche loro hanno giustificato la scelta del ragazzo, e in particolare il rapper marocchino Dr. Domino, al secolo Amine Mokdar, ha spiegato che è proprio la scuola il luogo dove i giovani musulmani si sentono osteggiati e discriminati. «Finché sei piccolo tutto va bene e non ti accorgi di niente, ma quando arrivi alle superiori le cose cambiano: ci sono quelli con la testa rasata, ci sono quelli che ti rinfacciano il fatto di essere marocchino».
La promozione di Marco
La situazione è davvero paradossale, perché tutti sono d’accordo che l’integrazione (in Francia la parola è già considerata politicamente scorretta, e si usa piuttosto l’espressione “il vivere insieme”) passa attraverso l’educazione. Tutti sono d’accordo che gli anni trascorsi a scuola sono quelli che modellano in modo decisivo la personalità: nel romanzo di Michel Houellebecq, Sottomissione, anche i Fratelli musulmani, saliti al potere in un governo di coalizione, chiedono per sé il ministero dell’Educazione, perché «la vera posta in gioco sono i bambini e la loro educazione». Ma se guardiamo a paesi pur dotati di sistemi scolastici molto qualificati come Francia e Gran Bretagna, vediamo che i risultati sono fallimentari.
Per fortuna esperienze positive in Italia esistono. Da due anni collaboro con Portofranco, un luogo di aiuto allo studio per studenti delle superiori in difficoltà. Ogni anno 1.700 studenti usufruiscono di migliaia di ore di lezione personalizzata da parte di 500 volontari, perlopiù universitari o docenti in pensione. I giovani stranieri iscritti sono meno di un terzo del totale, ma sono almeno la metà di quelli che poi realmente frequentano i corsi. A me, che mi rendo disponibile per lezioni di italiano, storia e filosofia, per una specie di legge del contrappasso (ho battuto in questi anni quasi tutti i paesi del Nordafrica e del Medio Oriente per reportage sull’islam politico e sui cristiani perseguitati da estremisti islamici) capitano quasi sempre ragazzi e soprattutto ragazze musulmane. Anche se il mio più grande successo è stato Marco, un giovane cristiano egiziano che tutti – compreso lui stesso – consideravano un caso disperato, e che invece si è diplomato col quinto voto più alto della sua classe.
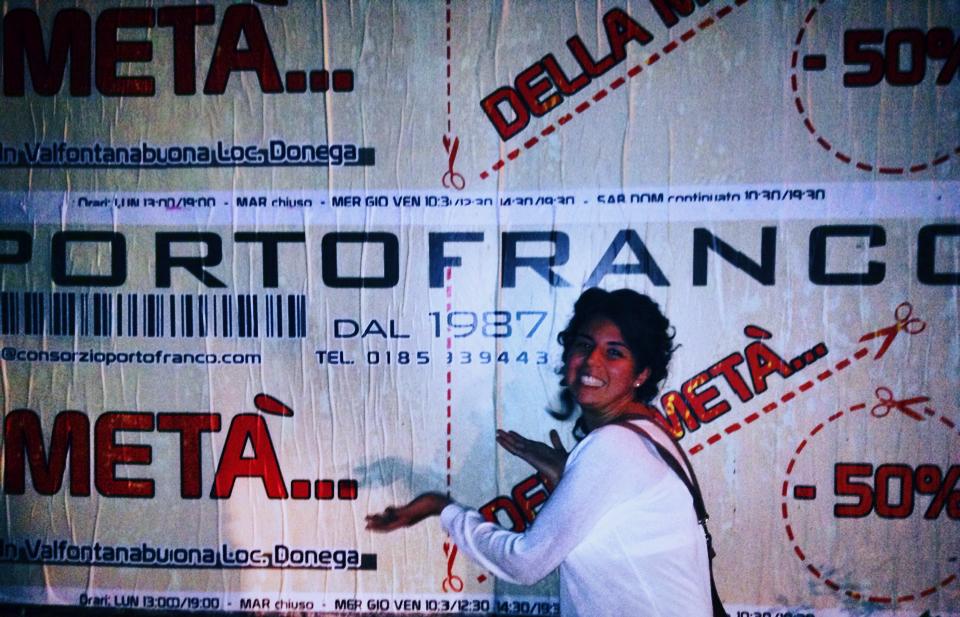 Portofranco cambia in meglio sia chi dà – i volontari – sia chi riceve – i ragazzi. Lo si vede dai risultati scolastici, ma non solo da quelli. Posso affermare con una certezza vicina al 100 per cento che da loro non verranno fuori estremisti religiosi, o gente che rigetta in blocco la nostra società e che pratica il rancore identitario. A Portofranco i ragazzi incontrano persone che li fanno sentire importanti non perché si interessano alle loro origini o alla loro cultura. Ma perché danno gratuitamente il proprio tempo per loro. L’autostima dei ragazzi cresce impetuosamente perché scoprono che adulti italiani di estrazione religiosa diversa dalla loro li considerano abbastanza importanti e interessanti da dedicare loro gratuitamente ore di serio lavoro.
Portofranco cambia in meglio sia chi dà – i volontari – sia chi riceve – i ragazzi. Lo si vede dai risultati scolastici, ma non solo da quelli. Posso affermare con una certezza vicina al 100 per cento che da loro non verranno fuori estremisti religiosi, o gente che rigetta in blocco la nostra società e che pratica il rancore identitario. A Portofranco i ragazzi incontrano persone che li fanno sentire importanti non perché si interessano alle loro origini o alla loro cultura. Ma perché danno gratuitamente il proprio tempo per loro. L’autostima dei ragazzi cresce impetuosamente perché scoprono che adulti italiani di estrazione religiosa diversa dalla loro li considerano abbastanza importanti e interessanti da dedicare loro gratuitamente ore di serio lavoro.
L’altra cosa che colpisce tantissimo questi adolescenti è vedere degli adulti che si tuffano nelle pagine di storia, di letteratura, di chimica o di inglese con lo stesso entusiasmo con cui si tufferebbe in piscina con gli amici. Vedono qualcuno che trae godimento dalla conoscenza delle cose e dalla relazione con le personalità del passato: scrittori, poeti, personaggi e popoli della storia. Capiscono che per essere non basta dichiarare di avere un’identità: occorre uscire da se stessi e andare incontro a ciò che è fuori di noi. Capiscono che l’identità non si afferma nel ripiegamento e nella rivendicazione, ma si realizza nel rapporto con la realtà, nell’uscire da sé per abbracciare ciò che è fuori da noi, persone e saperi. Allora tutto diventa nostro, ci appartiene, e questo nuovo avere ci permette di essere. Ricordo che quando spiegavo la Rivoluzione russa o il fascismo, Marco mi guardava incantato. Poi diceva: «Prof, si vede che queste cose le sente sue, si vede che c’entrano con lei». E io allora capivo che ce l’avrebbe fatta.
Dunque non si tratta di incoraggiare i ragazzi a manifestare la loro diversità, di “dialogare” con loro sulla base delle rispettive differenze, di “riconoscere” la loro identità. Queste sono cazzate moralistiche e sociologiche. Il vero riconoscimento, il vero dialogo avvengono su tutt’altra base: il fatto che loro si accorgono che tu parti da un’ipotesi positiva su di loro, che hai uno sguardo valorizzante su di loro che dice: «Non so nulla di te, non conosco la tua storia, non so se riuscirò a capirti, ma sono certo che in te c’è una positività e una capacità di costruire e sono qui perché voglio che vengano fuori e cambino la faccia del mondo».














