
Come vuole la regola numero uno del giornalismo – la notizia in testa – parto subito dando la notizia: questa non è una recensione. E non è neanche un invito alla lettura. Queste brevi righe vogliono essere piuttosto un omaggio, un tributo a un autore e a un libro ai quali tantissimi di coloro, in Italia e nel mondo, che si ostinano a professarsi cattolici debbono molto, il sottoscritto per primo. Lui è Vittorio Messori, giornalista e scrittore cattolico che non ha bisogno di presentazioni; il libro è Ipotesi su Gesù, long-seller edito per la prima volta nel lontano 1976 e che ora, dopo qualche milione di copie vendute, decine di ristampe e altrettante traduzioni (compresa una versione in braille per i non vedenti), è tornato in libreria per i tipi dell’editore Ares.
Volumi di successo
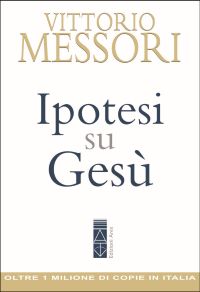
Rispetto all’edizione originaria l’impianto dell’opera è rimasto pressoché inalterato; solo il secondo capitolo, intitolato Un Dio nascosto e scomodo, è stato eliminato per disseminare negli altri capitoli ciò che l’Autore ha ritenuto fosse ancora valido. Ipotesi su Gesù è stato il volume, il primo di una lunga serie (ne seguiranno altri 23, tutti di successo), che fece conoscere Messori, all’epoca giornalista professionista in forza alla Stampa di Torino dove seguiva l’inserto “TuttoLibri”, al grande pubblico.
Il giornalista laico
Fin da subito fu chiaro che le appena tremila copie della tiratura iniziale non sarebbero state sufficienti. Le Ipotesi divennero in poco tempo un caso editoriale con un milione di copie vendute solo in Italia dopo appena un anno, segno evidente che l’opera era in qualche modo attesa, era la risposta ad un bisogno latente che evidentemente in quegli anni turbolenti del post Concilio e di profondi sconvolgimenti politici e sociali, aspettava solo la scintilla per esplodere. Scintilla il cui effetto fu senza dubbio accresciuto dal fatto che non si trattava dell’ennesimo lavoro storico-esegetico dell’esperto di turno, ma di un libro su Gesù scritto da uno sconosciuto, per giunta laico, che di mestiere faceva il giornalista.
La legge dell’et-et
Insomma le premesse perché l’accoglienza di un’opera simile fosse a dir poco tiepida, soprattutto in certi ambienti ecclesiali, c’erano tutte. Invece le cose andarono diversamente. Tanto più che il taglio divulgativo non inficiò per nulla il rigore e la serietà della ricerca che Messori aveva appreso da studente nelle scuole subalpine. Semplicità e rigore allo stesso tempo: se i “segni” parlano, anche nello “stile Messori” è da rinvenire quella legge dell’et-et tipica del cattolicesimo – che sta a significare come tutto, alla luce della fede, si tiene, anche i contrari – che Messori fece sua mutuandola da Jean Guitton (beninteso, legge dell’et-et che non solo non ha nulla a che vedere con quella dell’aut-aut propria dell’eresia, ma che anche è distante anni luce dalla posizione del “sì, ma” propria di certa teologia situazionista, oggi di nuovo in auge e le cui conseguenze sono sotto gli occhi di tutti).
Cuore e ragione
In realtà, se le Ipotesi vennero accolte – dice Messori – con «simpatia… e senza obiezioni “tecniche”… la ragione è nel non aver lesinato tempo e fatica; sono gli anni di ricerca, di riflessione, di vita che – a partire da quell’estate – ho gettato nelle pagine che seguono». Gli anni di cui parla Messori furono ben dieci; un decennio di studi e ricerche per approfondire, per cercare di capire o, meglio, per colmare il fossato tra «coeur e raison, tra intuizione e conoscenza oggettiva, tra fede antica e ragione moderna. Un bisogno (che ogni giorno ancora mi incalza) di indagare sulle tracce del Dio che, stando alla fede, assumendo volto e carne d’uomo, si è rivelato e al contempo celato».
Quell’estate del 1965
Dieci anni a partire da “quell’estate”, l’estate del 1965, quando accadde il fatto che avrebbe cambiato per sempre la vita di un giovane laureando in scienze politiche, cresciuto nella fucìna del laicismo di matrice agnostica quale era la Torino dei suoi maestri Norberto Bobbio e Galante Garrone, e che a tutto pensava tranne che di mestiere avrebbe fatto l’apologeta. Invece, in quell’estate in cui Messori stava lavorando alla tesi di laurea, «l’improbabile, l’inatteso avvenne». “Cosa” in particolare avvenne, a dire il vero Messori non l’ha mai rivelato in dettaglio, neanche nel suo libro più autobiografico (Perché credo, ndr). Le ragioni risiedono, da un lato, nell’educazione ricevuta, in particolare nella reticenza a parlare di sé che nell’austera Torino in cui crebbe era giudicato a dir poco disdicevole; ma c’è anche un altro motivo, più profondo, e che ha a che fare con la dinamica di certi “incontri ravvicinati” di cui parla la letteratura mistica: il fatto cioè – confermato da lui stesso durante un incontro la scorsa estate nella splendida Abbazia dì Maguzzano – che non è facile spiegare l’inspiegabile.
«Non so cosa sia accaduto»
«Io stesso – ci disse Messori – non so cosa sia accaduto». Quel che è certo è che aprendo per caso i Vangeli cercando una citazione per la tesi, quel Gesù che fino ad allora era il personaggio principale di una storia il cui valore si esauriva tutt’al più a livello letterario o poetico, gli si manifestò con una forza dirompente. «Sperimentai – dice l’Autore – lo choc di un incontro-scontro (senza alcuna mediazione ecclesiale che ne attutisse l’impatto violento) con la figura misteriosa di Colui che si presentava, ed era creduto da tanti, come il Figlio di Dio, come Dio egli stesso. Scoprivo quelle antiche parole e strabiliavo, forse esultavo come se in esse avessi scoperto la chiave per gli interrogativi non solo dell’uomo (la politica, la vita sociale, l’economia), ma sull’uomo: il significato del vivere e del morire, del gioire e del patire. Alla ricerca, come ogni giovane, della Verità, questa mi dava appuntamento proprio là dove non l’attendevo né la cercavo».
«Mi hai sedotto»
Un’esperienza simile a quella di un altro convertito famoso, anch’egli giornalista e scrittore, Andrè Frossard. Esperienze ben riassunte dagli straordinari versetti iniziali della vocazione di Geremia: «Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre; mi hai fatto violenza e hai prevalso» (Ger 20,7). Ipotesi su Gesù nacque così. Non è stato un libro “a tavolino”, bensì il frutto di un lavoro innescato da un fatto sconvolgente che «avvenne per una serie di esperienze personali cui non fu estraneo il dolore, con la sua capacità di costringere al confronto con le domande ultime».
I Vangeli dicono il vero?
La genesi di Ipotesi su Gesù spiega anche un’ulteriore particolarità di Vittorio Messori. Il fatto cioè che a differenza di altri convertiti, che hanno scoperto Cristo al termine di un percorso fatto di esperienze, spesso dolorose, riflessione, studio, ecc., nel suo caso è accaduto il contrario: prima c’è stato l’incontro-scontro, come lui lo chiama, con Gesù, e solo dopo l’inizio di un cammino, tuttora in corso, per comprendere e spiegare le ragioni della fede. A partire dalla domanda delle domande, quella che da sempre riecheggia nel cuore di ogni uomo e che è alla base di Ipotesi di Gesù: i Vangeli dicono il vero o raccontano solo storielle edificanti senza alcun fondamento storico? Domanda tanto più attuale oggi, vista e considerata – stando all’omiletica che piace alla gente che piace e più in generale ai temi che sembrano stare in cima all’agenda pastorale – la quasi scomparsa di Gesù dai radar del discorso pubblico ecclesiale (per tacere di quello politico e sociale, dove la fede è stata di fatto relegata negli angusti anfratti della coscienza), se non quando si tratta di predicare l’accoglienza dei migranti e l’attenzione ai poveri, spesso e volentieri riducendo il Vangelo ad una caricatura di se stesso.
Prima la fede, poi le opere
Insomma Gesù è diventato un argomento tabù come per altro già nel 1976 Messori aveva acutamente intravisto aprendo il libro con questa frase che non lascia scampo a equivoci: «Di Gesù non si parla tra persone educate». Ma c’è anche un altro motivo che rende attuale, e anzi direi urgente, un libro come Ipotesi di Gesù; ed è il fatto che sempre più spesso in ambito ecclesiale si tende a privilegiare l’azione, la prassi, insomma le opere rispetto alla fede. Come se, dando questa per scontata, ci si dovesse concentrare sull’agire, sul darsi da fare per sanare le storture e i mali della società. Tanto più che – questo il ragionamento sotteso, che dimostra quanto sia penetrata in profondità la teoria cara all’esegesi protestante che vuole un “Gesù della storia” distinto e separato dal “Cristo della fede” – ai fini pratici che il Vangelo abbia o no un fondamento storico conta fino a un certo punto. Intendiamoci. La fede senza le opere è morta, dice san Giacomo. Vero. Ma nel giusto ordine. Prima la fede, poi le opere. Anche perché, tolta la fede, e soprattutto tolta una fede senza il suo fondamento, del cristianesimo non resta che una melassa filantropica di cui il mondo può farne tranquillamente a meno. Ecco perché è importante (ri)partire dai fondamentali, tutto il resto viene dopo.













