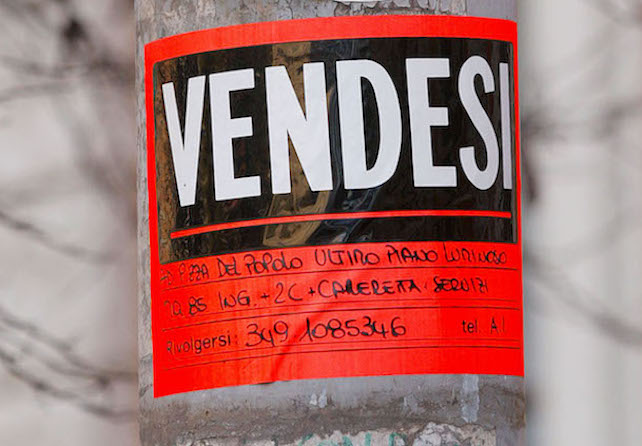
Articolo tratto dal numero di Tempi in edicola (vai alla pagina degli abbonamenti) – C’è da pensare, a essere buoni, che non ci conoscano. Che ragionino dell’Italia come fosse la Danimarca, o chissà quale altro paese. Altrimenti, l’invito che la Commissione europea ha rivolto al governo di Roma, nelle sue consuete raccomandazioni di primavera, sarebbe difficile da spiegare: «Reintroducete l’Imu sulla prima casa per i proprietari con i redditi più elevati», il consiglio non richiesto di Bruxelles. A pagina 9 del documento, quando cioè la Commissione elenca i provvedimenti a essa graditi, gli eurotecnici spiegano che un fisco che colpisce la proprietà immobiliare, e quindi in teoria le rendite, sia da preferire a uno che si concentri sul lavoro e i mezzi di produzione. Insomma, meglio l’Imu dell’Irap per evitare effetti depressivi. «Ma sono considerazioni basate su studi vecchi, che arrivano dall’Ocse, secondo cui elaborare un mix fiscale – prelevo un po’ più qui e un po’ meno lì – sia una ricetta per condizionare l’economia. La verità è che a contare è solo il prelievo fiscale complessivo», spiegava qualche giorno fa, ospite a Tgcom24, Riccardo Puglisi, docente di Economia politica all’Università di Pavia e collaboratore de lavoce.info. E se a contare è soltanto il prelievo complessivo, è facile capire come l’imposizione sugli immobili – prime, seconde o terze case poco importa – abbia in sé, in un paese come l’Italia, un effetto fortemente condizionante per l’intera economia.
Dicono i dati di Confedilizia, l’associazione della grande proprietà immobiliare, che dal 2012 in avanti – cioè dall’arrivo a Palazzo Chigi del governo Monti – le tasse sugli immobili sono cresciute di circa 15 miliardi di euro, anche tenendo conto della successiva abolizione dell’Imu sulle prime case. Un salasso sul mattone i cui risultati – giura il presidente dell’organizzazione, Giorgio Spaziani Testa – sono sotto gli occhi di tutti. Il fatto è che ai governi tassare la casa risulta particolarmente facile: gli immobili, lo dice la parola stessa, al contrario dei capitali non possono spostarsi, e quindi colpirli con sempre nuovi balzelli è un gioco da ragazzi. È così che, con la scusa della crisi e dei conti da far quadrare, la casa si è rapidamente trasformata nel bancomat del fisco.
Il ritornello è stato più o meno sempre lo stesso: meglio gli immobili del lavoro. Ma questo forse sarebbe vero in un paese diverso dal nostro, dove quasi l’80 per cento della popolazione è proprietaria dell’abitazione principale, un dato nemmeno paragonabile a quello di paesi come Germania, Francia o Regno Unito, dove il tasso di proprietari supera di non molto il 50 per cento. Tassare la casa in Italia – e tassarla così tanto di più in così poco tempo – ha avuto un effetto inequivocabile, peggiorato dalla crisi economica che (causa perdita del lavoro) ha costretto molti a disfarsi dell’abitazione per liberarsi del mutuo: il crollo del mercato immobiliare. Dal 2008, denuncia Confedilizia, i dati periodici messi insieme da Abi e Agenzia delle Entrate sulle compravendite fotografano impietosamente la situazione: nel 2016 il numero delle compravendite è stato del 25 per cento circa inferiore a quello del 2008, ultimo anno prima della grande crisi. E se la tendenza, ultimamente, è per un leggero recupero (complici i tassi ai minimi storici per i mutui), la verità è che la prospettiva di tornare ai livelli precrisi è niente più di un miraggio.
Il collasso del mercato immobiliare è facile da spiegare: la tassazione sugli immobili ha portato chiunque potesse a mettere sul mercato le case in eccedenza, per disfarsene. La conseguenza, per eccessiva offerta, è stato un abbassamento sostanziale dei prezzi. Che però, come è ovvio, ha colpito indiscriminatamente prime e seconde case. Il risultato è quello che si può intuire: i proprietari della sola prima casa – che sull’acquisto hanno magari fondato le loro sicurezze per il futuro – ora si sentono, e in effetti lo sono, più poveri. Ma se una famiglia diventa più povera – a spiegarlo sul Corriere della Sera qualche settimana fa è stato proprio l’economista Puglisi – «avrà meno voglia di spendere perché si sente meno sicura dal punto di vista delle ricchezze totali di cui può disporre vendendo pezzi di questa ricchezza, oppure facendosi prestare i soldi grazie a questa garanzia (caso tipico: il mutuo ipotecario)».
Pure i “non performing loans”
E qui arriviamo al vero tasto dolente. Perché in quella stessa paginetta redatta dai tecnici di Bruxelles e illustrata in conferenza stampa dal commissario Pierre Moscovici, c’è un’altra raccomandazione per l’Italia: ridurre lo stock di “non performing loans” (npl), cioè di crediti deteriorati, in pancia alle banche. Tradotto: quei prestiti che gli istituti in passato hanno concesso e che ora non riescono a farsi restituire. Ma quei crediti altro non sono, per una parte molto rilevante (proprio perché in Italia la proprietà immobiliare è così diffusa), che mutui su prime case e non solo.
Insomma: con una mano l’Europa chiede più tasse sulle case, per ripianare i conti pubblici senza (secondo loro) compromettere la ripresa. Con l’altra chiede che le banche affrontino il problema dei crediti deteriorati, cioè dei mutui non pagati. In altre parole: quella della Commissione, più che una medicina, sembra un “farmakon”, per usare il greco classico, cioè un veleno che potrebbe rivelarsi letale per l’economia italiana. Più tasse sugli immobili porterebbero a una ennesima contrazione del mercato delle compravendite, e questo avrebbe come conseguenza una ulteriore discesa dei prezzi. Ma se i prezzi scendono, le ipoteche sulle case su cui le banche hanno concesso mutui perdono valore, e i bilanci degli istituti traballano ancora di più.
Molto rischio per pochi euro
Senza contare che l’indicazione di Bruxelles è piuttosto bizzarra: si suggerisce l’introduzione dell’Imu sulla prima casa, ma solo “per i redditi alti”. A parte l’ambiguità della formula e il fatto che le prime case dei più ricchi (ville e castelli) sono già tassate, ci sarebbe da fare due conti: nel 2012, anno di picco della tassazione sugli immobili, il gettito dell’Imu sulla prima casa fu di circa 4 miliardi di euro. Ora, è difficile pensare che questi “redditi alti” possano superare il 25 per cento del campione dei proprietari di prime case. Insomma: il gettito presunto di questa nuova Imu – ipotesi, va detto, respinta dal ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan – non potrebbe mai superare il miliardo. Relativamente pochi soldi, per un effetto negativo sul mercato da non sottovalutare.
E se il governo sembra orientato a resistere, almeno stavolta, alle sirene della Commissione, chissà se farà altrettanto anche con l’altra raccomandazione: la riforma del catasto. Per ora la discussione sembra rinviata, almeno fino al prossimo ammanco nelle casse pubbliche. Una cosa, però, è certa: con la variazione dei valori, la tentazione di una revisione al rialzo (per tutti e non solo per i più ricchi) sarà pressoché irresistibile, per lo Stato e per gli enti locali. E mentre le ipotesi corrono, e il tassametro del debito pubblico gira, il mattone sarà sempre là: fermo, pronto per essere tartassato.
Foto Ansa














