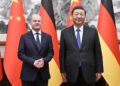Dopo un anno siamo punto e a capo nella lotta contro il coronavirus e la pandemia di Covid-19: ricoveri nelle terapie intensive oltre il livello di allarme, Italia di fatto di nuovo in lockdown, scuole chiuse, incubo recessione. In attesa che i vaccini dimostrino la loro efficacia, dopo dodici mesi di sacrifici tutto questo sembra la certificazione di un colossale, costosissimo fallimento.
E così riemergono inesorabili anche le stesse identiche domande di un anno fa: ma dove abbiamo sbagliato? Avremmo dovuto adottare il modello cinese? O il giapponese? Meglio ancora Taiwan e Corea del Sud? E l’Australia, come ha fatto l’Australia a sbarazzarsi del coronavirus? La verità, racconta una lunga, notevolissima inchiesta di David Wallace-Wells per il magazine New York, è che non sappiamo davvero “Perché l’Occidente ha perso contro il Covid”, come recita il titolo del servizio.
Troppi fattori che sfuggono
Possiamo solo ipotizzare che cosa ha funzionato e cosa no, nella reazione alla pandemia messa in campo da Europa e Stati Uniti, ma la verità è che tanti, troppi fattori determinanti per la diffusione del virus risultano tuttora insondabili, o comunque fuori dal controllo della nostra avanzatissima scienza e tecnologia medica. Emblematico in questo senso il misterioso caso dell’India – per fare un esempio di cui Tempi si è occupato recentemente –, un paese che sembra avere abbattuto i contagi senza fare praticamente nulla. E che per altro proprio in questi giorni torna a registrare numeri allarmanti altrettanto inspiegabilmente.
La scienza non fa miracoli
Vale la pena dunque riproporre qui qualche passaggio dell’articolo di New York. Non, ovviamente, per diffondere scetticismo rispetto a qualunque misura contro il Covid. È tutto utile quel che si fa con ragioni. Lo ripete più volte lo stesso David Wallace-Wells nel suo pezzo. Semplicemente, quello che emerge bene dall’inchiesta del magazine americano è che la scienza non ha tutte le risposte che pretendiamo sul coronavirus, e non può averle, nemmeno un anno dopo l’esplosione della pandemia. E se non può averle la scienza, figuriamoci la politica. Allo Stato e ai medici al massimo possiamo chiedere vaccini, non miracoli.
I misteri della pandemia
Scrive Wallace-Wells:
«Negli Stati Uniti, la storia dell’anno della pandemia è stata dominata dalla personalità del presidente che se n’è occupato con tale inettitudine, spesso con una indifferenza tale da sembrare che tifasse per la malattia. Ma il problema di addossare a Donald Trump tutta, o quasi tutta, la colpa delle sofferenze americane è che il fallimento del paese non è un caso unico. In effetti, fino all’arrivo dei vaccini, l’America non ha avuto del coronavirus un’esperienza eccezionale, bensì tipica – quanto meno tra le nazioni europee tipicamente considerate sue pari. E da che il nuovo anno ha portato una nuova amministrazione, esperti di vari ambiti, dalla salute pubblica all’economia, hanno iniziato a riconoscere con sempre maggior certezza come la catastrofe fosse molto più vasta e profonda del negazionista-in-capo, e molto più “normale” di quanto gli americani avessero compreso.
La misura dei decessi pro capite è rozza, e oscura i problemi della demografia e della comorbidità, ma da questo punto di vista di base gli Stati Uniti hanno sofferto meno di Regno Unito, Portogallo e Repubblica Ceca, situandosi nello stesso gruppo di altre nazioni europee – Italia, Spagna, Francia – attorno alla media Ue. La media sudamericana invece è appena inferiore. Nessuno di questi paesi, a parte il Brasile, si ritrova presidenti o primi ministri che abbiano impietosamente negato la minaccia della malattia come Trump, o che abbiano tentato di sopprimere i tamponi, o tenuto comizi elettorali al chiuso durante una recrudescenza locale. “Questo tuttavia non vuol dire che se ci fosse stato un altro presidente noi non avremmo avuto difficoltà”, mi ha detto Natalie Dea, una biostatistica della University of Florida.
Francois Balloux, epidemiologo delle malattie infettive e genetista computazionale allo University College of London, si spinge oltre. “Non c’è evidenza che misure diverse adottate in posti diversi abbiano chiaramente portato a risultati diversi”, dice. “C’è molta idiosincrasia, e io penso che sia semplicistico sostenere che i paesi che hanno tenuto sotto controllo o eliminato il virus abbiano fatto le cose in modo molto diverso. Se si mettono in fila, per esempio, gli interventi realizzati in paesi come la Nuova Zelanda o l’Australia, questi non sono drasticamente diversi, per rigidità e per durata, da quelli di altri posti. Lo stato che ha avuto il lockdown più stringente e più lungo al mondo è il Perù, e si è ritrovato assolutamente devastato. Il messaggio un po’ deprimente secondo me”, dice Balloux con un sospiro, “è che non esiste un semplice pacchetto di misure che garantiscano il successo e che possano essere applicate in qualunque posto del mondo”.
Non è questo il modo in cui la malattia è stata guardata dalla maggior parte dei liberal americani, che tendevano a vedere il Covid come una inequivocabile sfida gestionale, nell’ambito della quale la pandemia poteva essere “risolta” attraverso misure dettate dalla scienza e una coscienziosa diligenza. Una prospettiva che ha impresso alla pandemia i tratti di un “morality play” in cui le questioni del distanziamento sociale e della mascherina diventano prove di virtù personale determinanti per il corso della malattia. Ma l’indignazione locale non è un fenomeno esclusivamente angloamericano. “Prendete la stampa nazionale di qualunque paese, che sia la Germania, la Svizzera o la Francia. Leggerete che dappertutto si ha la percezione che la propria situazione sia la peggiore”, dice Balloux. […]
Anche all’interno dell’America il coronavirus non si è mosso secondo una logica esattamente determinista. Il tasso di mortalità più alto, per esempio, non si registra in Texas ma nel New Jersey. Durante la devastante ondata d’autunno, un sondaggio ha rilevato che il 90 per cento degli adulti americani stava usando la mascherina “talvolta, spesso o sempre”. I contatti ravvicinati negli stati con pesanti restrizioni non erano significativamente più alti che negli stati lassisti, e anche i lockdown draconiani hanno prodotto, tipicamente, appiattimenti o leggere inflessioni delle curve epidemiche, non ripide discese verso lo zero. Ci sono, all’interno degli Stati Uniti, alcuni casi di relativo successo: notevole quello delle Hawaii che quasi non hanno registrato morti in eccesso. Ma i tassi di mortalità in Florida, uno degli stati più orgogliosamente lassisti, superano a malapena quelli della California, uno di più autolesionisticamente rigidi.
Niente di tutto ciò rappresenta una particolare sorpresa per gli epidemiologi, che hanno speso intere carriere a sguazzare nell’incertezza virale. Mentre a noi altri sconcertati resta la domanda: come può essere? “Ho ripetuto questa domanda, per tipo due mesi, in pratica a tutti gli esperti che conosco in California”, dice Soumya Karlamangla, la cronista del Los Angeles Times più immersa nella pandemia della California meridionale, che ha ossessivamente tentato di spiegare il paradossale contrasto con la Florida. “Domandavo e domandavo ancora. E quel che mi sentivo ripetere da questi esperti era sorprendente per me: non lo sanno. Semplicemente, non hanno spiegazioni valide”. Io ho fatto per molti versi la stessa esperienza. Quando ho domandato Shane Crotty, virologo del Jolla Institute for Immunology di San Diego, se avesse un’idea del motivo per cui l’ondata peggiore dell’autunno in tutto il paese si fosse abbattuta sulla California meridionale, un posto che tradizionalmente non ha un autunno, in sintesi la sua risposta è stata: “No, non ce l’ho”.
Questo non per dire che le misure e i comportamenti non contino, ma solo che arginare una nuova malattia che non comprendiamo del tutto non è facile come pigiare il pulsante “Scienza”. Le misure di contenimento su cui si è basato principalmente il paese (mascherine, distanziamento sociale, scuole chiuse, restrizioni ai ristoranti) sono mitigatori di curve, non muri antincendio. E molti dei fattori che hanno un ruolo ben più ampio nella diffusione della pandemia entrano assai meno facilmente nello zainetto del tecnocrate o nelle prediche moraliste dei progressisti.
Eccone un elenco parziale: c’è la stocastica, meglio nota come caso, guidata in parte da dinamiche di superdiffusione, per via delle quali la stragrande maggioranza dei nuovi casi è prodotta da una piccola fetta di infezioni esistenti e gran parte delle catene di trasmissione semplicemente si estingue da sé. C’è la demografia, che determina una distorsione della mortalità così marcata che molti dei paesi più giovani del mondo non hanno quasi registrato vittime. C’è la distribuzione delle comorbidità fra la popolazione. C’è la geografia, con le isole che beneficiano di ovvi vantaggi e con le comunità alle latitudini più elevate che sembrano più esposte a rischi, forse per via dell’effetto salubre della luce del sole. C’è il rapporto di ciascun paese con i propri confini, e chi sono i suoi vicini, e la sua posizione nelle reti dei trasporti e del commercio. C’è il clima, con la temperatura e soprattutto l’umidità che a quanto pare determinano i risultati nazionali tanto quanto hanno determinato certi ritmi stagionali della malattia all’interno dei paesi. C’è l’aria condizionata: se si usa e di che tipo è. C’è quello che Crotty descrive come una versione dell’“ipotesi igiene”, ossia la possibilità che un’esposizione regolare ai patogeni tenga il allenamento il sistema immunitario come il microbioma intestinale. C’è il gran calderone dei fattori culturali, che contiene di tutto, dalla convivenza multigenerazionale e dalle strutture dell’impiego fino ai baci sulle guance e alle strette di mano.
Potrei proseguire: la densità abitativa, i gruppi sanguinei, la vitamina D, la capacità delle terapie intensive, la vicinanza ai pipistrelli. Ogni volta però che si prova a puntare il dito su un singolo fattore dominante, la malattia scivola via, sconfiggendo i modelli riduttivi e suscitando argomenti e fatti contrastanti: il Giappone è anziano, il Brasile è in gran parte tropicale, l’Inghil terra è un’isola e in Francia l’aria condizionata esiste a malapena. E oltre a tutti questi fattori, con i relativi impatti di dimensione ignota, c’è quello che il controverso epidemiologo di Stanford John Ioannides ha recentemente chiamato “caos” della malattia: la dinamica di diffusione apparentemente casuale e tuttora misteriosa, perfino più della stocastica, la quale quanto meno può essere modellata matematicamente.
Il recente crollo del numero di casi in America, per esempio, è arrivato subito dopo il nuovo anno, in mezzo a quella che era stata paventata al paese – dagli epidemiologi e dal nuovo presidente, nel discorso inaugurale – come probabilmente la stagione più buia della pandemia. Guardando indietro, si trovano poche voci solitarie che indicavano che l’inverno sarebbe stato più tranquillo dell’autunno. Ma i Cdc [Centers for Disease Control and Prevention, ndt] esibiscono 26 modelli certificati in grado di predire il corso della malattia nel breve termine. Il 18 gennaio, soltanto due dei 26 mostravano il marcato calo di casi registrato dal paese nel cosiddetto intervallo di confidenza del 95 per cento. In altre parole, 24 dei 26 modelli dicevano che quello che è finito per accadere nelle due settimane successive era, più o meno, statisticamente impossibile. Gli altri due gli davano per lo meno un pezzetto di possibilità».
Le tre macroregioni
Per provare a paragonare senza disperarsi l’efficacia dei diversi modelli di risposta al coronavirus, insiste Wallace-Wells, si può dividere il mondo in macroregioni.
«In Europa, Nord America e Sud America: fallimento quasi universale. Nell’Africa subsahariana e in Asia meridionale: numerosi casi e bassi tassi di mortalità, molto per merito della struttura di età della popolazione. Nell’Asia orientale, nel Sud-Est asiatico e in Oceania: successo indiscutibile».
Tuttavia anche questa suddivisione è messa in crisi da troppi fenomeni senza spiegazione apparente. Per esempio l’enorme “fortuna” che ha contraddistinto il Canada rispetto agli Stati Uniti, in termini di contagi e morti. Oppure gli ottimi risultati ottenuti da Nuova Zelanda e Australia con due approcci alla pandemia in pratica agli antipodi uno dell’altro.
Nuova Zelanda e Australia “trumpiana”
La nuova Zelanda, ricorda New York, vanta un tasso di mortalità da Covid di 5 per ogni milione di abitanti. Quello della Germania è di 900 morti per milione di abitanti, quello degli Stati Uniti è di 1.600. Ma certo, verrebbe da dire, la Nuova Zelanda è piccola, è un’isola, ha dovuto affrontare il coronavirus d’estate e lo ha fatto in maniera spietata e con un leader credibile. Tutto vero, conferma Wallace-Wells, eppure…
«La vicina Australia è una nazione molto più vasta, con un sistema mediatico divisivo dominato da Rupert Murdoch e un leader alla Trump o quanto meno alla Boris Johnson. Ha grandi aeroporti e un sacco di aria condizionata. Ci si aspetterebbe dall’Australia un andazzo simile a quello degli Stati Uniti o del Regno Unito, invece il suo tasso di mortalità è al di sotto di 36 vittime per milione di abitanti, meno di un cinquantesimo del tasso americano».
E pensare che qui in Europa la serie A giocava senza curve e a Sanremo si cantava senza pubblico, mentre laggiù la gente «si è ammassata agli Australian Open, come avrete visto».
L’elemento umano
Ci sono molti altri spunti di riflessione interessanti nell’articolo del magazine newyorkese. Per esempio la sottolineatura che non bisogna mai farla troppo facile quando c’è di mezzo l’uomo. Perché l’uomo si muove con motivazioni ultimamente insondabili per la scienza, e perciò non è così facile fargli cambiare idea con le regole e con le prediche.
Osserva sempre l’epidemiologo Balloux:
«Il problema è che si ha a che fare con gli esseri umani. Ai quali potrebbe piacere fare certe cose; potrebbero dire che fanno certe cose e potrebbero farne altre. Io penso che le persone forse si sarebbero comportate meglio se ci fosse stata una reale sensazione che fosse davvero utile. Ma credo che una gran parte della popolazione in Europa avvertisse che non era davvero possibile eliminare il virus a livello locale. E io dico: giustamente».
La paralisi dei governi
Altro spunto notevole l’inchiesta di Wallace-Wells lo offre a proposito della sottomissione della politica alla scienza e alle sue (presunte) sicurezze. Un tema parecchio dibattuto anche in Italia, soprattutto durante il primo lockdown, quando sembrava che il governo Conte avesse di fatto lasciato le redini del paese in mano al famigerato Comitato tecnico-scientifico. Lo stesso è accaduto in misura maggiore o minore in tutti i paesi dell’Occidente, ricorda il giornalista di New York, e proprio da questo discende l’impasse di molti governi davanti all’emergenza.
A differenza dei paesi europei e degli Stati Uniti, spiega alla rivista Michael Mina, epidemiologo di Harvard, in Asia orientale i governi, benché molto più poveri e disorganizzati dei nostri, hanno avuto il merito di non attendere le indicazione dell’Oms per rischiare (sì, rischiare) di prendere contromisure al contagio. Non hanno preteso di avere «tutti i dati» prima di agire, osserva Mina. Qui invece «i decisori si sono paralizzati. Hanno preferito non agire e lasciare che la pandemia avanzasse, piuttosto che agire in modo aggressivo ma potenzialmente sbagliato».
Mina paragona, per metterle in contrasto, l’attuale emergenza drammatica a quella ben più tragica della Seconda Guerra mondiale:
«Soprattutto in un paese come gli Stati Uniti, ma anche in altri paesi europei, da lungo tempo non siamo più abituati a essere a disagio. Mi ricordo di aver detto a febbraio o marzo 2020: “Non penso che gli Stati Uniti se la passeranno bene stavolta”, per la sola ragione che non siamo nemmeno capaci di sapere e di riconoscere che ci sta capitando qualcosa di male. Abbiamo continuato a pensare che quel qualcosa di male non stesse capitando a noi, e che di certo avremmo risolto tutto nel giro di un mese. E finché manca solo un mese alla soluzione, non esiste l’urgenza. Io credo che questo sia sintomo di una società che non ha dovuto fare i conti con le avversità per un periodo davvero lungo. Siamo a disagio nel prendere le dure decisioni che devono essere prese».
Un rischio “minuscolo”
Infine, un simpatico promemoria conclusivo sull’atteggiamento dell'”establishment” di fronte al pericolo. Tutto il mondo è paese, verrebbe da dire pensando ai giorni di “Milano non si ferma”.
Sempre tratto dall’articolo di David Wallace-Wells per New York:
«L’11 febbraio Anthony Fauci, Nancy Messonnier e Ron Klain erano sul palco di una conferenza dell’Aspen Institute sul nuovo coronavirus condotta dalla giornalista superstar dell’infettivologia Helen Branswell. Molte volte Fauci ripeté di essere convinto che il virus rappresentasse un basso rischio – successivamente spiegherà come fosse importate comunicare al pubblico che era a basso rischio, anche per proteggere la propria credibilità e la credibilità dell’establishment della salute pubblica. “Ancora oggi non capisco perché”, ha scritto recentemente la Branswell. Pochi giorni dopo la conferenza, Fauci descrisse il rischio del coronavirus per gli americani come “minuscolo”. […] Il 15 febbraio disse in un’intervista che l’influenza rappresentava una minaccia superiore per gli americani. Per un altro mese ha continuato a consigliare di non usare mascherine».
Non solo Fauci. Il governatore democratico di New York, Andrew Cuomo, faceva lo stesso in quei giorni perché, come ha ammesso lui stesso recentemente, «la mia prima preoccupazione era il panico».
«Per tutto l’inverno, l’orientamento dell’establishment sanitario americano è stato chiaro, proiettato al pubblico attraverso commenti ed editoriali come quello del New York Times che avvertiva “attenzione al panico da pandemia” e quello del Washington Post che sosteneva “dovremmo diffidare di una risposta aggressiva al coronavirus da parte del governo”. Altri titoli di quel periodo: “Dovremmo ridimensionare la guerra al coronavirus”, da Wired; “Il coronavirus fa paura, ma l’influenza è più letale e più diffusa”, da Usa Today; “L’influenza è una minaccia molto più grave per la gente negli Stati Uniti del coronavirus di Wuhan”, da Business Insider. Prima che i paragoni con l’influenza diventassero un luogo comune della destra negazionista, erano le rassicurazioni della sinistra di establishment».
Foto di Edwin Hooper per Unsplash