
Articolo tratto dal numero di Tempi di gennaio. Dello stesso viaggio di Tempi in Veneto fa parte anche l’intervista a Luca Zaia disponibile online per gli abbonati da mercoledì 6 febbraio («Dateci l’autonomia e solleveremo l’Italia»).
Cosa ci faccio qui? Come ci sono finito in questa terra di agricoltori e letterati, di sindaci sceriffi e storici dell’arte, di ubertose colline a vigneto e cemento a presa rapida; in questa geografia dei paradossi che sposa fatturato e poesia, schei e arte, fede e blasfemia, teatro e impresa? Perché il Veneto? E perché proprio io? Un po’ di antefatto è d’uopo. Nell’estate del 2017, colto da improvvisa febbre zingaresca, mi mettevo in testa di andarmene un po’ a zonzo per l’Italia. Col senno di poi dirò che l’intento era in fondo quello di riscoprire questo paese amato e bistrattato. Avevo scelto il Veneto intanto perché da dove mi trovo (la Bassa Romagna) è praticamente dietro l’angolo. E pur essendo vicino, al tempo stesso mi pareva un altro mondo, sconosciuto e fantastico; fatate creature di mistero i veneti e le venete, dal modo di parlare a quello di mangiare. E bere.
Ho scelto il Veneto anche per gli scrittori, ai quali il mio ritrovato patriottismo deve molto. Autori come Goffredo Parise, Andrea Zanzotto, Giovanni Comisso, Guido Piovene; tutti esibiscono profonde radici in questa terra. Il loro amore per il Veneto mi ha contagiato. A Piovene va una menzione speciale: negli anni Cinquanta lo scrittore vicentino attraversò la nazione per una serie di reportage finanziati dalla Rai che poi andarono a comporre il suo celebre Viaggio in Italia – ripubblicato da Bompiani proprio nel 2017, guarda il caso. Un documento che rimane ancora oggi insostituibile per intelligenza, rigore, approfondimento, completezza. Un libro il cui nome oggi fa quasi da parola d’ordine per una strana carboneria segreta, un’insospettata società di esplorazioni del nostro paese. Leggendo il Viaggio in Italia mi sono chiesto come colmare lo iato che ci separa; come raccontare la trasformazione antropologica che ha cambiato il volto della nazione, e su cui già molti intellettuali hanno messo il dito.
Il Veneto dunque, va bene. Ma quale Veneto? Ogni provincia qui conserva gelosamente la propria specificità. È l’impronta della secolare, gloriosa storia della Serenissima repubblica di Venezia; l’orgoglio e la coscienza della quale scorrono forti nelle vene di molti ancora oggi. La Serenissima ha praticato una politica di decentramento, riconoscendo a ogni città il proprio statuto di convivenza e consentendo alle élite politiche locali di prosperare. E così oggi Verona, Padova, Treviso, Vicenza, Belluno conservano ciascuna il proprio patrimonio culturale, artistico, architettonico ed urbanistico. Mi sono lasciato guidare dall’impalpabile rete delle coincidenze. Nervesa della Battaglia (Tv) sta tra il fiume Piave e il Montello; siamo nei luoghi in cui si è svolta la Battaglia del Solstizio, dove il fronte italiano si è riposizionato dopo Caporetto, e da qui è iniziata la riscossa. «Nel buio della notte Italia splende» sta scritto nel Sacrario Militare del Montello. Qui nel giugno del ’18 fu abbattuto il maggiore Francesco Baracca, eroe dell’aviazione e mio concittadino. Mentre il Paese intero commemorava questi avvenimenti, un’altra, più tecnologica Rete lavorava per me. Grazie a Facebook conosco l’amico Luca Rossetto, coltivatore e vinificatore, titolare dell’azienda agricola Rossetto di Arcade (Tv). L’azienda di Rossetto è anche vivaio di relazioni; ogni anno a fine vendemmia vi si tiene la benedizione del vino, come una volta, con la presenza del parroco di Arcade, di amici e clienti, e la festa di anno in anno ospita conferenze, concerti, esposizioni.
MODELLO DEL PAESAGGIO ITALIANO
Il mio viaggio in Italia è partito dal Veneto; il viaggio nel Veneto è iniziato nel cuore della Marca Trevigiana, “Marca gioiosa et amorosa”, che annovera tra il Montello e i colli di Asolo «uno dei grandi “modelli” del paesaggio italiano» (Piovene); e che ha in Treviso un capoluogo grazioso nel vero senso della parola, di una bellezza discreta e non imponente: che non si impone. La mia prima impressione di Treviso – dei suoi canali, dei ponti, delle porte, delle piazze – è di un’allegra comunione: vi metto piede nell’ora sacra dell’aperitivo, quando tutta la città esce da case e uffici per il rito dello spritz. Non sembra, come altrove, un’usanza classista o giovanilista; abbraccia tutte le classi sociali e tutte le età. Mi sento davvero per un poco nel Veneto di Piovene, «…regione [che] porta dentro un amore di sé… una felicità nel suo pittoresco, una delizia nel fare teatro di sé e della propria condizione… un gusto della sfumatura e non dei contrasti nettii». O nella Treviso di Comisso: «Ve ne sono [di osterie, ndr] a ogni angolo […], e rivelano un gusto a volere convivere e affratellarsi». I veneti amano presentare al mondo un volto pacifico e autoindulgente, riassunto nel motto locale che è No vao a combatar, non mi metto a combattere, a litigare. Sarò capitato qui per caso ma ho la sensazione di trovarmi nel posto giusto.
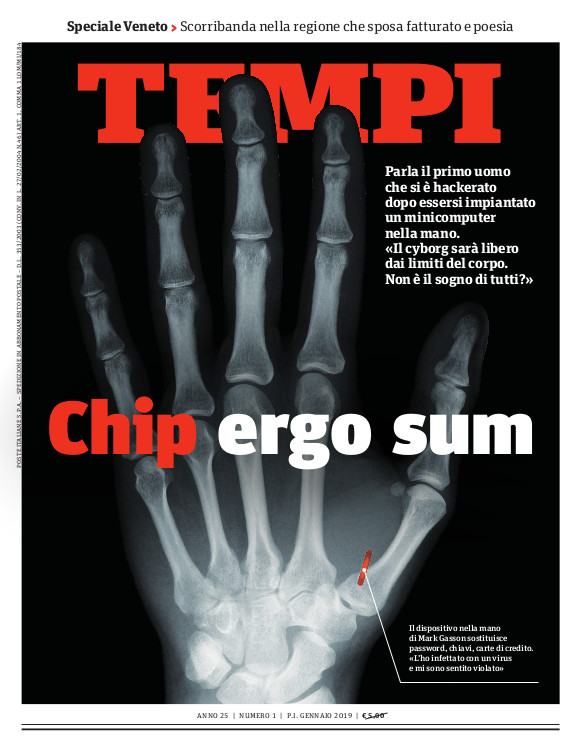
Ritorno alla Marca a novembre, col preciso obiettivo di scoprire e raccontare il Veneto. Ho chiesto a Luca di presentarmi alcuni amici. La sera del mio arrivo incontriamo Ferruccio Mazzariol, motore dell’editrice trevisana Santi Quaranta – nome e marchio richiamano una delle due stupende porte della città. Il mazzariol, mi spiega Luca, è una specie di folletto burlone del folklore veneto. L’energia del colto gentiluomo trevisano, classe 1939, sembra davvero avere del soprannaturale. Ci accoglie nella sua libreria e monopolizza da subito la conversazione. Trent’anni di attività editoriale, un catalogo che sa distillare il meglio della scrittura regionale, ma guarda anche all’Europa, vantando opere di Vàclav Havel, Robert Louis Stevenson, Emmanuel Mounier; una rete di distribuzione costruita personalmente macinando chilometri su chilometri, con punti vendita anche nelle osterie. «Io sono il tipo di editore che va a vendere libri alla sagra della polenta» dice, e racconta ridendo di aver vinto il Premio Chiara nel 1995 con La Grande e la piccola guerra del grande critico Elio Gioanola, soffiandolo sotto il naso ad Adelphi, e di aver poi venduto copie del libro al ricevimento di premiazione, tra lo sconcerto dei grandi editori: «Il problema del nostro tempo è il divorzio tra cultura intellettuale e cultura manuale». Questo giudizio su cultura e lavoro mi sembra molto importante per capire dove mi trovo. Sviato dai pregiudizi immaginavo un Veneto provinciale sgobbone e concreto, tendenzialmente chiuso su se stesso; respiro invece aria europea.
Ci spostiamo per la cena nella vicina Trattoria dei Due Mori dove Mazzariol, di casa e carismatico, riserva un cerimoniale baciamano asburgico a tutte le cameriere, e io cerco di riportare il discorso sulla dimensione locale. «Il carattere della nostra gente è fiero, indipendente. Le radici cattoliche sono profonde. Il fascismo e il comunismo qui sono passati come acqua sul marmo. Mio zio Piero faceva il casolìn (droghiere, bottegaio, ndr) e ai fascisti diceva “A casa mia il padrone sono io; rispondo solo al parroco, che risponde al Papa”».
L’ABITUDINE ALLA BESTEMMIA
Davanti a polenta, soppressa, risotto col radicchio e un bicchiere di torbolìn (vino novello) si ragiona meglio. È evidente che la libertà dei veneti poggia sul loro forte senso della proprietà; reso possibile a sua volta dalla diffusione della piccola proprietà agricola, e poi della piccola impresa. Penso anche alla mia Romagna, dove le aree della Bassa, sfruttate a latifondo e popolate di braccianti, sono sempre state le più vulnerabili al radicalismo anarchico, repubblicano, comunista. Confido a Luca le mie riflessioni: la piccola proprietà richiede piccolo credito, cooperazione. «Sai che uno dei primi promotori delle leghe contadine “bianche” era di Arcade? Giuseppe Corazzin, detto Bepi. Sindacalista e deputato del Partito popolare; morto a 35 anni per le conseguenze di un’aggressione fascista». Ho ancora molto da imparare della storia d’Italia. Ma oggi? Il boom economico, il benessere, la secolarizzazione come hanno inciso su queste comunità? I toni di Mazzariol si tingono di preoccupazione: «I veneti sono un popolo orgoglioso, ma c’è in loro una fragilità che il tempo ha messo a nudo. L’abitudine alla bestemmia, ad esempio: svela un complesso di inferiorità per una religiosità tante volte subita. Una debolezza non estranea ai problemi di oggi. Eppure anche la Lega odierna, con tutto il suo opportunismo, esprime un istinto conservatore, un desiderio di salvare le cose buone, che va riconosciuto. La Cei non dovrebbe osteggiarla!».
Si capisce che il Veneto, forse più di altre parti d’Italia, reca le ferite visibili del mutamento. Un certo sfruttamento del territorio, l’individualismo, lo sradicamento, la perdita del sacro. Come orientarsi in questo paesaggio cambiato senza perdere la via? Il folletto delle buone occasioni deve avermi preso a benvolere: il giorno stesso Paolo Malaguti presenta a Treviso il suo nuovo libro. Vado con Luca, che lo conosce. Malaguti, classe ’79, padovano oggi residente ad Asolo, ha esordito per Santi Quaranta; quest’ultimo libro per Marsilio si intitola Lungo la Pedemontana. In giro lento tra storia, paesaggio veneto e fantasie, e pare scritto apposta per me. L’autore ha percorso in bicicletta il tracciato del “cantiere più grande d’Italia”, quello della Superstrada Pedemontana Veneta, convinto che «raccontare il mutamento del paesaggio, della società, della lingua, è e sarà raccontare il Veneto stesso». Già la presentazione dà spunto alle controversie, tra nostalgici di un rapporto idilliaco col paesaggio e aggressivi fautori dello sviluppo.
Dopo l’evento cerco di agganciare l’autore per una visita ad Asolo, ma devo accontentarmi di un colloquio telefonico. Lo invito su un terreno che gli è congeniale; la letteratura veneta. Piovene, Zanzotto, Meneghello: come si spiega questa messe di talenti così profondamente connotati dal rapporto con la terra, col paesaggio? «È un rapporto figlio della specificità anche economica del Veneto. Su una realtà già di per sé diversificata non è intervenuta l’industrializzazione precoce che osserviamo in Piemonte, in Lombardia; così che fino ai primi anni Settanta per un intellettuale veneto è stato possibile vivere la provincia in modo fecondo. Da questo provincialismo profondo, dalla dimensione dell’oratorio, dal binomio prete-e-osteria siamo usciti di recente, attraverso un’accelerazione più brusca, violenta. Nella mitologia di paese di mia madre era ancora presente l’immagine della famiglia che fino a vent’anni fa mangiava pane e mortadella e adesso ha la villa fatta “con le scarpe”».
NEL PROFONDO DELL’INDOLE
Si intuisce che il fantasma della povertà dice tante cose di questa fuga dal passato. E il dialetto? Qui si sente ovunque, è realtà viva, continuità con la tradizione; ma per Paolo come per molti altri è una riscoperta dell’età adulta: «Fino agli anni Novanta il dialetto veneto è stato a rischio di estinzione; era associato alla povertà, ci si vergognava a parlarlo in società. Oggi c’è un ritorno al dialetto come riscoperta delle radici». Visto che si parla di radici accenno al tema delicato dell’indipendentismo veneto: come lo giudica? «Io sono d’accordo con Piovene, per il quale “la civiltà del Veneto è piuttosto sentimentale, che significa appagamento e delizia in se stessi […] e perciò scarsa inclinazione a mutare[…]”. I “Serenissimi”, i movimenti degli anni Novanta erano una mascherata; ma in fondo le mascherate sono il residuo di una teatralità profonda dell’indole veneta, più che progetti politici».
Alla fine del colloquio viro verso lo snodo critico del discorso. Nel libro Malaguti racconta di una grande infrastruttura il cui impatto sul paesaggio non potrà essere ignorato; ma, dice, è solo l’ultimo di una serie di interventi che rientrano in un atteggiamento di riduzione del territorio a economia. Mi rimanda ai dati dell’Ispra: il Veneto è la terza regione per consumo di suolo annuale. Il presente è davvero così grigio? È possibile vivere questa nuova dimensione territoriale al di là di una pur legittima nostalgia o di progetti di decrescita più o meno felice? «Il problema non è che il territorio sia a livello 10 o 100 di destrutturazione; ma che chi lo abita faccia un lavoro di conoscenza storica su quello che è accaduto». Paolo è anche insegnante. Ricorda gli ex studenti che ad anni di distanza lo hanno sorpreso con le proprie scelte di vita organiche al territorio. Hanno compiuto un proprio percorso di conoscenza. La speranza, il futuro creano i propri spazi attraverso le nuove generazioni.
AFFRANCARSI DALLA SCHIAVITÙ
La mia ricerca non si conclude col viaggio nella Marca. Parlo ancora con tre persone: un imprenditore, una scrittrice e un educatore. Roberto Brazzale è un battagliero imprenditore caseario di Asiago; del suo lavoro e delle lotte a tutela delle dipendenti Tempi ha già parlato. Accoglie con entusiasmo la richiesta di raccontarmi il suo Veneto, e nelle sue parole si sente tutta la fierezza dell’identità: «Noi siamo un vero popolo, una nazione che ha una lingua, una tradizione. C’è stato un tentativo di occultare questa realtà, ma fino a qualche generazione fa nell’altipiano di Asiago era riconoscibilissimo il ceppo cimbro, celtico, germanico. Io sono indipendentista: l’autonomia sbandierata dalla Lega è inutile, bisogna liberare i popoli. Ma guardi i dati: al referendum ha partecipato un 60 per cento; il 95 per cento ha votato sì. E doveva vedere le votazioni: composte, silenziose. Questo è un vero movimento dal basso, e le dirò di più: se domani ci fosse il referendum per l’indipendenza, vincerebbero i sì».
Che ruolo gioca la fatica dei ceti produttivi in lotta con lo Stato? «Qui – prosegue Brazzale – un intero sistema bancario è stato fatto fallire: di fronte a questo fatto di una gravità inaudita chi fa impresa e tira avanti è un eroe che vuole solo affrancarsi dalla schiavitù. Lo Stato italiano è parassitario». Ma non è possibile un’idea di nazione dove ognuno sia ricchezza per l’altro? E cosa risponde a chi nell’autonomia vede un atto d’egoismo del Nord? «Quello che noi proponiamo è nell’interesse di tutti, perché responsabilizza tutti. Oggi bisogna ripensare realtà statuali a misura adeguata. L’Italia nazione non è altro che ideologia risorgimentale, basta sentimentalismi, bisogna guardare ai fatti».
Parlo con Antonia Arslan. L’autrice, padovana di origini armene, è nota per i romanzi sulla storia e sul genocidio del suo popolo, ma non sente di meno l’appartenenza veneta: «Venezia è sempre stata porta dell’Oriente, ed è luogo di adozione per la nazione armena. Gli armeni hanno fatto da mediatori tra veneziani e turchi, e poi c’è San Lazzaro degli Armeni, l’isola che la Repubblica ha donato in perpetuo alla congregazione fondata dall’abate Mekhitar di Sebaste. Il Veneto continua a guardare a est, alla Russia, anche per le relazioni commerciali». Penso al mio amico Rossetto; sotto i suoi vigneti corrono due ingombranti gasdotti provenienti proprio dalla Russia. Gli interessi russi non sono lontani.
CULTURA CATTOLICA E CULTURA LAICA
«I mille anni di dominazione della Serenissima – mi dice ancora Arslan – sono entrati nella coscienza profonda della gente, che passa anche per la lingua; e la nostra è una lingua a tutti gli effetti, come il napoletano. Entrambe hanno la dignità della corte. Il Veneto ha risentito molto dell’annessione all’Italia. La tassa sul macinato, la coscrizione obbligatoria… C’era un rapporto straordinario tra la nobiltà, il popolo e la terra, che si è rotto all’inizio del Novecento: quando questa gente ha oltrepassato la soglia della povertà è iniziata l’emigrazione. La percezione della povertà aiuta a capire gli ultimi vent’anni; la micro-imprenditoria, l’edilizia selvaggia… Si può biasimare chi desidera star meglio?». E i frutti positivi dello sviluppo? «Ci sono: la presa di coscienza, il miglioramento delle condizioni di vita. L’indole profonda non è mutata, non abbiamo abbandonato la forte vocazione alla solidarietà che ci avvicina alla Lombardia». La religiosità? «È una certezza. Anche la forte presenza dell’editoria cattolica, sia nella linea della scrittura veneta sia nei periodici diocesani, che un po’ ovunque hanno ancora lettori… Naturalmente l’aggressività della cultura laica miete vittime, c’è chi si vergogna». La gentile professoressa è tanto disponibile da spingermi ad arrischiare un’intuizione personale: secondo lei il veneto è pragmatico, oppure gli piace recitare la parte del pragmatico? «Ah, certamente ama il teatro! Non bisogna mai credergli immediatamente. Non dimentichiamo i nostri paesi, così scenografici, da Schio a Montagnana a Marostica. Dove c’è una piazza, c’è un teatro».
STRANGOLATI DALLE TASSE
Questa conferma della teatralità dei veneti è anche la testimonianza di un robusto filo che tiene insieme l’Italia, da Venezia a Napoli, altra patria della sceneggiata. Felice di averlo trovato, ormai convinto di questa segreta affinità tra veneti e napoletani che voglio portare alla luce, mi appresto a mettere il punto a questa tessitura. Federico Pendin dirige la cooperativa Dieffe a Noventa Padovana, con quattro centri di formazione e un istituto alberghiero paritario. Mi aiuterà a ricucire i temi della cultura e del lavoro, del senso degli affari e del senso della vita: «Siamo nati nell’85. Padre Egidio Gelain dava lezioni serali di impianti elettrici a quelli che trovava davanti ai cancelli delle fabbriche a Marghera; poi gli preparava la cena, così è nata l’idea della ristorazione. Abbiamo seguito quello che ci chiedeva la realtà; non siamo più intelligenti, al massimo lavoriamo di più». La formazione professionale è in situazione critica: da un lato ha enormi potenzialità, dall’altro è vista come ripiego. Anche in Veneto? «La mia generazione è cresciuta sentendosi dire: vai a studiare perché faticherai di meno e guadagnerai di più. Il genitore cercherà sempre di togliere la fatica al figlio. Bisogna ripartire dall’educazione, dall’idea che la fatica è un dono. Sono venuti da noi due laureati in ingegneria a imparare a fare la birra. Sa qual è stata la cosa più difficile? Spiegarlo ai genitori». Mi sembra che ci sia un’idea che ritorna: «Noi creiamo un percorso culturale e lo abbiniamo al lavoro. Cultura e lavoro introducono entrambi alla realtà». Restiamo sulla specificità veneta: dietro al lavoro c’è anche l’ansia di promozione sociale? «Il Veneto ha 600 mila piccole imprese. È un dato imponente, c’è un’operosità diffusa, una cultura del fare da sé. Nell’azienda piccola il dipendente tende a collaborare col padrone. C’è un aspetto fondamentale da capire: l’imprenditore veneto è uno che non rischia solo il capitale, rischia tutto se stesso. Per questo a volte chi fallisce si toglie la vita: è l’orgoglio. Facendo consulenza mi è capitata un’azienda di 18 dipendenti che avrebbe dovuto chiudere, il padrone non aveva cuore di dirlo. Ha convocato tutti e ha spiegato la situazione, avevano gli occhi lucidi, hanno rinunciato al tfr per andare avanti». E l’autonomia? «Non è che i veneti vogliano l’autonomia: questi imprenditori sono strangolati dalle tasse, tutto qui. Il Sud è una risorsa strepitosa. Quando il veneto e il napoletano si mettono a lavorare insieme non c’è problema».
Saluto temporaneamente questa terra con un bottino di osservazioni, alcune piste promettenti che conducono altrove, e un pugno di domande che spero mi portino più vicino al cuore della vicenda “Italia”. È possibile un’esperienza che tenga insieme bellezza e produttività, mestiere e gusto del vivere? Esistono modelli antichi o nuovi di sviluppo organico? Qual è la distanza giusta che salvaguarda le diversità e consente loro di arricchirsi reciprocamente? Dove ritrovare il senso del futuro in un paese con un passato tanto ingombrante? Per un po’, il Veneto è stato la lente attraverso la quale ho visto l’Italia con maggiore chiarezza. Il viaggio continua.














