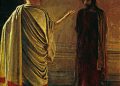Questo articolo di Mauro Grimoldi, tratto dal numero di Tempi in edicola, fa parte della serie “Ragione Verità Amicizia”, il manifesto dei nostri vent’anni e della Fondazione Tempi (una proposta che si può sottoscrivere in questa pagina).
Rileggo, per ragioni di studio, una raccolta poetica di Franco Fortini uscita trent’anni fa, Paesaggio con serpente. Mi resta addosso un verso:
«Lavoratori di Mosca ottantamila
la storia ha un modo di ridere che è ripugnante».
È tratto da un testo che rievoca, trentacinque anni dopo, gli anni del liceo, le ore trascorse a mendicare amore a un orto di rose osservato dal banco e le parole che Brecht dedicava agli operai nel giorno, il 27 aprile 1935, dell’inaugurazione della metropolitana, tutta fatica loro, della capitale sovietica.
Sono versi amari, rancorosi a tratti («più ilare che triste, più ansioso che sazio, più indistruttibile… mi avvio veloce verso il mio rancore»), privi di idillio, come qualcuno giustamente ha fatto osservare. Basti questo amletico lacerto a darne efficace testimonianza:
«Questo puoi, ora questo: dormire.
Pia dai secoli dei secoli una ignota
ti rimbocchi la coperta, la fronte ostinata ti tocchi,
porga la buonanotte, spenga la lampada, esca.
Prega che in vece sua non venga innanzi
il cranio assorto dell’insonnia
che non parla ma guarda».
Credo abbia ragione Emanuele Zinato (Letteratura come storiografia?) a spiegarne il motivo: «L’individuo (per Fortini, ndr) non è che un luogo biologico attraversato, nella sua labile durata, dalle forze storico sociali, e il “dente della storia” morde e recide non meno di quello della natura».
«Qualcosa mi è stato detto
che debbo ricordare meglio: che
quanto di me si consuma sarà cibo e bevanda di molti».
(La promessa)
Paesaggio con serpente raccoglie testi che coprono un arco temporale che va dal principio degli anni Settanta ai primi anni Ottanta del secolo scorso. Chi ha vissuto quel periodo, chi, come me, lì è stato svezzato, può orientarsi tra questi versi fino a riconoscersi. La vita (muscoli, ossa, nervi, materia cerebrale) trovava una direzione sensata dedicandosi alla trasformazione delle cose, al cambiamento del contesto sociale, alla lotta di liberazione dai condizionamenti economici e culturali imposti dal Potere (clericale, fascista, capitalista, imperialista). Intelligenza, lavoro, studio, affetti persino, erano orientati a questo, da questo significati e nobilitati.
Fu necessaria una lotta per non cedere al rifiuto del fascino cristiano, quando esso si presentò a tanti che lo credevano estinto per sempre, pretenzioso, irritante, ma vivo, straordinariamente persuasivo, invincibilmente umano e ragionevole.
Ancor più, tutto questo, perché aveva (e ancora ha) la sostanza di un Corpo, di una compagine umana, familiare nella sua rilevanza carnale, impregnata di materia. «Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue…».
E ora?
La prendo da lontano.
L’ipotesi e il dato
Zachar Pavlovic, detto “tre ottavi filettato”, uno dei personaggi del grande romanzo di Andrej Platonov, Cevengur, amava le macchine più di ogni altra cosa al mondo: aveva riempito la sua abitazione di bulloni, rubinetti, vecchie valvole, oggetti metallici di ogni tipo. «Osservando la fiamma viva Zachar Pavlovic viveva lui stesso: la testa pensava, il cuore sentiva e tutto il corpo si placava dolcemente. Rispettava il carbone, il ferro in barre, ogni materia prima dormiente e ogni semilavorato, ma amava e sentiva veramente solo il prodotto finito – il frutto della trasformazione per mezzo del lavoro e che continua a vivere di vita autonoma».
Nelle pause del pranzo contemplava la locomotiva, non le staccava gli occhi di dosso. Le ruote anteriori della macchina lo indussero a interessarsi dello spazio: ce n’era abbastanza per permettere a esse di percorrerlo? La prospettiva di un limite lo spaventava, come il pensiero dell’infinito: «Se l’infinito esistesse davvero, si dissolverebbe da solo nel grande spazio e non ci sarebbe nulla di solido… Ma come sarebbe a dire l’infinito? Deve pur esserci un binario morto!».
Quanto ai limiti del cosmo la faccenda poteva essere risolta: «Dopotutto anche lo spazio si poteva scaldare e allungare come il ferro a nastro».
Tutto questo riguarda il mondo di cento anni fa, gli esordi del sogno sovietico, ingoiato poi nel ripugnante «ridere» della storia, le ambizioni degli uomini di ferro e dell’industria pesante. Oggi la tecnica ha imboccato i sentieri impalpabili della leggerezza, secondo gli auspici americani di Italo Calvino. Non la pesantezza dell’hardware, ma l’agilità felina del software.
Fino ai droni, alle connessioni autistiche col mondo, alle illusioni di guerre meccaniche e pulite, alla risoluzione definitiva del problema della morte. Fino a considerare l’uomo stesso come un manufatto, manipolabile in forza del nobile fine di espungere ogni impurità per renderlo perfetto, biologicamente sano; e insieme socialmente, moralmente, finanche religiosamente, sano. Per dirla con termini in voga da tempo e giunti oggi a lambire nuovi vertici ideologici, il dato viene sostituito dall’ipotesi.
 Un errore di mistica
Un errore di mistica
La sostanza umana, un tempo mero luogo biologico, giunge oggi a smaterializzarsi, gli stessi rapporti umani, compresi quelli più intimi, vengono gestiti in una sorta di telemetria digitale e i fatti, divenuti labili postille, non giungono a scalfire, se non entro brevi e volubili intermittenze emotive, i nostri fiochi spiriti erranti, intenti ad elevarsi sopra la coltre impura della materia inferiore.
Si respira, persino tra amici, un’aria rarefatta, piena di pudore e cautela, preoccupata di non sbagliare; si deve innanzitutto riflettere, pensarci su, non giungendo mai ad una risoluzione decisa, a forza di esaminare, centellinandoli all’infinito, i rischi (ma esiste pensiero, parola, opera umana esente dal rischio?). Ci si rifugia nel locus amoenus dell’omissione, come se questa non fosse un peccato, il più grave, forse, di questo tempo. Tutti, in fin dei conti, cullati nel tepore infantile di chi si crede nel giusto, con l’aria innocente che intende rassicurare tutti: io non c’entro niente (De André) con gli sbagli dei padri, dei fratelli e persino dei figli. Fino a perderli i padri, i fratelli, i figli.
Alla fine, come cantava il molto egregio signor Rossi (anche lui, un bravo ragazzo, perfettamente allineato),
ci troveremo come le star
a bere del whisky al roxy bar
oppure non c’incontreremo mai
ognuno a rincorrere i suoi guai
ognuno col suo viaggio
ognuno diverso
e ognuno in fondo perso
dentro i cazzi suoi.
Anche la barca di Pietro, che procede sicura verso il porto, non può evitare i marosi del tempo, che vogliono sballottarla di qua e di là, come sapeva bene Péguy, quando indicava le due tentazioni che La riguardano: «Navighiamo certamente tra due bande di curati: i curati laici che negano l’eterno del temporale ed i curati ecclesiastici che negano il temporale dell’eterno».
Una delle ultime mattutine meditazioni di papa Francesco ci aiuta a comprendere quello che ancora Péguy indicava come un errore di mistica («Infinitamente grave. Vicinissimo al cuore, il più vicino possibile al cuore del cristianesimo»), ricordando che «una delle prime eresie nel cristianesimo è stata quella del pensiero gnostico», che vedeva un «Dio, lontano e non c’era concretezza». Non a caso «l’apostolo Giovanni la condanna bene: “Questi non credono che il Verbo si è fatto carne”». (L’Osservatore Romano, venerdì 8 maggio 2015).