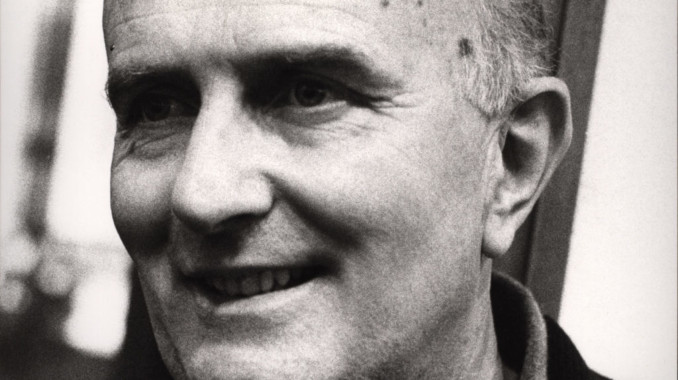
Vi proponiamo la lettura di un articolo di Giovanni Testori, “Marco si è ucciso. Quale amore cercava?”, pubblicato dal Sabato il 20 gennaio 1979. Marco Riva, redattore ventunenne del Quotidiano dei lavoratori, giornale dell’estrema sinistra milanese, si era tolto la vita l’8 gennaio, lasciando una lettera per i suoi famigliari.
***
«Non vi chiedo perdono per quello che ho fatto. È stata una decisione meditata, una scelta precisa. La scelta dell’unica alternativa che mi restava ad una vita fatta ormai solo di angoscia e dolore. È troppo tardi, adesso, domandarsi perché. E sinceramente non mi sento di dare spiegazioni a nessuno. Quello che veramente mi rattrista è di avervi coinvolto direttamente in una scelta profondamente individuale e della quale, però, adesso anche voi pagate le conseguenze. Posso solo immaginare cosa significherà per voi ed è per questo che, se non è possibile la comprensione, vi chiedo almeno il rispetto per una scelta personale. Credo che ognuno abbia diritto di disporre della propria vita.
Esistono situazioni nelle quali è preferibile morire piuttosto che continuare con una esistenza che, a volte, può trasformarsi in un vero e proprio inferno. Io mi sono trovato a scontrarmi con una realtà troppo grande e troppo diversa dalla mia e ho deciso di non voler tirare avanti una situazione veramente insostenibile e senza alcuna prospettiva (e credo proprio sia stata quest’ultima verità a farmi decidere).
Una cosa sola non voglio: essere giudicato. Nessuna persona che non abbia conosciuto fino in fondo la mia realtà o che non abbia vissuto almeno per un istante una situazione simile alla mia ne ha alcun diritto. Le sentenze e i giudizi lasciateli agli ipocriti e agli stupidi. Avrei tanto voluto vivere, amare, essere amato. Non è stato il rifiuto della vita, ma l’impossibilità di vivere, di vivere la mia vita, la mia realtà, a farmi scegliere la morte.
Mi spiace darvi questo colpo, ma non ce la facevo veramente più. Al mio funerale vorrei tanta musica, e poi, vorrei essere cremato. “Avevo vent’anni e non permetterò a nessuno di dire che questa è l’età più bella della vita”. Mi piacerebbe che questa frase (di Paul Nizan) fosse posta sulla mia tomba.
Non piangete e pensate che questo è stato molto meglio di quello che avrebbe potuto offrirmi questa vita. Marco».
Non è a ciò che molti chiameranno il tuo non esistere, il tuo non esserci più, non è, insomma, alla tua assenza, che vorrei parlare; né solamente alla tua anima che è stata già ricevuta da Chi, in assoluto, da sempre e per sempre, è l’essenza stessa dell’amore, quell’amore che così disperatamente hai cercato di ricevere e di dare nei giorni faticosi e atroci della tua esistenza, essendo, appunto, origine e somma dell’amore, di tutto l’amore che è possibile all’universo. Egli t’ha capito e giudicato secondo un metro d’intelligenza e di carità del quale noi, per magnanimi che ci sforziamo d’essere, non riusciremo mai a sfiorare le dimensioni e, soprattutto, la capacità di contenere insieme giustizia e pietà, inflessibilità e comprensione. Lui, di te, ha conosciuto e conosce tutto; e l’ha conosciuto e lo conosce per sempre. Mentre noi possiamo solo procedere per tratti; e, anche su quelli, con cautela e, in ogni caso, malamente.
È a te come te, Marco, che vorrei parlare; alla tua presenza che continua nella nostra storia di uomini; al tuo essere stato giovane… Fatico troppo a scrivere accanto al tuo nome la parola che designa la tua morte. L’ho già lasciata cadere sul foglio tre volte e tre volte l’ho cancellata. È una parola, quella, che mi dà sempre un’immensa pena fermare dentro uno scritto, soprattutto quando venga riferita a un essere preciso; preciso e irripetibile; come sei stato tu; come lo sei ancora. Ogni volta è come se, in quella parola, avvertissi qualcosa di troppo definente e, insieme, troppo indefinito; quasi che la realtà che essa intende significare si trovasse altrove e non si potesse chiudere nelle lettere di cui è composta. Forse basterebbe scrivere che non hai più voluto vivere; tutto sembrerebbe allora meno improprio e, appunto, ti lascerebbe ancora, come pure sei qui, in mezzo alla vita.
È terribile, non solo per te, ma per tutti gli uomini, che le nostre società non riescano più a conservare in mezzo a loro i loro morti! L’aver allontanato dalla vita la sua sacra ragione e, dunque, la sua teologia (e la connessa liturgia), si paga anche così. Come si paga nell’incapacità di eleggere quanti pur lo sono stati alla dignità e all’esempio di martiri.
Lo pensavo in occasione delle recenti polemiche apertesi sugli stermini compiuti dal nazismo; per notare, appunto, l’incapacità che la cultura, considerata nel senso più lato, ha avuto di riconoscere quei morti come tali e di dar loro la forma e la figura di martiri. Anche la poesia, anche l’arte sono state in grado di dar forma e figura agli assassini; al male; non ai santi; non al bene. Non, ecco, all’amore; essendo che l’amore, in primissima istanza, è proprio e solo bene; è, anzi, il bene. Così mi domando se gran parte della cultura moderna sia veramente stata critica e giudice nei confronti del male o se, col gesto di colpirlo, non abbia alle volte trovato un modo sinistro e lucido, per diventarne complice. Non sto allontanandomi da te. Sto cercando d’avvicinarmi per strade che non violino il silenzio che tu hai chiesto; o che non lo violino troppo. Che rispettino, comunque, i tuoi anni verdi, pieni d’una speranza che hai voluto chiudere (o che non t’è stato permesso d’aprire) con la lucida e caparbia fermezza di parole dure; parole che sono una condanna al mondo e, appunto, alla cultura che ti ha lasciato e forse t’ha indotto a metterti, quelle parole, sulle labbra, nel cuore e, poi, su d’un foglio.
«Credo che ognuno abbia il diritto di disporre della propria vita» – hai scritto, deciso e insieme innocente, crudele e insieme smarrito. Da quest’affermazione consegue l’altra che, consegnata alla tua famiglia, potrebbe sembrare solo un taglio, una ferita: «Non vi chiedo perdono per quello che ho fatto».
C’è un grande bisogno di dignità in queste tue ultime parole dette a noi da vivo; ma, senza che quel bisogno e quella dignità vengano minimamente toccati, lette da noi ora che tu le hai volute rendere gesto e azione, avviano il dubbio che quel tuo bisogno e quella tua dignità siano stati innanzitutto innocenza; innocenza e tensione verso un assoluto, non importa quale, che attorno ti veniva negato; forse deriso; forse schernito; mentre tu, forse, venivi schernito e deriso in lui.
Terribile innocenza, terribile tensione, se t’hanno portato alla morte; ma pur sempre innocenza e tensione. In verità, quello che tu hai fatto e, nello stesso tempo, il modo del tuo permanere qui, con l’essere stesso della vita, apre una domanda proprio sul rapporto tra liceità di disporre della propria vita e liceità di condurre quella disponibilità fino alla negazione della vita medesima; fino alla sua distruzione.
Quando tu pronunci un’affermazione simile, domandi che qualcuno l’ascolti: se non già che l’accolga. Domandi un “altro”. Chiedi, insomma, se non l’aiuto, certo il soccorso della testimonianza ricevuta. Dunque, stabilisci una relazione.
Pronunciate nel vuoto, nel nulla, che senso avrebbero quelle parole; che senso, la tua libertà; e quale, il gesto che ne hai dedotto?
Parole, libertà e gesto acquistano senso proprio perché davanti a te c’era un “altro”, perché “l’altro” l’hai voluto; l’hai chiamato in causa, Marco; uomo o donna; padre o madre; società o comune; amico o amica. Ma, a questo punto, ti chiedo: “l’altro” era solo davanti a te o non era anche e prima dentro di te, dentro la vertigine e l’abisso del tuo essere?
Se questa seconda ipotesi fosse vera, se per un momento tu potessi concedermi che era, che è vera, capisci come il vuoto da me prima ipotizzato all’uomo non sia possibile, ove pur si trovasse a nascere solo e attorno a lui non esistesse veramente nessun altro uomo. “L’altro” infatti sarebbe dentro, sigillato in lui dal momento del suo concepimento. Ma quest’“altro” che esiste nell’uomo prima che l’uomo abbia avuto la possibilità di pronunciare una qualunque parola, cos’è se non, appunto, la Parola stessa, lo stesso Verbo? Cos’è se non la determinazione e la volontà di Dio?
La tua sfida, terribile e innocente, Marco, l’hai rivolta alla Parola, al Verbo, a Dio, prima che agli uomini; o a loro, in seconda istanza; e, comunque, proprio e solo perché l’hai rivolta a Lui; quel Lui che continua ad essere presente anche nella seconda istanza perché Egli è anche la seconda istanza.
Ma quando nella parola che si pronuncia esiste un “altro”, supponiamo pure e solo un altro uomo, quando con quella parola si stabilisce una relazione, il diritto non genera da sé un dovere?
Ora il diritto, è ben chiaro, resta. Non è per il fatto che, di sua natura, genera un dovere che esso decade. Ma non è neppure perché un diritto viene esercitato che decade il dovere che gli è correlato. Il rapporto è interno; proprio come il rapporto di cui discutevamo prima è interno al fatto di parlare. Ora è proprio questa relazione che, accettata o non accettata, si pone come centro dell’immagine umana, a impedirti di non esistere più. Sei esistito, tra diritto e dovere; esisterai per sempre; anche qui, sulla terra.
Se da questo dato in cui non ti muovi più come responsabilità diretta (poiché morendo le responsabilità cessano anche se ne proseguono le conseguenze), ma in cui continui a esistere e a vibrare come creazione, passiamo al fulcro nel quale hai coagulato e fulminato il tuo esistere tra diritto affermato e dovere rifiutato, adesso lo vedi anche tu, Marco, come quel fulcro si sia incistato, impossibile incendio di sole e di fuoco, nella realtà e nel nome, anzi nel bisogno della realtà e del nome dell’amore.
E qui tutto di te, tutto della tua vita, che non conosco e che pochissimi forse han conosciuto davvero fino in fondo, torna a dichiararsi religioso, anche se d’una religiosità negata; più che da te, che pure quella negazione hai tanto declamato, da una cultura che quella negazione t’ha indotto o costretto a scegliere quale unica possibilità d’esistere nel presente. Ma tu, senza ricorrere ad alcun paradosso, sei l’esempio doloroso e straziato che la storia non si spiega con la storia; proprio come sei l’esempio che il diritto non si spiega con se stesso, ma col dovere.
Da questo punto in avanti, le ragioni, tutte le ragioni sono dalla tua parte di giovane non riconosciuto, di giovane non possibilitato a essere se stesso, di giovane dilaniato, sacrificato, alterato e offeso. Ed è colpa nostra, colpa della società che abbiamo costruito sulla «cosa» (cioè a dire sulle ceneri dell’uomo), se le tue ragioni non han potuto restar tali, ma si sono trasformate in diminuzione e in torto, se è diminuzione e torto prendersi il diritto d’uccidersi. Che società è quella che cambia in tal modo le carte nelle mani, nelle coscienze, nei cervelli e nei cuori della sua giovinezza? Che diritti può avanzare se non ha riconosciuto e non riconosce i suoi primi doveri?
Dentro questa società, la responsabilità di noi cristiani è certo ancor più grande di quella degli altri uomini; e così lo è di fronte a te; di fronte alla tua morte. Poiché, oltre ai doveri che hanno tutti gli uomini, ai cristiani spetta un di più: il di più che deriva dalla coscienza dell’Incarnazione; il di più che deriva dalla croce e dal sangue che ne discende. Un di più che è d’amore.
Dunque se l’amore tu non hai potuto né riceverlo, né darlo, la colpa maggiore è di chi, nella società, dell’amore avrebbe dovuto essere la sorgente più piena. È a questo punto che mi chiedo se noi cristiani abbiamo veramente imparato che le nostre prime parole, da non pronunciarsi mai, è ben chiaro, disgiunte dai fatti o, peggio, in loro sostituzione, devono essere le preghiere; cioè a dire le parole che tornano alla Parola; i pensieri che tornano al Pensiero.
Abbiamo pregato e preghiamo per te e per chi come te soffriva e soffre del non-amore che è dilagato nel mondo? Abbiamo pregato e preghiamo, non confondendo i singoli esseri in una sola anonima gestione, ma riconoscendoli uno per uno nella loro irripetibile individualità, nell’irripetibile forma che Dio ha loro dato? Abbiamo pregato e preghiamo per chi, come te, è stato ed è tentato dal diritto che si stacca dal dovere; per chi come te è stato ed è tentato dalla morte che nasce da quel distacco?
Insomma, l’Altro, l’Altro che tu hai inconsciamente chiamato in causa nelle tue ultime parole, l’Altro che è l’Amore, l’abbiamo chiamato in causa e in aiuto, noi, con le nostre suppliche, per te, per la tua vita, come pure avremmo dovuto?














