
Il senso della vita e della morte secondo Violante

Bisogna giungere a pag. 95 dell’ultimo libro di Luciano Violante per comprendere il significato del titolo: Ti ho sempre salvato, Bollati Boringhieri. Esso fa riferimento a due eventi decisivi della sua vita e del rapporto con sua madre.
Il primo è al momento della sua nascita, nel 1941, quando la signora, detenuta in un campo di prigionia insieme al marito a Dire Daua in Etiopia, decise, malgrado le terribili condizioni di vita, di non abortire. Il secondo è durante la guerra quando, per raggiungere la Puglia e salvare lei e suo figlio, probabilmente offrì il suo corpo, «pagando il prezzo che in quelle circostanze paga una giovane donna».
Questi ricordi, unitamente a quelli delle morti della nonna nel 1946, dello zio Nino e della moglie Giulia nel 2023, chiudono un libro che è una lunga riflessione, ma anche un’approfondita analisi, sul tema della morte.
Il libro si presenta a prima vista come un saggio, ma più ci si addentra nel contenuto più si percepisce nettamente l’approccio personale dell’autore. Alla conclusione della lettura si comprende come Violante abbia affrontato il tema non da un punto di vista meramente scientifico, ma per l’esperienza che della morte ha fatto nella sua vita.
Se la vita ha un senso
Il fil rouge che lega i sei capitoli è il suo grande amore e rispetto per la vita e il rifiuto di una certa concezione “moderna” della morte.
A pagina 14 Violante scrive: «Respingiamo la realtà della morte, perché ci rifiutiamo di riflettere sulla realtà della vita». E poco avanti: «Nel dibattito pubblico discutiamo su come garantire il diritto ad una morte degna, ma non ci interroghiamo su come garantire il diritto alla vita degna». E a pag. 51: «Vita e morte sono due aspetti della stessa umanità; c’è conseguentemente un rapporto tra il mancato rispetto per la morte e il mancato rispetto per la vita, tra l’assenza di una teoria della morte e l’assenza di una teoria della vita. Dobbiamo riprendere a parlare rispettosamente del senso della vita per parlare rispettosamente del senso della morte«. Non a caso il primo capitolo è intitolato: «Se la vita ha un senso».
In esso si affrontano tutte le sfaccettature etiche e sociologiche della morte, a partire dalla domanda fondamentale: cosa c’è oltre la morte? Nelle pagine finali del testo l’autore si definisce così: «Io sono credente, anche se finora privo di religione», ma ciò non gli impedisce di affermare l’importanza della speranza. A pagina 52 scrive: «Il primato della vita è strettamente legato al principio della speranza, che a sua volta anima la fiducia nell’impegno e nel miglioramento futuro. Aiuta a vivere e a non essere passivi, magari dandosi obiettivi, piccoli o grandi, e impegnarsi a raggiungerli». E prosegue con grande realismo: «Non è facile nutrire speranza nel tempo che stiamo vivendo. L’orizzonte dell’umanità sembra ostruito».
Guerra e pace
Il libro è ricco di citazioni della mitologia e della letteratura antica sulla morte, di racconti sul ricordo dei morti in molte civiltà, anche moderne, di riferimenti filmografici, come quello molto bello sul film L’arpa birmana.
Più di un capitolo è dedicato alla fonte primaria della morte, la guerra con una gran mole di citazioni di dati e di vicende, spesso poco note all’opinione pubblica, che dovrebbero indurre tutti a lottare per la pace piuttosto che per la guerra. A tal proposito dice: «Chi, ad esempio, decide di risolvere una tensione internazionale attraverso la guerra, decide per la prevalenza della morte; chi si impegna per una trattativa, invece, fa prevalere il valore della vita, anche se questo è un argomento che non viene mai messo in piena luce» (pag. 70).
Né meno dure sono le sue parole sulle morti per causa delle migrazioni. «I fuggitivi – dice – sono gli indesiderabili del XXI secolo». Violante non si limita a snocciolare cifre, ma fa un’acuta disamina dei provvedimenti assunti da vari governi per i respingimenti al di fuori dei confini nazionali.
Potrebbero dirlo tutte le madri
Altrettanto duro è il suo giudizio sull’eutanasia e su forme similari che si stanno diffondendo in vari Stati, fino ad elencare e spiegare i giochi sulla morte per adolescenti sempre più in rapida diffusione.
Interessante e utile anche la rilettura postuma dei tre casi italiani di eutanasia più noti: Pier Giorgio Welby, Eluana Englaro e Fabiano Antoniani (Dj Fabo) in cui mette in rapporto gli aspetti giuridici del fenomeno con quelli sociali, nel V capitolo intitolato: “I giuristi, la vita e la morte”.
Le pagine finali sono quelle che lasciano il segno nel lettore. Sono una splendida sintesi tra la sua esperienza personale nel rapporto con la madre e quella di tante madri che hanno lottato e lottano per salvare la vita ai figli, «quelle fuggite dai lager libici o tunisini, dalle strade dell’Ucraina, di Gaza o di Israele, disperatamente avvinghiate ai figli» che non sono riuscite a proteggere. «Io ti ho sempre salvato dovrebbero poterlo dire tutte le madri: ma solo poche possono farlo; è la nostra tragedia. Le madri che salvano i figli vivono una forma di immortalità, perché fanno vivere la vita che hanno trasmesso».
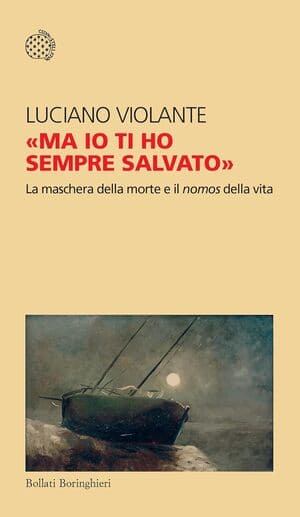
***
Disclaimer: grazie al programma di affiliazione Amazon, Tempi ottiene una piccola percentuale dei ricavi da acquisti idonei effettuati su amazon.it attraverso i link pubblicati in questa pagina, senza alcun sovrapprezzo per i lettori.



0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!