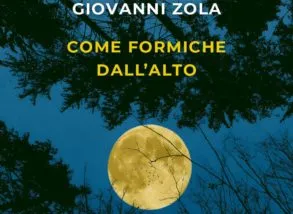
Albacete, un monsignore in mezzo ai lupi

Pubblichiamo l’articolo tratto dal numero di Tempi in edicola (vai alla pagina degli abbonamenti)
Un allegro patriota della totalità del reale. Perciò, un entusiasta di Gesù Cristo. Come dalle prime parole di Karol Wojtyla eletto papa, «redentore dell’uomo, centro del cosmo e della storia». In effetti, benché all’età in cui scrisse l’inedita lettera qui pubblicata non gli passasse nemmeno per la testa la vocazione sacerdotale (ci si dispose dopo che, imbucatosi a un incontro di sacerdoti con Paolo VI, questi gli chiese se fosse anche lui prete, e lui: «Bè, no», e il Papa: «Bè, potresti pensarci»), nel ventisettenne “zio Lolo” che scrive al neonato Michael John del quale sarà padrino di battesimo, c’è già in nuce il formidabile monsignore cattolico di Manhattan. Come le gang portoricane di West Side Story, Lorenzo Albacete ha una mente affilata come un coltello a serramanico. E non aspetta altro che incrociare la sua lama con quelle degli dei liberal della east e della west coast americana.
Lorenzo Albacete era nato nella povera isola di Portorico. E quello del celebre musical ambientato nei bassifondi dei latinos a New York, doveva essere anche il titolo della rubrica che, sul finire degli anni Novanta, avevamo pensato per lui su Tempi. Fatto sta che Monsignore ci ha tenuto compagnia con la sua prosa acuminata per quasi un decennio. Prima del suo incontro con Tempi, da laureato in fisica e scienze spaziali, andato poi a prete – come si dice – per “vocazione adulta” grazie alla felice intuizione di papa Montini, Albacete aveva dovuto attendere l’incontro con don Luigi Giussani per esplodere il suo talento di affabulatore, opinionista, apologeta non clericale. Nel volume che ci propone Marietti, Realtà e ragione (91 pagine, 12 euro), in uno dei testi raccolti dalla sua adorata segretaria Olivetta Danese, c’è il racconto preciso di come andarono le cose. Si tratta di un discorso tenuto nel 2002 alla Templeton Foundation di Filadelfia – “La religione nella sfera pubblica” – che è di un’attualità quasi profetica. Insomma, Monsignore si è trovato all’incrocio di circostanze che rendono bene l’idea di cosa sia “dialogo” in un mondo e in un’epoca in cui tutto è relativo, perfino la verità.
Racconta Albacete che «nel 1997 l’allora cardinale di New York, John O’Connor, mi invitò come professore di teologia presso il seminario arcidiocesano. Mi chiese anche di aiutare la vita della Chiesa nell’arcidiocesi in due altre aree: l’apostolato ispano-americano e la possibile fondazione di un ufficio arcidiocesano per la Fede e la Cultura». Il cardinale O’Connor era a conoscenza del lavoro di Albacete per il movimento di Comunione e Liberazione, «per il quale», scrive Monsignore, «il rapporto tra fede e cultura è una preoccupazione centrale». Nei primi anni Novanta «don Giussani mi aveva chiesto di aiutare le comunità degli Stati Uniti a capire meglio l’esperienza religiosa americana e i suoi effetti su quella che, di fatto, è diventata la cultura dominante del mondo».
Il caso volle, prosegue Albacete, che «poco dopo il mio arrivo a New York, un amico di Washington che scrive per il settimanale liberal The New Republic organizzò una cena di benvenuto. Tra gli ospiti c’erano parecchi suoi amici che lavorano nei media laici, tra cui Rick Hertzberg, autore e redattore del New Yorker. Quando Hertzberg venne a conoscenza del mio lavoro di studio sul pensiero di Giovanni Paolo II mi invitò alcune volte a pranzo con lui e altri redattori per discutere della possibilità di scrivere un articolo sull’imminente visita di Giovanni Paolo a Cuba. Il risultato fu l’articolo di copertina che scrissi per il numero del 26 gennaio 1998 intitolato “Il poeta e il rivoluzionario”».
Una scoperta che unisce
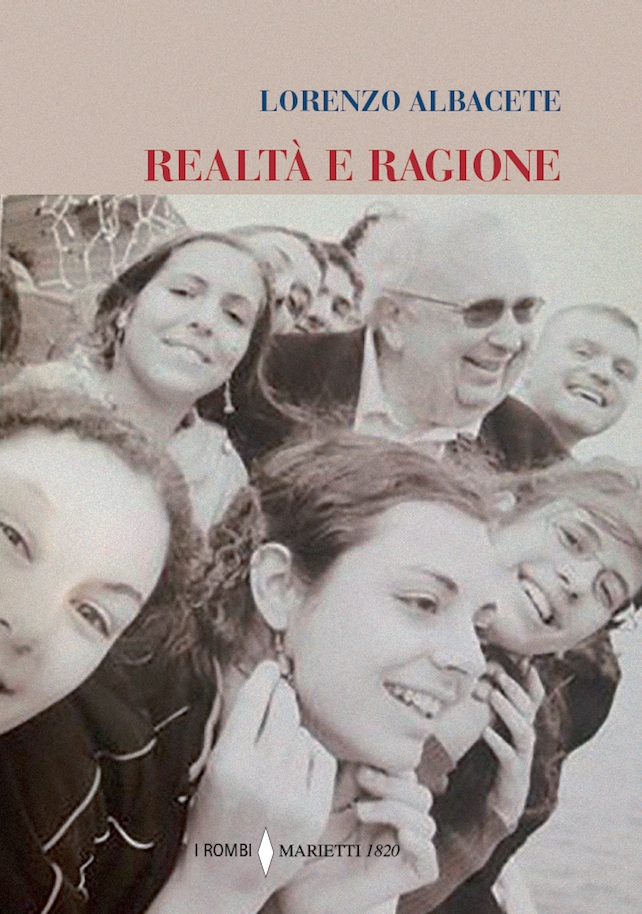
Dopo di che inizia il ricco dialogo del Monsignore con i liberal newyorkesi. «Rick mi invitò ad unirmi a un gruppo di amici che si incontravano ogni settimana per discutere di problemi correnti, e che condividevano tutti la sua prospettiva laico-liberale. Il mio ruolo a questi incontri, suppongo, era quello di rappresentare gli interessi del “Mistero Invisibile”, o qualcosa del genere. Scoprii che, nonostante il nostro approccio a molti dei problemi discussi fosse diversissimo, condividevamo molte delle stesse preoccupazioni fondamentali… che Giussani (e Giovanni Paolo) chiama i desideri “originali” o “primordiali” o “fondamentali” o “costitutivi” del cuore umano. La scoperta che condividevamo queste preoccupazioni divenne la base di una vera amicizia tra di noi». Da questa nettezza e intelligenza di posizione, nasce anche la collaborazione con la bibbia del giornalismo internazionale. «Tra le persone presenti agli incontri c’era una redattrice del New York Times e questo fu il punto d’accesso a quel mondo».
Albacete diventa un collaboratore regolare del New York Times e in seguito verrà ingaggiato anche dalla produttrice televisiva, scrittrice e regista Helen Whitney, come consulente del programma televisivo Frontline di Pbs (Public Broadcasting Service). «Un altro frutto di questi sforzi è il mio libro God at the Ritz Hotel. Fu il risultato di un intenso “interrogatorio” su questioni di religione e fede a cui fui sottoposto durante la presentazione in anteprima del primo programma di Frontline ai critici televisivi degli Stati Uniti in occasione del loro incontro annuale in California per la nuova stagione televisiva. Il libro fa vedere l’approccio che ho seguito in tutte queste attività».
«Eppure lei ci considera suoi amici»
Tradotto in Italia con il titolo devoto Attrazione per l’infinito, il libro mostra bene che per Albacete, come per don Giussani, il dialogo presuppone esattamente l’opposto dello stile cattolico “sommesso” e la sua accettazione del secolarismo come fatto compiuto. Tant’è vero che, spiega Albacete tratteggiando un bilancio del suo coinvolgimento nel mondo della comunicazione laica, «la maggior parte delle persone che ho incontrato è consapevole del fallimento del secolarismo radicale ad affrontare adeguatamente le “grandi” domande sulla vita umana e il suo significato, sia individualmente che socialmente. L’incapacità del secolarismo di prevenire l’orrore assoluto della violenza e della morte prodotte dai grandi mostri ideologici ha scosso la loro fiducia nell’idea di relegare la fede e la religione alla pura dimensione privata. Di conseguenza, in questi circoli l’ideologia dominante è diventata “l’ideologia dell’ambiguità”, custodita preziosamente come l’unica difesa della libertà contro l’intolleranza. Eppure, credo che in fondo molte di queste persone percepiscano che questa non è una soluzione, che questa ambiguità porta presto all’apatia e al cinismo».
L’attualità e la pregnanza di questo metodo di dialogo ce le delinea lo stesso Albacete: «Non c’è bisogno di minimizzare o nascondere le nostre convinzioni, né di tentare di formulare insieme un compromesso, né di cercare un minimo comune denominatore. Un redattore del New York Times mi disse: “Monsignore, abbiamo molti amici che sono preti e che sono d’accordo con noi su quasi tutto. Il risultato è che quello che hanno da dire non è veramente interessante. D’altra parte, quelli che non sono d’accordo con noi non vogliono essere nostri amici. Lei è qui perché non è d’accordo con noi su molte cose, ma è ovvio che le piacciamo e che lei ci considera suoi amici”».
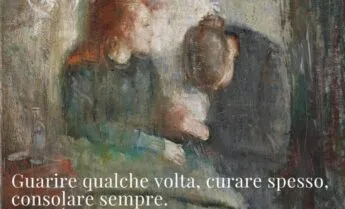
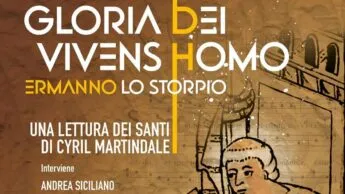

0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!