
Un’unica vita offline e online. Un’opinione “contra Tempi”
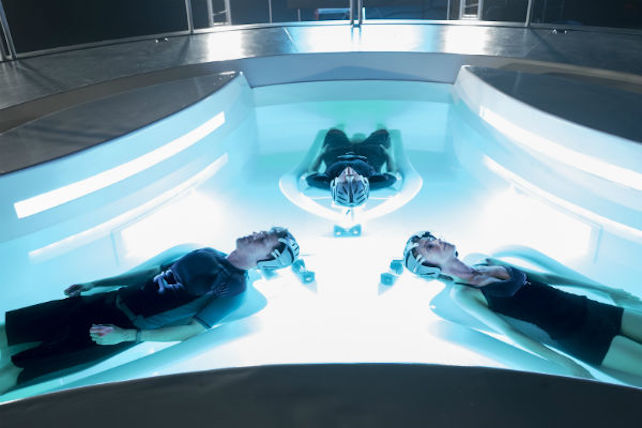
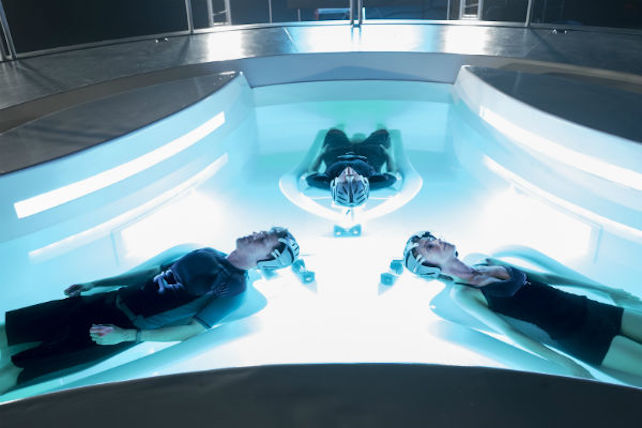
Articolo tratto dal numero di Tempi in edicola (vai alla pagina degli abbonamenti) – «Veniamo da una cultura agricola in cui sapevamo coltivare le piante. Ora siamo in un mondo tecnologico dove dobbiamo imparare a coltivare le menti». Shimon Peres siede di fronte a me. Siamo a Gerusalemme, è l’ottobre del 2012, e insieme a noi ci sono imprenditori, startupper e giornalisti tecnologici provenienti da ogni parte del mondo. Nello spazio di due semplici frasi, l’allora presidente di Israele riassumeva magistralmente la trasformazione profonda che aveva investito e rivoluzionato l’economia di un intero paese – il suo – in appena 25 anni; definiva il cambio di paradigma imposto dall’avvento dell’era tecnologica in cui ci troviamo oggi e, cosa forse ancora più importante, metteva al centro di tutto le persone e la loro intelligenza, da coltivare come se fosse il grano del nuovo millennio. Dall’alto dei suoi 89 anni, Peres aveva capito una lezione che oggi ci riguarda tutti: siamo nel pieno di una rivoluzione digitale e tecnologica che ha senso e si compie in tutta la sua magnificenza solo se l’essere umano ne resta al centro. E affinché ciò sia possibile, l’essere umano deve tenere il passo con il cambiamento, comprenderlo, farlo proprio e dominarlo, altrimenti ne sarà travolto, snaturato, sconfitto. Siamo connessi, interattivi, digitali. Siamo cambiati. In parte, facciamo le stesse cose ma con strumenti, modalità e in tempi diversi. In parte, proprio perché tecnologicamente abilitati, ci scopriamo in grado di farne di nuove, sperimentiamo, improvvisiamo. E così facendo, alla lunga non siamo più gli stessi di prima.
 In Italia ci sono decine di milioni di smartphone e tablet su cui girano app per fare praticamente qualsiasi cosa. L’avvento del mobile ci ha liberato dalla schiavitù del Pc e della scrivania, al punto che ora non c’è più soluzione di continuità tra la nostra vita offline e quella online. La tecnologia che ci consente di ricevere e trasmettere informazioni, mantenere e coltivare relazioni, testimoniare il nostro passaggio in questo tempo, diventa un’estensione delle nostre dita. Servizi sempre più potenti e articolati vengono messi gratuitamente al servizio della nostra creatività.
In Italia ci sono decine di milioni di smartphone e tablet su cui girano app per fare praticamente qualsiasi cosa. L’avvento del mobile ci ha liberato dalla schiavitù del Pc e della scrivania, al punto che ora non c’è più soluzione di continuità tra la nostra vita offline e quella online. La tecnologia che ci consente di ricevere e trasmettere informazioni, mantenere e coltivare relazioni, testimoniare il nostro passaggio in questo tempo, diventa un’estensione delle nostre dita. Servizi sempre più potenti e articolati vengono messi gratuitamente al servizio della nostra creatività.
E quando tocchiamo lo schermo touch di un dispositivo (che ha ucciso la tastiera, abbattendo la barriera di accesso alle nuove tecnologie), il nostro “Io” digitale e quello analogico si incontrano in ciò che il sociologo Derrick De Kerckhove definisce il «punto dell’essere», eliminando ogni soluzione di continuità tra le due dimensioni del vivere. Insomma, per dirla con un altro sociologo esperto di social media, l’americano Nathan Jurgenson, oggi «il digitale è diventato carne».
Tutto questo fa di noi una “umanità aumentata”, potenziata e amplificata dalla tecnologia. In molti si chiedono se sia un bene o un male: la risposta è che dipende. Intanto perché a essere aumentati sono tanto i nostri pregi, quanto i nostri difetti; e poi perché, se da un lato non siamo mai stati così “capaci” né abbiamo avuto mai tante opportunità di esprimere e concretizzare il nostro valore, dall’altro non abbiamo ancora avuto il tempo di digerire e assorbire il cambio di paradigma dettato dall’incredibile accelerazione del progresso tecnologico.
È un po’ il futuro descritto dal grande Philip K. Dick, che immagina un domani in cui gli uomini immersi nella tecnologia fino al collo sono gli stessi di oggi, con i loro vizi e le loro virtù, le idiosincrasie, la crudeltà e tenerezza. Non si sono evoluti: più che altro, sono pieni di nuovi e potenti “giocattoli” hi-tech con cui possono fare miracoli, ma anche spararsi metaforicamente alla tempia.
Un esempio? Basta ricorrere alla cronaca degli ultimi anni: un marito adultero è a Venezia con l’amante. Ha preso ogni precauzione per non farsi scoprire dalla moglie, che pure gli ha messo due investigatori alle calcagna. Riesce a farla franca finché non decide di farsi un selfie con l’amata: sbaglia applicazione e pubblica l’immagine direttamente su Facebook, di fatto autodenunciandosi con tutte le conseguenze del caso.
L’elenco di Epic Fail, di epici fallimenti derivanti da uso inconsapevole di strumenti digitali come questo appare infinito, ma ne basta uno per mettere a terra una prima considerazione: la rivoluzione tecnologica è qui per restare. Opporsi o demonizzarla non serve a nulla; ciò che serve sono formazione, cultura, e una visione condivisa su come diffonderle tra la popolazione. Tutta la popolazione.
Ora due esempi diversi e molto più drammatici: nel primo caso, un ragazzino americano di appena 16 anni litiga con il suo migliore amico, gli spara, si fa un selfie con il cadavere e lo pubblica su Twitter. Viene ovviamente arrestato poche ore dopo. Nel secondo un detenuto di origine rumena muore suicida impiccandosi in una cella di un carcere italiano, e un nutrito gruppo di guardie carcerarie riempie di commenti feroci la pagina del sindacato di categoria che aveva pubblicato la notizia. Peccato lo facciano usando il proprio account Facebook, mostrando nome e cognome, e quindi incorrendo nel giro di pochissime ore in pesanti sanzioni disciplinari da parte dei loro superiori.
Creare un mondo migliore
Qui più che l’uso inconsapevole, che perlomeno smaschera chi compie atti illeciti e condannabili, a emergere è un altro tema fondamentale: per la prima volta nella storia, una parte consistente dell’enorme quantità di interazioni umane alla base della società avviene sotto la luce del sole, visibile a tutti. E rivela con crudele puntualità il lato oscuro della collettività, ci impone di guardare il male negli occhi, di prenderne atto, e quindi di chiederci cosa fare per creare un mondo migliore. Tutti insieme, nessuno escluso.
Perché la rete non rende malvage le persone – così come sostiene chi cerca ogni possibile scusa per tirare fuori dal cappello inutili leggi bavaglio – ma piuttosto le rivela per ciò che sono, le mette sotto i riflettori, creando lo spazio per condannare ma anche per riflettere, oltre che l’opportunità per un’eventuale “redenzione” di chi sbaglia e si vede – finalmente – puntare il dito contro dalla comunità.
La rivoluzione digitale, internet, i social network e tutti gli annessi e connessi sono qui per restare. Le prossime grandi battaglie si combatteranno – ancora una volta, come in ogni epoca – contro i tentativi di controllo, gli oligopoli (ora anche digitali), le manipolazioni dell’informazione e dell’opinione pubblica. Quindi – parafrasando JF Kennedy – smettete di chiedervi se e come la tecnologia vi minacci, e iniziate invece a domandarvi cosa potete fare voi per renderla uno strumento utile a migliorare il mondo.
Perché ormai siamo connessi, interattivi, digitali. E abbiamo finito le scuse.
Il bello di Tempi, fra tante altre piccole cose, è che ha una linea retta e chiara e distinta in fatto di battaglie bioetiche. E per quanto mi riguarda il rapporto tra l’uomo e la tecnica fa parte della questione bioetica. Ma siccome non amiamo i giornali a una dimensione, la nostra retta presenta alcuni segmenti tratteggiati all’interno dei quali è possibile che s’inserisca una visione totalmente opposta, irriducibile alla nostra, purché bene articolata.
È il caso di Alessio Jacona e del suo articolo. L’autore è una persona di valore, nel genere lo si direbbe un influencer di rango. La sua tesi è pressoché interamente centrata sulla neutralità della tecnologia. Del che, da buon jüngeriano, dubito fortemente. Più ancora scettico mi dico sul concetto di “umanità aumentata” dalla tecnologia, poiché esiste una linea di confine (tecnologica) di là dalla quale l’umanità cessa di essere tale e diventa altro.
È la post umanità di cui parlano Fukuyama e i superumanisti? Non proprio. L’uomo è un campo di battaglia all’interno del quale soltanto l’arte (teknè) di elevarsi spiritualmente può sorreggere e giustificare un uso corretto della tecnica, e l’instaurarsi intorno a essa di un discorso virtuoso (non virtuale!) designabile con approssimazione come tecnologia.
Diversamente, per dirla con Oswald Spengler, «l’umanità non ha alcuno scopo, alcuna idea, alcun piano, così come non lo ha la specie delle farfalle o quella delle orchidee: umanità è o un concetto zoologico o un vuoto nome. Si bandisca questo fantasma dal dominio dei problemi storici della forma e allora si vedrà apparire una sorprendente dovizia di vere forme. Qui regnano una sconfinata ricchezza, una profondità e una dinamicità della realtà vivente finora nascosta da parole d’ordine, da aridi schemi, da “ideali” personali. Invece della squallida immagine di una storia mondiale lineare, cui ci si può tenere solo se si chiudono gli occhi dinanzi alla massa schiacciante dei fatti, io vedo una molteplicità di civiltà possenti, scaturite, con una forza elementare dal grembo di un loro passaggio materno, al quale ciascuna resta rigorosamente connessa in tutto il suo sviluppo: civiltà che imprimono, ciascuna, la propria forma all’umanità, loro materia, e che hanno ciascuna una propria idea e delle proprie passioni, una propria vita, un proprio volere e sentire, una propria morte».
La mia civiltà non è quella della Silicon Valley.
Alessio Jacona ha pubblicato il suo articolo sul suo blog, con questa nota che di seguito riproduciamo.
Nota importante sulla genesi di questo articolo, pubblicato giovedì 16 marzo 2017 su Tempi diretto da Alessandro Giuli:
Si fa un gran parlare in questi mesi di “camere dell’eco” e di come i social network servano a isolarci, a chiuderci con le nostre idee insieme con altre persone che la pensano come noi.
Secondo me il problema vero è che la camera dell’eco ce l’abbiamo in testa tutti, da sempre: quando scegliamo con chi parlare, chi frequentare, che cosa leggere, quali canali televisivi guardare e – se siamo giornalisti – su quali testate scrivere.
Si può fare di meglio.
Ad esempio, ci si può mettere in gioco cercando il confronto anche dove vengono espresse idee radicalmente diversa dalla nostra, se non del tutto opposte. Che poi è anche l’unico modo per arrivare a lettori che altrimenti non si riuscirebbero mai neanche a sfiorare.
Può essere davvero utile? È tutto da vedere. Quel che so è che per provarci io personalmente avevo bisogno dell’interlocutore giusto, è che l’ho trovato nel neo-direttore di Tempi Alessandro Giuli.
Alessandro mi ha detto di voler trasformare il giornale che ha preso in mano in uno spazio aperto di confronto, che superi le tradizionali barriere e schieramenti, dove “dirsele di santa ragione”.
E per dimostrarmi che fa sul serio, non solo mi ha chiesto di scrivere un pezzo in risposta al numero di Tempi “I bannati della terra” – del quale sa bene che non condivido una sola parola – ma lo ha anche pubblicato senza battere ciglio, pur essendo a sua volta in totale disaccordo con me.
Il numero è uscito giovedì. Il mio pezzo ha una risposta di Giuli in pagina. Dopo aver letto ci siamo sentiti e abbiamo convenuto serenamente che non siamo d’accordo su un cazzo: “Per questo la vita è bellissima, no?”, è stata la sua risposta.
“Bellissima” forse è una parola forte. Di sicuro diventa più interessante. E stai a vedere che, a forza di insistere e parlarsi, migliora anche un po’.



0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!