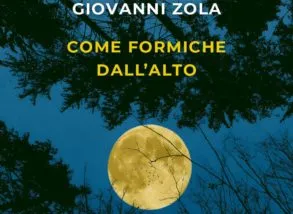
Alla radice dell’autorità paterna


Articolo tratto dal numero di Tempi in edicola (vai alla pagina degli abbonamenti) – La famiglia è stato il primo fondamentale organismo sociale della storia umana, non sorprende dunque che le civiltà e forme religiose si siano spesso ispirate ad essa e alle sue strutture fondamentali per la loro organizzazione e gestione interne. Quasi tutte le più antiche culture mediterranee, sviluppatesi lungo i fiumi e fondate su un’economia agricola, erano caratterizzate da un sistema matriarcale e si riconoscevano nel culto preistorico di una grande madre tellurica, simbolo di fertilità, rigenerazione e protezione. Il potere, seppur amministrato sempre da uomini, era trasmesso per via matrilineare, come nel caso dei faraoni d’Egitto o dei sovrani micenei. Le cose mutarono però sensibilmente, almeno nelle terre sulla sponde settentrionale del Mediterraneo, a partire dalla fine del II millennio a.C., con l’arrivo delle genti definite genericamente indoeuropee.
Originari probabilmente delle regioni a nord del Mar Nero, questi popoli praticavano il seminomadismo ed erano dediti per lo più all’allevamento e alla pastorizia. Queste attività, che obbligavano gli addetti a lunghe permanenze lontano dalla comunità, spesso in completa solitudine, erano propriamente maschili perché svincolate dalla crescita della prole e dalla famiglia. A differenza delle genti agricole e stanziali, inoltre, i popoli indoeuropei collocavano i loro dèi nel cielo perché la loro presenza fosse costante qualunque fosse il paese in cui transitavano o si stabilivano. Queste divinità celesti dominavano la meteorologia e, in quanto apportatrici di pioggia, erano quasi sempre maschili per l’assimilazione dell’acqua fecondatrice allo sperma. Per le genti indoeuropee, la pratica della pastorizia e questa particolare visione del sacro si tradussero in una forma sociale fondata sul patriarcato e su un regime a dir poco fallocratico, dove la figura paterna riuniva in sé caratteri dominanti assoluti e perfino sacrali. Dalla radice pat-, atta probabilmente a designare la paternità, derivarono quei nomi che, nelle lingue storiche di ceppo indoeuropeo, passarono a indicare il padre (in latino páter, in greco patér, in gotico fadar, in persiano padar, in hindi pita, etc.). Nel giro di tre secoli, questi popoli nomadi apportatori del patriarcato irruppero con violenza sulle culture matriarcali del Mediterraneo provocandone in molti casi l’assoggettamento o il totale annientamento.
Le genti latine, che tra tutti gli indoeuropei furono quelle che conservarono di più i loro caratteri culturali ancestrali, mantennero a lungo questo assolutismo paterno, cristallizzato nell’organizzazione gentilizia della società come nei precetti della religiosità tradizionale. La patria potestas rappresentò quindi il più assoluto e sacro dei poteri, fondato sul diritto naturale del genitore maschio e sulla sua facoltà dispotica. La figura del pater familias, com’è noto, era rivestita di una priorità giuridica, di un potere e di una sua sacralità intrinseca che travalicavano enormemente quanto sancito dal diritto naturale. Solo a lui spettava, oltre alla sovranità sulla famiglia, il riconoscimento dei figli, il diritto di venderli come schiavi e perfino di ucciderli, anche se queste eventualità erano più che altro valori formali e verranno spesso perseguite dalle leggi. Particolarmente importante era poi il suo diritto alla gestione del patrimonio, il cui nome deriva proprio dall’essere un dovere paterno (patrimonium da patris munus “compito del padre”).
Il tablinium e la sella
Questa dignità e sacralità era ben sancita già nel V sec. a.C. dalla più antica legislazione romana delle XII Tavole e si estrinsecava quotidianamente in tutta una serie di compiti e liturgie domestiche, dall’assegnazione delle consegne all’amministrazione dei riti religiosi a carattere privato famigliare. Perfino l’architettura della casa sembrava riflettere questa sovranità e sacralità, con il tablinium che era per il padre una sorta di sala delle udienze e la sella il suo trono. In quanto custode e signore della casa, la domus, il padre diveniva dunque un dominus, un “signore” e “padrone”, in una corrispondenza tra spazio fisico consacrato e figura preposta che era una delle caratteristiche più tipiche della civiltà romana. Col passare dei secoli l’aspetto sociale e giuridico si svincolò da quello naturale conseguente alla generazione dei figli e la patria potestas divenne un presupposto degli individui maschi di rango che, per la morte prematura del genitore, si trovavano a ereditarne i poteri; non era raro quindi imbattersi in bambini che fossero pater familias con potere sugli altri membri adulti della famiglia.
La funzione dominica e sacrale della figura paterna si rifletteva macroscopicamente sull’intera comunità e sullo Stato. Nei primi secoli della romanità, infatti, la persona del re assumeva in sé caratteri paterni su tutta la popolazione che era dunque governata sulla base di presupposti che si ispiravano a quelli della famiglia. Per la stessa ragione i membri anziani delle famiglie più antiche erano chiamati i patres e, riuniti nell’assemblea del Senato, costituivano l’organo politico più importante dello Stato romano. In seguito la paternità simbolica del re andò scemando e scomparve completamente alla fine del VI sec. a.C., con la fine della monarchia. La sua funzione sacrale sopravvisse però all’interno di alcuni dei più antichi collegi sacerdotali, organizzati anche loro sul modello gentilizio.
Augusto e il Senato di Roma
Un caso emblematico era quello del pater patratus (letteralmente “padre sancito”), una carica sacerdotale romana documentata però anche per la comunità di Alba Longa. Era questi il più importante dei sacerdoti feziali, cui era affidato il compito esclusivo di stipulare i trattati con le altre popolazioni ma anche quello di procedere direttamente e ritualmente alla dichiarazione di guerra contro di esse. Pare, anzi, che fosse proprio lui a piantare in territorio nemico la cosiddetta lancia bellica, compiendo l’atto formale che dava inizio alle ostilità. Questo diritto gli derivava dal fatto di essere simbolicamente il padre religioso di tutti i cittadini e dunque di poter parlare in nome di Roma, secondo un diritto che era stato in origine del re. È interessante notare, inoltre, come la stessa parola latina che indica la conclusione rituale o sanzione di un accordo, patrare, derivi anche lei dalla radice pat- di padre, un elemento che le dava evidentemente forza sacra e giuridica.
La sacralità assoluta e fatale della figura paterna tornò a essere ribadita nel I secolo con l’avvento dell’impero, quando la struttura del nuovo potere sembrò ispirarsi ancora una volta al modello della struttura famigliare tradizionale. Per questo Augusto, che certo fece del recupero dell’identità latina uno dei fondamenti della sua idea di stato, assunse su di sé, oltre alle altre cariche politiche e istituzionali, anche il prestigio derivante dalla suprema patria potestas e, nel 2 a.C., fu salutato dal Senato come pater patriae. Da questo momento, dunque, l’imperatore romano avrebbe rivestito in sé tutti i poteri conferitigli dalle diverse magistrature, ma santificati da quello assoluto e naturalmente sacro del padre. Va sottolineato che, dopo di allora, diversi altri imperatori assumeranno la paternità della patria ma sempre su conferimento da parte del Senato, cioè degli altri “padri istituzionali”.
La venerazione di Mitra
A partire dal II secolo, con la provincializzazione dell’impero, alcuni istituti e caratteri tradizionali della romanità subirono l’influenza delle culture orientali e vennero svuotandosi di molti dei loro significati arcaici; non fu però così per quelli che interessavano la figura paterna nel suo valore religioso. Anzi, alcune dottrine di origine anch’esse indoeuropee sembrarono perfino rinforzarne la sacralità e l’assolutismo. È il caso, ad esempio, del mitraismo, un culto originato probabilmente in Asia Minore su presupposti di natura iranica. Esso era fondato sulla venerazione di Mitra, un dio persiano minore preposto all’osservanza dei patti (torna dunque il concetto latino del patrare) e figlio del grande dio solare Ahura Mazda. I caratteri di questa religione, che si diffuse enormemente in quasi tutto l’impero romano e rimase attiva per almeno tre secoli, ci sono ancora in parte sconosciuti, ma è certo che essa fosse riservata ai soli maschi adulti e che, al suo interno, fosse organizzata in una rigida gerarchia con regole di ispirazione famigliare. Ogni comunità di fedeli, infatti, contava poche decine di individui e aveva al suo vertice una figura sacerdotale e carismatica cui era conferito il titolo di pater. Questi rivestiva il suo ruolo a vita, era il solo di cui risultava il nome nelle dediche, cui spettava il diritto di accogliere i fedeli all’interno della comunità, celebrare i riti e consacrare i luoghi di culto. La sua carica era posta sotto la protezione di Saturno, il dio padre di Giove cui era attribuito il merito di aver governato il mondo durante la mitica età dell’oro, quando gli dèi, gli uomini e gli animali vivevano insieme in una perenne pace e beatitudine. Il pater mitraico, dunque, era un autentico garante del bene e dell’ordine, un benevolo genitore custode dei riti e guida della comunità. In alcune iscrizioni votive il suo nome è accompagnato dall’epiteto di pater patrum (“padre dei padri”) o addirittura da quello arcaico di pater patratus (entrambi abbreviati in p.p.) in riferimento ai patti sacri cui era preposto originariamente il dio Mitra.
Come molti altri precetti rituali del mitraismo, anche questa funzione prioritaria del padre passò al cristianesimo fino a metterne in ombra alcune tendenze matriarcali che fin dai suoi primi secoli erano parse affermarsi, soprattutto in occidente. Anche nella nuova religione si costituirono dunque comunità di fedeli a capo delle quali si posero figure maschili cui era riservato l’esercizio del culto e a cui era riconosciuta un’autorità simile a quella del pater mitraico. Il caso senza dubbio più emblematico è quello della Chiesa di Roma, il cui vescovo assunse quelli che in precedenza erano stati alcuni titoli sacerdotali pagani, tra cui quello di pontefice massimo, o quello ancor più discusso di papa, usato a partire dal V secolo. È opinione comune che esso derivi proprio dall’abbreviazione p.p. di pater patrum e sia dunque un’eredità mitraica, anche se nel medioevo si pensava addirittura che fosse un acronimo della frase Petri Apostoli Potestatem Accipiens (“Avente il potere dell’apostolo Pietro”), con cui si intendeva ribadire il primato della Chiesa Romana.
Il pontefice e l’abate
È ben più probabile, invece, che esso derivi dalla parola greca πάππας, usata familiarmente per indicare proprio la figura paterna, e derivante a sua volta dal semitico happa. Il suo uso religioso cristiano si trova per la prima volta nel De Pudicitia di Tertulliano per designare genericamente la persona del vescovo, e sopravvive ancora in Oriente nel nome pope dei sacerdoti ortodossi. Nella forma habba il titolo paterno si ritrova anche nelle comunità monastiche del Sinai per indicare il monaco anziano posto a capo del cenobio e a cui si doveva obbedienza (da cui il termine latino abbas “abate”). L’uso della parola papa come attribuzione del vescovo di Roma si trova invece già in una lettera di papa Siricio (384-399) ed è ribadito dallo scrittore ecclesiastico Ennodio in una sua epistola a papa Simmaco (498-514). Nella nomenclatura attuale, del resto, la si ritrova nel titolo “Santo Padre” usato specificatamente per il primate della Chiesa Cattolica Romana.
Dunque l’autorità paterna sembra essere stata, almeno nel mondo occidentale, una garanzia di potere assoluto e sacralità che, fin dalla protostoria e senza soluzione di continuità, ha accompagnato lo sviluppo di alcune delle più grandi civiltà e forme religiose per tutti i secoli della loro storia, costituendone senza dubbio uno dei caratteri e presupposti più importanti.
Foto Ansa
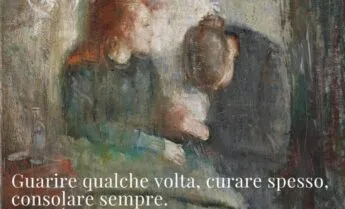
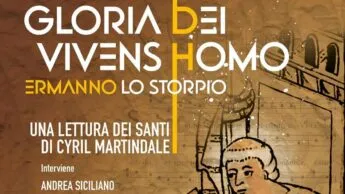

0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!