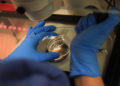Articolo tratto dal numero di Tempi in edicola (vai alla pagina degli abbonamenti) – Agli inizi del XII secolo, Roberto di Arbrissel, figlio di un prete, prima maestro ad Angers, poi eremita secondo il costume bretone e celtico, poi predicatore itinerante dall’aria incolta e dal fare bizzarro, riscosse un grandissimo seguito tra la popolazione e creò un vero e proprio movimento popolare. La sua giovinezza non era trascorsa nell’innocenza: il suo biografo narra che aveva mantenuto la castità fino a quando aveva potuto; praticava una curiosa ascesi orientale, mediante la quale nell’atto sessuale solo la donna provava piacere, mentre l’uomo se ne asteneva. La sua personalità affascinava soprattutto l’animo femminile: prostitute, principesse, contadine seguivano lo strano predicatore del Vangelo in una turba disordinata per vaste desolate regioni e per foreste nel nord della Francia. Ciò non mancò di preoccupare l’autorità ecclesiastica del luogo, il vescovo Marbodo di Rennes, che inviò a Roberto quasi un ultimatum: doveva provvedere a regolare quel movimento a cui aveva dato vita. Fu così che, a malincuore, Roberto dovette rassegnarsi, in ubbidienza ai suoi superiori, ad adottare un genere di vita più ordinato, secondo la regola benedettina, con alcuni significativi mutamenti.
Divisi gli uomini dalle donne, e tra queste le vergini, le vedove e le prostitute pentite, impostò la vita comune secondo il modello della Chiesa primitiva. Poiché Gesù dalla croce aveva affidato come figlio l’apostolo Giovanni a Maria, nel monastero doppio di Fontevraud, il primo insediamento della comunità di Roberto di Arbrissel, gli uomini erano sottoposti all’autorità della badessa. Essi provenivano da ceti medio bassi, perché i nobili si rivolgevano in prevalenza al monachesimo tradizionale. Le donne invece erano in prevalenza nobili, per la scarsità di monasteri femminili e per l’attrattiva che Roberto esercitava su di loro. Le prostitute pentite abitavano un piccolo monastero a parte, dedicato a santa Maria Maddalena. Le comunità maschile e femminile facevano vita separata, ma si riunivano nella chiesa per la recita delle ore canoniche. La badessa era scelta tra le vedove, più esperte del mondo e più abili nell’amministrare un patrimonio che, a causa di ricche donazioni, si accresceva con il passare degli anni.
Non una fondazione isolata
Il monastero di Fontevraud, imponente costruzione nella valle dell’Anjou, è costituito da una luminosa chiesa a tre navate, semplicissima e severa. Nel transetto destro si trovano le tombe dei grandi benefattori della nuova fondazione: lì riposano in tombe policrome Eleonora d’Aquitania, la protettrice del trovatori, ed Enrico II Plantageneto. La gloria del complesso è l’ampia cucina ottagonale, adatta alle dimensioni della costruzione. L’edificio del monastero, ampliato nel corso del Seicento, è di grande bellezza e maestà, anche se la Rivoluzione francese prima e poi Napoleone lo ridussero a uno stato di abbandono e lo adibirono ad altre mansioni meno nobili rispetto alla dignità della vita monastica.
Presto nelle regioni vicine si costruirono altri monasteri doppi, a imitazione della casa madre, per cui si può parlare non tanto di una fondazione isolata, quanto di un vero e proprio ordine, che mise le radici in tutta la Francia e in Spagna, dove si spense all’inizio dell’Ottocento. Le ultime monache rimaste ne scrissero la storia.
Roberto preferiva all’immenso monastero di Fontevraud fondazioni più piccole. Non a caso volle morire presso le predilette monache di Orsan, dove il suo corpo rimase sepolto, mentre il suo cuore, estratto dal petto, secondo una consuetudine per noi piuttosto macabra, ma allora non infrequente, fu trasportato con tutti gli onori nell’abbazia madre.
La badessa Petronilla di Chemillé, ricca vedova, resse il monastero con mano ferma, con giurisdizione anche sui monaci, come aveva voluto il fondatore. Ma già pochi anni dopo la decadenza incombeva. Era assai difficile mantenere la purezza e l’intensità del fervore primitivo e non mancarono occasioni di rivolta tra i monaci all’autorità indiscussa della badessa e in generale dell’elemento femminile più ricco e più scaltro.
San Bernardo e la contessa
Il fascino della predicazione di Roberto di Arbrissel era basato sulla ripresa integrale del Vangelo, quasi anticipazione di san Francesco un secolo dopo. Gli storici della spiritualità cristiana medievale assimilano in più punti le due figure. L’unico suo scritto pervenuto è una lettera inviata alla contessa Ermengarda di Bretagna. Nata verso la metà dell’XI secolo ad Angers, era figlia del conte d’Angiò e aveva sposato giovanissima il conte di Poitiers; rimasta vedova, si era risposata con il duca di Bretagna e durante l’assenza del marito, partito per la Crociata, aveva affiancato il giovane figlio come reggente nel governo delle terre. Il duca era tornato dalla Crociata provato nel corpo e nello spirito e, come spesso accadeva, aveva abdicato e si era ritirato in un monastero. Decisa a seguirne l’esempio, Ermengarda si rivolge a Roberto di Arbrissel, il quale piuttosto che incoraggiarla a prendere il velo, la invita a santificare la sua vita di castellana, ad attendere con cura ai suoi doveri senza trascurare la preghiera e le opere di carità.
 Forse in questa duttilità dolce e insieme esigente, improntata a mitezza e mansuetudine, lontana dalla durezza di regole rigide si trova il motivo dell’efficacia della predicazione di Roberto; in questa lettera, piccolo gioiello di spiritualità laicale, è presente una valorizzazione della vita familiare molto moderna per tempi nei quali essa era ancora ben lontana dall’essere tematizzata. Essa documenta quanto parziale sia una lettura unicamente misogina del Medioevo, in cui la figura della donna troverebbe risalto nella devozione alla Madonna e soltanto dopo secoli di oblio verrebbe idealizzata dall’amore cortese, senza alcun interesse per la realtà concreta della condizione femminile.
Forse in questa duttilità dolce e insieme esigente, improntata a mitezza e mansuetudine, lontana dalla durezza di regole rigide si trova il motivo dell’efficacia della predicazione di Roberto; in questa lettera, piccolo gioiello di spiritualità laicale, è presente una valorizzazione della vita familiare molto moderna per tempi nei quali essa era ancora ben lontana dall’essere tematizzata. Essa documenta quanto parziale sia una lettura unicamente misogina del Medioevo, in cui la figura della donna troverebbe risalto nella devozione alla Madonna e soltanto dopo secoli di oblio verrebbe idealizzata dall’amore cortese, senza alcun interesse per la realtà concreta della condizione femminile.
Ermengarda entra a Fontevraud nel 1111 per uscirne alla morte del marito e assumere il ruolo di conciliatrice nella Bretagna sconvolta da intrighi e lotte nobiliari. Ma la nostalgia del chiostro la accompagna e la mette sulle tracce di Bernardo di Chiaravalle, nel cui ricco epistolario si trovano due lettere a lei indirizzate, non facilmente databili. In un brano della prima egli le si rivolge così: «Piacesse a Dio che tu potessi leggere nel mio cuore come su questa pergamena. Vedresti quale profondo amore il dito di Dio ha inciso per te nel mio cuore». Un frammento della seconda esprime l’affetto in modo ancora più esplicito: «Il mio cuore è colmo di gioia quando sento che il tuo è in pace. Che piacere sarebbe intrattenermi con te di persona e non per lettera. Mi dolgo dei miei impegni quando mi impediscono di vederti e sono così felice quando mi consentono di farlo».
Il tono meraviglia gli esperti, pur abituati all’affettività del santo, che si esprime secondo tutta la gamma dei sentimenti umani, dall’ammirazione alla rampogna, dall’intenso affetto all’ira. Vi si legge l’attenzione riservata dall’abate cistercense alla sensibilità di una donna forte tanto da governare territori estesi, ma anche combattuta circa la via per perseguire la propria santità.
Quei gesti “fuori regola”
Ermengarda infatti non trova pace neppure quando per opera di san Bernardo viene accolta tra le monache cistercensi di Larrey nel 1129. Su invito del fratello Folco, diventato re di Gerusalemme, compie un pellegrinaggio in Palestina, non contemplato dalla rigida clausura dell’ordine che aveva abbracciato. Al suo ritorno in Bretagna fonda l’abbazia cistercense di Buzay, il cui primo abate è il fratello di san Bernardo. Nel 1147 muore in monastero e viene sepolta accanto alla tomba del secondo marito, esempio quanto mai vivace di una condizione femminile privilegiata e connotata da mutamenti, dovuti non solo alle circostanze esterne.
Non è mai prudente usare storie e figure del passato per un confronto moralista con il presente. Però a volte basta scendere poco sotto lo strato superficiale dei pregiudizi per scoprire vite interessanti, fuori dagli schemi, amicizie depositate nella corrispondenza epistolare, relazioni rispettose e comprensive tra religiosi e donne che a loro si rivolgevano per trovare la propria strada e che non sempre erano prone ai consigli ricevuti. Tutto bello e umano, anche se in un cono d’ombra che tende a farlo scomparire. Tutto ancora presente e praticabile, solo che lo si voglia.
Foto Fontevraud da Shutterstock