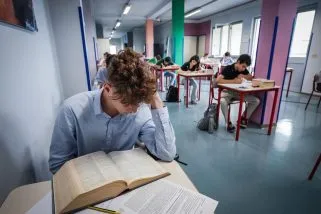
La storia della grande Alfa Romeo, che è anche quella della Grande Milano, raccontata da un appassionato e collezionista


L’Almanacco 2013. Dal sogno al progetto per una Grande Milano: Milanosesto è l’originale pubblicazione di Milanosesto spa nata da un’idea di Carlo Bruno, con la direzione creativa di Pietro Bestetti, per offrire un racconto corale della sempre più Grande Milano. La città che si allarga e si alza come un’entità viva nutrendosi e arricchendosi del patrimonio antropologico, culturale e industriale che la circonda. Sesto San Giovanni, dove Milanosesto spa e Renzo Piano stanno dando vita al più grande progetto italiano per il recupero e la riqualificazione di aree industriali dismesse, quelle della ex Falck, un sito di oltre 1.400.000 metri quadri; Monza con il suo parco; Arese che ha visto crescere e prosperare l’Alfa Romeo dopo il trasferimento dal Portello; le piane coltivate a sud, che circondano la bella Abbazia di Chiaravalle. Nello snodarsi delle pagine dell’Almanacco, attraverso testimonianze, interviste, poesie, illustrazioni, e visioni del futuro, il passato industriale e i simboli forti della provincia si mescolano alle immagini rappresentative dell’anima della città: la perfetta regalità della Scala, le guglie del Duomo da cui, nelle belle giornate, oltre alle gru si vedono le Alpi, l’arte dei musei e della strada, la musica delle periferie, il prêt-à-porter e l’alta cucina dei maestri chef. Frammenti vivi di una città non solo grande, ma sempre più grande. Tutta da riconoscere e immaginare sfogliando l’Almanacco, 170 pagine firmate da giornalisti ed esperti, scrittori e fumettisti, collezionisti e chef (da Gippo Salvetti a Barbara Alberti, da Salvatore Carrubba a Davide Oldani) che i lettori di Tempi potranno richiedere all’indirizzo [email protected] (fino ad esaurimento copie).
Sono un collezionista di Alfa Romeo. Molti mi definirebbero Alfista. A me piace di più Alfazioso: un Alfista fazioso. Alfisti o Alfaziosi non si nasce, si diventa da piccoli. Perché anche un bambino può rendersi subito conto che le Alfa Romeo hanno uno stile, un appeal, un rombo, una simpatia diversi da tutte le altre macchine. Specie dalle Lancia, distanti per cultura e design e per il loro “aplomb”, che sono state le vere e sole rivali delle Alfa fin dalla sua origine. Così Io divenni un Alfista fazioso a 5 anni, nel 1957, quando mi sono ammalato di questa malattia incurabile: l’Alfite.
Collezionare vuol dire prima di tutto sognare e conoscere a fondo l’oggetto della propria passione. Non solo la meccanica, la sinuosità della forma, ma anche la sua storia avvincente, legata nel caso dell’Alfa a doppio filo con quella dell’Italia e di quella “grande Milano” che spazia dal Portello ad Arese, dall’autodromo di Monza alle acciaierie di Sesto San Giovanni. Se Henry Ford, in segno di stima e ammirazione, si toglieva addirittura il cappello davanti alle prime vetture uscite dai capannoni Alfa Romeo, negli Anni 50 si parlava “dell’auto di famiglia che vince le corse” a significare che l’Alfa (in questo caso la 1900), pur essendo un purosangue rispetto alla concorrenza, ha contribuito (e non poco) alla motorizzazione di noi italiani.
Nata da un fallimento, e poi a più riprese in bilico tra trionfo e rovina, l’Alfa Romeo è segnata da una continua corsa verso il nuovo, che si traduce in progetti ambiziosi e spesso spregiudicati (sia nella meccanica che nel design), magari persino troppo all’avanguardia (leggi la coda tronca della Giulia poi copiata da tutti a cavallo tra Anni 60 e Anni 70) per essere compresi dal mercato. Ma che l’hanno resa grande.
Questo concetto nel tempo si è rafforzato sempre di più, tanto che Alfa Romeo è oggi considerato il marchio automobilistico con il maggior carico di storia. Una storia nata dalla visione di un imprenditore, Nicola Romeo, e costruita grazie all’intelligenza meccanica di progettisti che hanno fatto dell’azienda con i suoi prodotti una realtà riconosciuta in tutto il mondo. Un vero e proprio riferimento.
Alfa Romeo, infatti, non vuol dire solo automobili ma anche motori aeronautici, autobus, filobus, motori marini, mezzi di servizio e autocarri (sia civili, sia militari come la famosa fuoristrada Matta) che hanno trasportato tonnellate di materiale dal Brasile, all’Abissinia all’Est Europa.
Dagli stabilimenti del Portello e dalle officine di Pomigliano d’Arco (aperte a inizio anni ’40) uscivano motori per aviazione, autocarri e poi autobus che fino agli anni ’60 hanno rappresentato una quota importante della produzione Alfa Romeo. Un aspetto oggi poco considerato ma che allora era il vero cuore dell’azienda, soprattutto quando il mercato delle automobili era ancora una nicchia riservata a pochi benestanti o allo Stato.
Tutto è partito da Milano, dove è sempre rimasta la testa pensante di un’azienda che sin dalla fondazione ambiva a dare risposte a un’Italia affamata di mezzi e soluzioni per poter crescere e competere con le grandi potenze del tempo. L’Anonima Lombarda Fabbrica Automobili (A.L.F.A.) fu fondata nel 1910 al Portello, alla periferia nord di Milano, sulle rovine della società automobilistica francese Darracq. Nel 1915 l’azienda fu rilevata da Nicola Romeo, imprenditore napoletano di nascita ma milanese di adozione che, oltre al nome, diede nuovo impulso alla produzione, principalmente grazie alle commesse militari. Dal 1933 l’Alfa entrò a tutti gli effetti nell’orbita statale dell’IRI e in seguito, con le guerre coloniali, ottenne ingenti commesse per le forniture meccaniche più disparate.
Le auto erano ancora una minima parte della produzione. E lo sono rimaste per molto tempo: ancora nel 1936, dalle officine del Portello dove lavoravano migliaia di dipendenti, sono uscite solo una dozzina di veicoli. Ma il talento di Alfa Romeo si era rivelato fin da subito, con la prima auto prodotta, la 24 HP, quando è stata messa in luce per la prima volta la vocazione sportiva del marchio. Sono arrivati poi i trionfi sulle piste di tutto il mondo (dalla Mille Miglia agli Usa), la rossa di Nuvolari, Enzo Ferrari che ha iniziato la sua carriera grazie alle Alfa Romeo: simboli che nell’immaginario collettivo fanno correre il pensiero alla croce e al Biscione visconteo, e al famoso quadrifoglio che ha raffigurato il segno vincente sui cofani delle vetture da corsa (negli anni più vicini a noi come non ricordare le vittorie delle Gta della scuderia Autodelta sulle auto tedesche?).
L’officina, la fonderia, il reparto esperienze, la progettazione, la squadra corse, tutto questo ha rappresentato un tessuto connettivo di esperienza e di qualità umana per la quale i dipendenti Alfa Romeo si sentivano giustamente orgogliosi e con un senso di appartenenza difficilmente riscontrabile in altre realtà. Poi la guerra. E i famosi bombardamenti del ‘43 che hanno praticamente raso al suolo tutto il Portello. Anche i capannoni dell’Alfa Romeo andarono in fumo. In una città già ferita, l’attacco a realtà produttive il cui prestigio era esteso al mondo intero, fu un colpo durissimo.
Ma la Grande Milano si riprese. E nel mio universo di appassionato e collezionista, uno dei simboli più potenti di questa rinascita è l’immagine di Varzi e Trossi che durante il Gran Premio di Milano del 1947 sfrecciano sulle loro Alfa Romeo con alle spalle il cantiere della Fiera Campionaria, che sarebbe stata ampliata proprio là dove prima fischiavano le sirene dei capannoni dell’Alfa. La ricostruzione ha impresso un ritmo nuovo a tutto il microcosmo produttivo milanese, anche all’Alfa Romeo, che ha cominciato ad orientarsi verso un progetto industriale più complesso, di ampie vedute, grazie al quale ha saputo rivolgersi ad un target economicamente più soddisfacente: la nuova classe media, che attraverso simboli come la macchina e la televisione ambiva ad acquisire uno status di modernità e progresso necessari a quell’Italia che voleva rimettersi in moto. E non solo in senso figurato.
L’avvento dell’alfa 1900, prima vettura mono scocca (e quindi realizzabile non più solo in piccola serie ma in una vera e propria catena di montaggio) e poi il grandissimo successo della Giulietta, seguito da quello della Giulia hanno aperto le porte allo sviluppo del nuovo stabilimento di Arese, pochi chilometri a Nord Ovest di Milano. Alfa Romeo smette così di identificarsi solo con Milano e diventa l’emblema della Grande Milano, un territorio ricco di fonderie, acciaierie, sub fornitori di componenti, grandi carrozzerie come Zagato e Touring, tutto quel territorio che va da Arese a Sesto San Giovanni, a Settimo Milanese, a Monza, dove si trovava l’autodromo di casa Alfa: un tessuto collegato alla grande città, la cui piazza ormai non era solo quella del Duomo ma anche quelle delle tante piazze delle cittadine circostanti.
In queste piazze, si muovevano centinaia di famiglie immigrate da ogni parte d’Italia, che sono cresciute insieme alle aziende come Alfa Romeo e hanno fatto crescere a loro volta il territorio milanese, che ha assimilato e integrato tradizioni, culture, dialetti diversi restituendo una realtà sempre più composita e vicina a quella odierna. La storia di Alfa Romeo è affascinante proprio perché si intreccia con quella del nostro paese in un momento in cui si sono plasmati i presupposti della società che conosciamo oggi, passando per i trionfi sportivi, la ricostruzione del dopoguerra, il boom economico e le lotte operaie. Un’azienda, milanese sì, ma con accenti napoletani (il fondatore e lo stabilimento di Pomigliano), così da unire non solo idealmente il Nord al Sud e viceversa.
Un’azienda, l’Alfa che a seconda delle epoche ha registrato grandi successi, ma anche grandi crisi. Un gruppo che per necessità ha cercato anche accordi con aziende straniere: con la Renault a cavallo tra Anni 50 e 60 per la produzione della Dauphine e la commercializzazione della R4. E 20 anni dopo con la joint venture con la giapponese Nissan per la produzione a Pratola Serra (AV) della Arna. Un fallimento che ha pesato sulla situazione economica e contribuito a mettere in ginocchio l’Alfa, nonostante all’epoca si producesse una magnifica auto per la grande massa, l’Alfa Sud, e che ha favorito successivamente il suo passaggio dall’orbita pubblica (IRI) a quella privata (Fiat).
Ma ancora più affascinante, è osservare come i prodotti di questa grande azienda abbiano scandito il passaggio delle epoche: auto da corsa, auto per pochi, diventate poi lo status symbol della nascente classe media e del primo benessere, auto forgiate in capannoni che hanno visto nascere i movimenti sindacali, auto che oggi rappresentano una vibrante (anzi, rombante) testimonianza e sono diventate il tesoro dei collezionisti. Soprattutto dei collezionisti Alfaziosi come me.
Articoli correlati
2 commenti
I commenti sono chiusi.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!



L’inizio della fine fu la sindacalizzazione estrema dell’azienda che culminò con la nomina alla presidenza di un certo Massaccesi (mi pare si scrivesse così), un inetto sindacalista. La casa di Arese era nota nei dintorni come “Casa di Riposo”. Gli operai avevano un secondo lavoro. L’Alfetta si poteva trovare, ovviamente con documenti taroccati, presso alcune piccole officine che assemblavano le auto con pezzi assolutamente originali, usciti illegalmente dalla fabbrica. Dagli stabilimenti Alfa Sud uscivano anche le macchine… per il caffè. Così è stato e così è ancora oggi dove lo strapotere sindacale protegge i lavativi e i fannulloni o addirittura, vedi i casi dei furti all’aeroporto di Malpensa, i delinquenti. Chissà se di tutto questo vi è traccia nel libro.
un glorioso marchio che lanciò auto bellissime e grintose e occupò decine di migliaia di lavoratori fino a quando il potere vetero comunista sindacale e il Prodismo disastratore disfecero la grande azienda di Arese e regalarono il nuovo marchio annacquato alla Fiat