
Siamo così stanchi delle nostre vacue libertà che è meglio sottometterci? Ma Allah non si è fatto carne

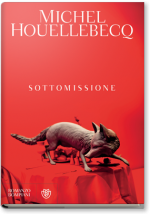 «Della libertà l’uomo non ne può più». «Il cristianesimo è ben più che un libro, è un incontro tra vivi, tra gli uomini e il Cristo vivo». Le frasi appartengono a due autori diversi, ma sono apparse entrambe ieri sul Corriere della Sera. La prima l’ha pronunciata lo scrittore francese Michel Houellebecq in un’intervista molto interessante e a tutto campo sui fatti parigini e il suo libro. La seconda l’ha scritta Vittorio Messori in un articolo in cui si ragiona di islam e cristianesimo. Due interventi diversi, entrambi notevoli.
«Della libertà l’uomo non ne può più». «Il cristianesimo è ben più che un libro, è un incontro tra vivi, tra gli uomini e il Cristo vivo». Le frasi appartengono a due autori diversi, ma sono apparse entrambe ieri sul Corriere della Sera. La prima l’ha pronunciata lo scrittore francese Michel Houellebecq in un’intervista molto interessante e a tutto campo sui fatti parigini e il suo libro. La seconda l’ha scritta Vittorio Messori in un articolo in cui si ragiona di islam e cristianesimo. Due interventi diversi, entrambi notevoli.
IL RITORNO ALLA RELIGIONE. Di Houellebecq sapete tutto. È il romanziere francese la cui immagine appariva su Charlie Hebdo il giorno dell’attentato, ha scritto un libro di cui si discute ormai in tutto il mondo (Sottomissione) e che esce oggi in Italia. Houellebecq è personaggio singolare, genialoide e naif, difficilmente banale. Nel colloquio, oltre a raccontare i suoi sentimenti di paura e cordoglio per le vittime dell’attentato – l’economista Bernard Maris era suo amico – mostra anche un certo disincanto sia verso la manifestazione di Parigi sia verso la decisione del settimanale satirico di mettere Maometto sulla copertina del nuovo numero: «Non credo che quella marcia pur immensa avrà enormi conseguenze. La situazione non cambierà nel profondo, torneremo con i piedi per terra». Lo scrittore si dice «allarmista» sul futuro della Francia ma non «declinista», «perché ci sono cose bizzarre e positive che accadono in Francia, per esempio abbiamo una demografia molto alta, una cosa tutto sommato misteriosa».
Così come bizzarro è il fenomeno del ritorno alla religione: «È un fenomeno che i media non riescono a cogliere, pensano che la religione sia un fenomeno passato di moda. Ma prima di domenica le grandi manifestazioni di piazza sono state le manif pour tous. Fatte da cattolici molto diversi da quelli che mi ricordavo da giovane, ovvero gente complessata e all’antica oppure di sinistra insopportabilmente perbenista (ride, ndr)».
LA LIBERTA’ E’ FATICOSA. Ma l’aspetto più interessante di Houellebecq è la sua convinzione che gli occidentali siano ormai stanchi di essere liberi. «Della libertà l’uomo non ne può più, troppo faticosa», dice. «Ecco perché parlo di sottomissione». E oltre a confermare all’intervistatore che il suo non è un volume islamofobo, ma semmai islamofilo, Houellebecq garantisce che il Corano non è un libro violento che incita «ad ammazzare i bambini ebrei». La violenza, spiega «non è connaturata all’islam. Il problema dell’islam è che non ha un capo come il Papa della Chiesa cattolica, che indicherebbe la retta via una volta per tutte».
«SONO STANCO DI ESSSERE ATEO». Insomma, come aveva già spiegato, la visione di Houellebecq parte dalla constatazione che «l’ateismo è perdente perché è troppo triste». O, come dice al Corriere, «essere ateo mi è diventato insopportabile». In lui paiono così convivere la convinzione che l’essere umano è – per natura – un essere religioso (nel senso di legame con qualcosa di diverso da sé e che lo trascende) e la constatazione che la libertà di cui oggi gode è monca, sciatta e non all’altezza della sua condizione naturale e primigenia. Ma se questa libertà con cui ci ha illuso la cultura occidentale negli ultimi duecento anni è triste e amputata, che fare? Non sembra da scartare l’ipotesi, suggerisce il romanziere, di barattare tale libertà con la sottomissione (islam), che perlomeno riannoda l’uomo con un dio oltre sé.
LA UCCIDERO’ SENZA FARLA SOFFRIRE. Se questo accade in maniera pacifica e opportunistica nel romanzo di Houellebecq, cosa ci racconta la realtà? E qui val la pena prendere in mano l’articolo di Messori, che si inserisce nel dibattito sollevato del rabbino Giuseppe Laras. Due i passaggi notevoli.
Il primo in cui l’autore riporta un aneddoto «purtroppo autentico: «Un amico francese, religioso cattolico a Gerusalemme e noto biblista, mi raccontava di recente che, nel loro convento, serviva da sempre, come factotum, un ormai anziano musulmano. Onesto, gran lavoratore, di tutta fiducia, faceva ormai parte della famiglia e tutti quei religiosi gli volevano bene, sinceramente ricambiati. Un venerdì, l’uomo tornò dalla moschea con un’aria accasciata. Il superiore della casa, insistendo, riuscì a farlo parlare. Disse: “Oggi l’imam che dirige la preghiera ci ha detto, nella predica, che nel giorno del trionfo di Allah e del suo Profeta, nel giorno che presto verrà e in cui libereremo questa Santa Città da ebrei e cristiani, tutti gli infedeli che non faranno subito professione di fede dovranno essere uccisi. Così vuole il Corano cui noi tutti dobbiamo obbedire”. Una pausa, e poi: “Ma non tema, padre, sa che io vi voglio bene, so come fare, se dovrò sopprimervi troverò il modo di non farvi soffrire”».
LA DIFFERENZA TRA CRISTIANESIMO E ISLAM. Insomma, forse tutto accadrà in maniera indolore e ipocrita come profetizza Houellebecq, ma i suggerimenti della cronaca vanno in direzione opposta. Il secondo passaggio, però, è quello più importante perché Messori coglie lucidamente qual è il nocciolo della questione: Allah non si è fatto carne. «Il Califfato ottomano, abolito nel 1924 da Kemal – scrive -, era una finzione a servizio del sultanato e, in ogni caso, la sua evanescente autorità non era riconosciuta al di là dei confini dell’impero turco. Ma anche se tornasse, che potrebbe fare un “Papa della Mecca” che non avrebbe la grande, liberante risorsa di quello di Roma: la risorsa, cioè, di una Scrittura approfondibile secondo i tempi e le situazioni pur senza rinnegarla, flessibile pur senza tradirla, divina ma affidata alla ragione di credenti che con essa devono affrontare i secoli? Il Cristianesimo, prima è ben più che un libro, è un incontro tra vivi, tra gli uomini e il Cristo vivo, con la ricchezza e la duttilità che nasce dalla vita. Ma così non è il Corano, anzi ne è il contrario, con il testo originale custodito in Cielo accanto ad Allah, eterno, immodificabile, dettato parola per parola a Muhammad, con le sue sentenze da osservare sempre e comunque in modo letterale, con la sua rigidità che deve sfidare ogni cultura, costi quel che costi. Possibile trarre, da qui, un “moderatismo” maomettano?».
Articoli correlati
1 commento
I commenti sono chiusi.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!



Caro Emanuele Boffi, il punto o uno dei punti più importanti per comprendere differenze che spostano il terreno di confronto dalla teologia o dall’antropologia – come se l’una, nel caso delle religioni, potesse andare disgiunta dall’altra – alla poltiica e al diritto è proprio questo. L’Incarnazione – mi lasci esprimere per metafore – è ciò che manca a tutte le altre religioni: solo nel Crisitianesimo il Verbo Divino Si è fatto Carne: Parola vissuta che Si incarna in noi – una “terribile bellezza è nata”, per dirla con Yeats, che si riferiva alla Pasqua di Sangue irlandese (e certe fatti vanno ben oltre le simbologie care al Mago Bianco): la Natività ha cambiato tutto, perfino la storia dell’arte.
Di questo non c’è traccia nell’Islam, che pretende di avere in Maometto l’ultimo Messaggero (!), così da aver portato a compimento la Rivelazione: mentre, al contrario, la religione islamica
– è regredita al sacrificio abramitico – con la mattanza dell’agnello a chiusura del Ramadan: premessa a tutte le altre mattanze;
– e ha fatto della Carne e del Verbo Divino un libro.
Il fatto che l’originale di questo libro sia in cielo e noi ne vediamo quaggiù le copie materiali, non è senza conseguenze reali: perché la cosiddetta Madre del Libro è un attributo di Dio, come l’Onnipotenza e l’Onniscienza: e come tale, il Corano non può essere, a rigore, né commentato né chiosato né interpretato. Questo ci ricordano jihadisti, terroristi e integralisti. E i moderati possono fare ben poco per smentirli senza commettere un sacrilegio imperdonabile. Ci sono islamici che si appellano alla taqyya, la dissimulazione quando devono convincere gli infedeli per ragioni apologetiche o di opportunità politica: ma la teologia islamica non può fare molto. Per questo non c’è una fonte autorizzata della dottrina, nell’Islam. Perchè non ci possono essere discussioni, ma solo “sottomissione”.
E questo spiega anche perché con l’Islam, al di là di espressioni di buona volontà che rimangono di carattere squisitamente ‘politico’, un vero dialogo è, se non impossibile, inutile.
Nulla di male. Anzi! Torniamo a discutere, con gli islamici come con tutti, in termini di politica e di diritto: e non si sottoponga il confronto su queste cose alle censure del politicamente corretto, che ripropongono sul terreno delle decisioni politiche interdetti e divieti che falsano ogni dialogo, rendendolo vacuo, inconcludente, inefficace.