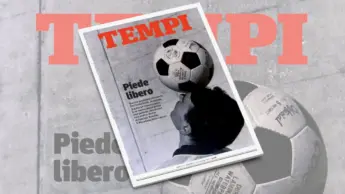
Per vestire un papa ci vuole umiltà

Articolo tratto dal numero di settembre 2020 di Tempi. Questo contenuto è riservato agli abbonati: grazie al tuo abbonamento puoi scegliere se sfogliare la versione digitale del mensile o accedere online ai singoli contenuti del numero.
È tutta vene, lava, sorgenti, spirito e agguati la storia di Filippo Sorcinelli, impagliarla in tre righe di biografia pare un delitto ma tant’è: artista poliedrico, imprenditore, pittore, musicista, direttore creativo, fotografo, graphic designer, ma soprattutto “sarto dei papi”, “stilista di Benedetto e Francesco”, eccoli, son tutti questi i sinonimi di “Sorcinelli” nel mondo. Ma non si può costringere un creativo così fuori dal branco nella brevità di una didascalia: il fatto è che Filippo Sorcinelli non somiglia a nessun altro indossatore di lauri e allori, è purosangue, materia e artigianato. C’è chi lo ha descritto con la barba di Rasputin, aura di serenità da monaco zen e un viso pallido che ricorda l’autoritratto di El Greco nei panni dell’apostolo Matteo, chi gli ha riservato il brusco trattamento elargito di default ai fornitori ufficiali (carica per altro inesistente) della Santa Sede, chi ha cercato di rinserrarne l’animo e il corpo solcato da tatuaggi di linee rette e incroci geometrici silenziosi nelle mille sfumature di un solo aggettivo: underground.
Quanto a noi, abbiamo incontrato un uomo vivo, che dalla sommità del campanile del duomo di San Martino a Lucca – gli occhi sul tappeto di tetti illuminati dal sole di fine estate – appena inizia a raccontarsi ci porta subito dalle “sue parti”, oltre gli Appennini, a Mondolfo, la verde fortezza adriatica gallopicena sorta nel fazzoletto di terra di Pesaro e Urbino. Non sotto alle possenti mura del bastione di Sant’Anna, in quel dedalo di vicoli stretti che portano alla torre dell’orologio, non sulla dorata spiaggia di Marotta inchinata sotto il castello: Sorcinelli parla, anzi, narra, e mentre narra ci ritroviamo all’inizio degli anni Ottanta nella Collegiata di Santa Giustina, indossiamo le pupille aguzze di un bambino del borgo natale, uno dei più belli d’Italia.
E che c’è intorno? Silenzio, si sente armeggiare in lontananza la mamma Gina alle prese con le pulizie settimanali, la chiesa illuminata a giorno si lascia attraversare docile dalla sagoma del ragazzino. Quante volte ha scrutato la pala dell’altare maggiore, guardato negli occhi la Madonna col bambino e i santi Giustina e Lorenzo, riconosciuto nel crocifisso la consistenza e lo strazio di un uomo reale, sbirciato e sfiorato quadri, sculture, candelabri e tesori barocchi profumati di incenso, quante volte ha avvicinato il naso al turibolo, socchiuso gli armadi della sacrestia, ed è salito per le scale tortuose a spiare il grosso mostro polveroso addormentato nella cantoria sopra l’ingresso principale, l’organo storico “Gaetano Callido”, opera 166 datata 1776. «Tutto è nato così. Da questo osservare, comprendere, respirare, toccare, aprire, immaginare in un luogo sacro che sopravvive in me anche oggi, qui, tra questi merli ghibellini nel cielo toscano», racconta a Tempi.
Santa Giustina, come mamma Gina, come Mondolfo, le croci, le pietre e i profumi Filippo Sorcinelli se li sarebbe in fretta portati con sé, nel sangue, a New York, Parigi, Gerusalemme, di quel bambino del borgo non avrebbe perso un solo battito di ciglia. Ma è necessariamente a quel luogo e all’infanzia che bisogna tornare, oggi che Sorcinelli sfiora i 45 anni, per capire che ci azzecchi la forbice che taglia la veste papale con il magma sversato in ogni sua installazione, l’odore della nebbia con il fumo di una cattedrale a fuoco, il sangue che scorre tra le macerie di un paese dell’Appennino divorato dal terremoto con le maison dei profumi d’eccellenza.
«Ciao, sto per diventare prete»
«Il fatto è che sono svenuto. Proprio così». Le cronache assegnano a Sorcinelli il titolo di organista fin dall’età di 13 anni – non male per uno che si sarebbe laureato al Pontificio Istituto di Musica sacra a Roma e che avrebbe suonato nelle cattedrali più belle d’Italia e del mondo – ma quando cadde a terra era solo un pischello. «Avrò avuto 7, 8 anni, ricordo che era la Domenica delle palme: il prete ci porta in gita alla chiesa di San Vito. Stiamo ascoltando un frate parlare di Quaresima quando questi si siede all’organo. Io non avevo mai sentito suonare un organo a canne. Insomma, appena inizia io perdo letteralmente i sensi e crollo giù sul pavimento. “Sarà stata solo l’emozione”, mi dicono appena mi riprendo. “Non credo”, penso, sopraffatto dall’incontro con un suono che mai avevo udito, e che mi aveva rapito l’anima e le cellule come una promessa misteriosa. Da quel giorno l’organo non ha mai smesso di chiamarmi».
Insomma, in capo a cinque anni Sorcinelli è organista a Rimini, Fano e San Benedetto del Tronto, si specializza presso il Conservatorio Rossini di Pesaro – in mezzo il diploma di maestro d’arte all’Istituto di Arte di Fano, l’enorme amore per il genio di Alberto Burri, la fiamma ossidrica usata come pennello, le tele coperte da sacchi di iuta lacerati come le ferite suturate da un medico in tempo di guerra, la materia sofferente, bruciata della terra incisa dall’artista di Città di Castello «col coltello infinito dell’anima» – e poi, finalmente, Roma. Arte, musica sacra, materia e spirito: qual è l’ombelico della mia vita, il punto infallibile, inevitabile?, si chiede Sorcinelli mentre, finiti gli studi e l’anno giubilare 2000, si prepara a tornare nelle Marche. È allora che arriva quella telefonata.
«È un vecchio amico, non ci vediamo da tempo, mi racconta un po’ di cose e poi arriva al punto: “Volevo dirti che tra sei mesi divento sacerdote”. E come reagisco io? Di getto, gioioso, gli dico: “Ti prego, non comprare niente, ti voglio fare un regalo, preparo tutto io”. Mi precipito quindi nella bottega che mia zia e mia sorella avevano aperto in centro a Mondolfo: un po’ sartoria, un po’ boutique cittadina, sono state loro a insegnarmi a tagliare e cucire. Morale, inizio a fare un po’ di ricerca sulla materia prima, i paramenti, i materiali per la litugia del culto cattolico, inizio a creare qualcosa di mio per qualcuno». È il 2001: da una telefonata inaspettata nasce Lavs, l’Atelier dei Paramenti sacri.
A tu per tu con Ratzinger e Bergoglio
Sì perché quel primo manufatto inizia a fare il giro della provincia, a suscitare curiosità, e Sorcinelli riceve una seconda telefonata: chiamano da parte del suo primo cliente, un certo Angelo Bagnasco, diventato vescovo di Pesaro. «Non sapevo, mentre lavoravo attorno alla creazione di una mitra, che dalla stoffa tagliata sarebbe scaturita una stima che, sì, mi avrebbe portato in Vaticano, ma soprattutto un’amicizia piena di significato per la mia vita. Nel mondo dell’arte, della moda, che inziai presto ad abitare, è quasi scontato smarrirsi, perdere qualcosa. L’amicizia e il confronto onesto con il cardinale Bagnasco mi servono a ritrovarmi, a ricordarmi chi sono e per cosa lavoro. A richiamarmi sempre al rispetto dell’altro per essere vero e libero, a ricordarmi che l’arte è libera e piena di senso se ha in sé un destino, se nasce o si esprime in un incontro».
Quello con Benedetto XVI avviene nel 2007. Sorcinelli ha vestito negli anni vescovi e alti prelati, il suo atelier sorge ora a Santarcangelo di Romagna, quando arriva ancora una volta una telefonata: è il cerimoniere del Papa, lo invita a Roma per vestire il Pontefice. Questo incontro, a cui ne seguirono tanti altri, personali, Sorcinelli lo serba per sé: «Vestire l’erede di Pietro, creare qualcosa che sia segno della gloria di Dio e del dono ricevuto per gli uomini, esprimere la bellezza del Creatore richiede stupore, preparazione ma soprattutto umiltà. Se da un lato il confine tra sartoria sacra e costume teatrale è sottile, dall’altro la veste papale deve trasmettere un messaggio verticale, trascinare il fedele verso l’alto: non puoi mondanizzare o livellare, semplificandola, la figura di un pontefice. Quanto al resto, preferisco custodire ciascuno degli incontri con Ratzinger e Bergoglio», dice senza tradire un briciolo di vanità o ostentazione, solo gratitudine. «Posso solo dire, commosso, che di quel primo incontro mi colpì la modestia, quasi timidezza, dell’uomo che avevo davanti, il più colto e sensibile che mai mi avesse rivolto la parola».
Sorcinelli realizza casule, dalmatiche, piviali, mitre, camici, veste papa Benedetto. Ed è sua la casula indossata da papa Francesco per la messa d’inizio pontificato nel 2013: i due si sono incontrati il venerdì e 150 ore dopo, ore di lavoro ininterrotto a Santarcangelo, la veste di seta bianca, con i quattro agrimani, i dodici fiocchi alla stola a ricordare la successione apostolica, viene consegnata la mattina del lunedì a Roma.
Fotografia e note
Quello stesso anno Lavs partecipa alla mostra “San Girolamo“ del pittore francese Georges de La Tour, a Vic sur Seille: secondo il Museo del Louvre, Sorcinelli ha riprodotto esattamente due dei paramenti presentati nel dipinto. Sì perché oltre agli uomini di fede che da New York a Gerusalemme si affidano alle mani del “sarto dei papi”, ci sono i musei che di questo insolito artista cristiano desiderano esporre opere e creazioni. Sempre nel 2013, sempre a Sorcinelli viene affidato il compito di ricostruire i paramenti sacri in occasione della Ricognizione delle spoglie di papa Celestino V all’Aquila.
Non smette mai di suonare l’organo: «È parte di me anche quando sta in silenzio». Diventa direttore artistico di molti festival musicali; dipinge, lavora con artisti contemporanei, realizza installazioni, coagulando magma materico e battaglie quotidiane, ricercando una sorta di redenzione a «sofferenze, dolori e cicatrici che fanno parte della mia esistenza», impasta e riplasma a vita nuova; realizza video che precipitano in luoghi neri e fatali, quasi dovesse liberare e al contempo domare il demone dell’arte che tutto vorrebbe fagocitare fino all’ultimo brandello di carne, osso, vena; fotografa la nebbia, che dal primo vagito tra le colline marchigiane conosce e gli appartiene, «la seguo nelle fabbriche abbandonate, nei boschi, sul mare, raccogliersi nel paesaggio mutandolo senza toccarlo, materia impalpabile che dissotterra in noi domande, malinconie e attese di infinito».
La stessa materia intoccabile che il ragazzo di Santa Giustina riconosceva sacra nel profumo di incenso e che Sorcinelli ha cercato di catturare quando ha fondato il brand che porta il suo nome, tecnicamente una maison di profumi d’eccellenza, nella realtà una vera e propria sartoria olfattiva. «Dalle scatole profumate per la consegna delle vesti sacre alla ricerca di fragranze che c’entrassero con la mia storia, il passo è stato breve. Sono un organista, non ricordo un momento di felicità pari a quello che ho vissuto una notte del 2009, quando ho potuto suonare da solo l’organo di Notre-Dame, la magnifica e gloriosa cattedrale dalle volte ardite. Quando, dieci anni dopo, l’ho vista bruciare, ho vissuto un dolore immenso, ma anche il bisogno cristiano di affermare che dalla cenere rinascono fede e monumenti, che anche questo dolore poteva essere salvato». Sorcinelli crea un profumo, “Notre-Dame 15.4.2019”, per destinare tutto il ricavato delle vendite a Musique Sacrée, l’associazione che cura la musica nella cattedrale di Parigi e le attività della Maîtrise, l’insieme di cantori e di musicisti che ne custodiscono il patrimonio inestimabile.
Un’estate «uguale a nessun’altra»
Prendere parte a una rinascita: lo aveva già fatto pochi anni prima, quando le sue Marche vennero squassate dal terremoto; aveva creato “Epicentro” per devolvere il ricavato al piccolissimo paese di Bolognola, 138 abitanti tra i Monti Sibillini divorati dal sisma del 2016 e 2017, un contributo che l’artista non smette di versare ogni anno, «fedele a un piccolo gesto».
Un’essenza Sorcinelli l’ha dedicata anche a un altro dei suoi padri artistici, Mario Giacomelli, il grande fotografo italiano mancato nel 2000. Sorcinelli lo incontra a Senigallia in una tipografia che sa di tabacco e inchiostri della macchina da stampa grazie a Lorenzo e Anna, proprietari di una serigrafia a Mondolfo («a loro, come ai miei maestri d’arte, devo l’amore per l’arte contemporanea ma soprattutto il mio desiderio di bellezza»). Il profumo si chiama “Io non ho mani che mi accarezzino il volto”, un verso di David Maria Turoldo scelto da Giacomelli stesso per battezzare una curiosa serie di foto. Siamo nel 1961: Giacomelli, col permesso della curia, sta facendo un servizio su un gruppo di giovani studenti del seminario vescovile di Senigallia, momenti di svago, di studio e di preghiera, preti che giocano a palla, stretti nei mantelli tra la neve, mentre fanno il girotondo in cortile. Una domenica porge ai ragazzi dei sigari, inizia a scattare e – apriti cielo – per aver portato scompiglio (quegli scatti diventeranno famosissimi) in un luogo di ordine e disciplina viene bandito, con la fedele Bencini Comet S del 1950, dal seminario.
«Quest’estate è stata per me la terza da direttore artistico del Synesthesia Festival». Sorcinelli racconta paziente a noi non addetti ai lavori cosa sarebbe un festival multisensoriale senza alcun precedente in Italia e a cui l’artista ha deciso di dare vita nella sua Mondolfo. «Solo che questa estate non è stata uguale a nessun’altra. Una pandemia non è amica dell’uomo e dei cinque sensi, di degustazioni, performance, dibattiti, dell’arte come incontro. Ho puntato quindi tutto sulle arti visive, cercando di fare di Mondolfo un museo a cielo aperto, una “galleria senza soffitto” che desse spazio alla poesia dello sguardo di Giacomelli, le sue foto ricollocate tra le vie del borgo insieme alle parole di suo figlio Simone».
In questi mesi di paura e confusione, «squarci nella notte e solitudine, di cicatrici, corpi sofferenti e monumenti a Dio bruciati», Sorcinelli ha cercato ciò che tiene e terrà in eterno. «C’è tanta bellezza», dice l’artista che tutti hanno cercato di imbrigliare in una definizione scrutando tetti, paesi e colline che costellano la via Francigena dalla torre campanaria di San Martino, «tutto può essere salvato».
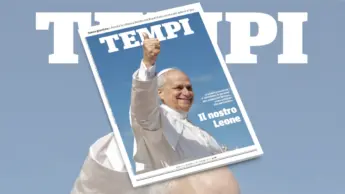


0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!