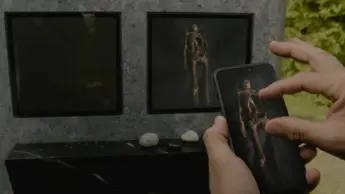
Il nichilismo poetico-esistenziale che ci spinge a chiedere Dio


Caro direttore, da quando l’Occidente è sotto attacco, si parla molto di nichilismo. La malattia dell’Occidente contemporaneo, si dice, è il “nichilismo”, che poi è l’altra faccia dell’edonismo ateo-materialista. Indubbiamente, l’uomo occidentale post-moderno non crede più in nulla, a parte il piacere immediato. Tuttavia, credo che nel nichilismo occidentale ci sia anche del buono o, meglio, credo che esista anche un nichilismo buono accanto a quello cattivo. E credo che questo nichilismo buono sia di gran lunga preferibile ai surrogati del senso spacciati, come droghe pesanti, sia delle ideologie totalitarie atee (soprattutto il comunismo) sia delle ideologie totalitarie religiose (il fondamentalismo jihadista).
In linea di massima, si può distinguere fra un nichilismo orientale e due tipi di nichilismo occidentale: uno super-oministico ed uno poetico-esistenziale. Se i primi due sono radicalmente anti-cristiani e quindi meritano una condanna senza appello, il terzo può avvicinare, sia pure molto indirettamente, alla fede. Per farla breve, il nichilismo orientale, che passa attraverso il manicheismo tardo antico e l’eresia catara medievale, è l’odio assoluto per la carne e per la creazione di Dio. È una bestemmia. Molti studiosi hanno notato che, effettivamente, ci sono alcune analogie fra l’eresia catara (che devastò vaste regioni d’Europa fra il XII e il XIV) e il fondamentalismo jihadista. Come catari medievali predicavano il suicidio e l’omicidio come strumenti per liberare se stessi e il prossimo dalla “prigione del corpo”, così oggi i jihadisti uccidono se stessi pure di riuscire ad uccidere il maggior numero di nemici. Il loro è il nichilismo dell’inferno: «Noi amiamo la morte più di quanto voi amate la vita». Se la amano così tanto, rischiano di tenersela per l’eternità.
Se il nichilismo orientale si basa ancora sulla contrapposizione manichea fra la materia (intesa come male assoluto) e lo spirito (inteso come bene assoluto), invece il nichilismo super-oministico di filosofi come Friedrich Nietzsche e Jean-Paul Sartre si basa sul materialismo assoluto. Nei loro scritti non fanno che ripeterti che Dio non c’è e che la vita umana non ha alcun senso, ma non ne sembrano veramente dispiaciuti. Infatti, l’assenza di Dio e di ogni senso diventa il pretesto per fare dell’uomo un dio terreno cui nessun piacere deve essere negato (e siamo all’edonismo assoluto) e pure un superuomo cui è lecito opprimere i deboli ossia i “sotto uomini” (impossibile continuare a nascondere che Nietzsche ha gettato le fondamenta del nazismo).
Se il nichilismo super-oministico è una filosofia sistematica, invece il nichilismo esistenziale è piuttosto un sentimento poetico, che emerge in molte delle migliori opere letterarie e cinematografiche degli ultimi cento anni. Se il primo nega il senso per fare dell’uomo il creatore del senso, il secondo piuttosto avanza una domanda di senso cui non giunge mai una risposta. Se il primo è espressione di superbia, il secondo è espressione di un senso religioso drammaticamente inappagato. Anche quando nega la possibilità che quel senso possa esistere, il nichilista esistenziale continua a desiderare che quel senso esista e gli venga incontro. Ma il desiderio di qualche cosa, qualunque essa sia, non depone forse a favore dell’esistenza di quella cosa? Come potremmo infatti desiderare, sentire la mancanza e dispararci per l’assenza di qualcosa che non esiste? Noi possiamo avere sete perché l’acqua esiste. Anche se stessimo morendo di sete in un deserto, non potremmo dire che l’acqua non esiste.
Vorrei fare una piccola apologia del nichilismo esistenziale nel cinema. La mia impressione è che, alla base della maggior parte dei più grandi capolavori, universalmente riconosciuti, del secolo scorso, ci sia proprio il nichilismo esistenziale. Di due di questi capolavori esistenziali ho già parlato: Il Settimo sigillo (Ingmar Bergman, 1957) e Blade Runner (Ridley Scott, 1982). Adesso vorrei parlare di altri due film, uno del secolo scorso e uno recentissimo: La rosa purpurea del Cairo (Woody Allen, 1985) e The Zero Theorem (Terry Gilliam, 2013). Il primo ha appena festeggiato il trentennale mentre il secondo, presentato a Cannes nel 2013 e mai arrivato nelle sale, è disponibile in streaming da pochi giorni.

La rosa purpurea del Cairo è probabilmente il capolavoro di Woody Allen. In nessun altro film, in tutta la storia del cinema, si è mai realizzata la stessa perfetta sintesi fra il dramma e la commedia brillante, fra l’esistenzialismo e la comicità. La vicenda ruota attorno allo schermo di un miserabile cinema del New Jersey, dove viene proiettato un immaginario film dal titolo, appunto, La rosa purpurea del Cairo. Fra la gente del pubblico c’è Cecilia (Mia Farrow), una donna di bassa estrazione sociale che lavora duramente per mantenere sé stessa e un marito anaffettivo e fannullone (Danny Aiello), che pensa solo a ubriacarsi e a divertirsi con gli amici. Uno dei personaggi del film (Tom Baxter, interpretato da Jeff Daniels) rimane colpito da Cecilia, esce dallo schermo e fugge con lei dal retro del cinema. In attesa che Tom, “esploratore e poeta”, torni al suo posto, tutti gli altri personaggi si riuniscono in uno dei lussuosi set del film e discutono sul da farsi fra di loro e con la gente in sala.
Al cuore del film c’è il tema del contrasto fra il sogno e la realtà. Possiamo distinguere fra due gruppi fondamentali di sogni: quelli inconsapevoli e quelli consapevoli. I primi sono quelli che si fanno di notte ad occhi chiusi, i secondi sono quelli che si fanno di giorno ad occhi aperti. I primi sono molto enigmatici, non sono necessariamente felici, a volte possono essere addirittura spaventosi (e allora si chiamano incubi). I secondi, invece, sono tutti e per definizione felici: in essi l’individuo diventa per magia quello che vorrebbe essere nella vita reale e gli capita tutto quello che vorrebbe gli capitasse nella vita reale. Per rimanere in tema, sono come film immaginari, proiettati dentro la mente, di cui l’individuo è autore, regista e attore protagonista. Ebbene, la letteratura e il cinema più commerciali cercano precisamente di riflettere i sogni ad occhi aperti della maggior parte della gente e, allo stesso tempo, suggeriscono alla gente che cosa sognare. Sebbene assuma una diversa identità e diverse caratteristiche in ogni romanzo, il protagonista assoluto della letteratura rosa, venduta all’ingrosso un tanto al chilo in tutte le edicole, è l’archetipo platonico dell’uomo sognato da tutte le donne o quasi (su questa mediamente pessima letteratura e su quest’uomo archetipico sono stati versati fiumi di inchiostro). Similmente, la maggior parte delle commedie americane di ieri e di oggi si svolgono nel mondo dei ricchi, perché la maggior parte della gente sogna di essere più ricca di quello che è, di frequentare gli ambienti che contano e di incontrare uomini affascinanti e donne bellissime. L’omonimo film in bianco e nero che viene proiettato all’interno di La rosa purpurea del Cairo è stato concepito da Woody Allen come una caricatura delle classiche commedie chic degli anni Trenta, le cui trame banali e ripetitive sono costellate da party dell’alta società e viaggi esotici.
I personaggi in bianco e nero di questo film nel film sono tanto irreali quanto ridicoli. Se al di qua dello schermo (dove prevalgono i colori della ruggine e del fango) la gente cerca di sopravvivere alla grande depressione economica degli anni Trenta, al di là dello schermo (dove il bianco e nero ha lo splendore dell’argento) dei ricchi frivoli e svagati, stanchi di party e serate al teatro, cercano rimedio alla noia fra le piramidi egizie. I battibecchi fra questi ricchi immaginari, che vorrebbero tanto diventare reali, e la gente reale in sala, che vorrebbe tanto entrare in quel mondo irreale, sono esilaranti. Anche il fatto che nessuno provi stupore e senta il bisogno di cercare le cause della fuga prodigiosa di uno dei personaggi suscita ilarità. Gli spettatori in sala si lamentano perché sullo schermo i personaggi stanno fermi a chiacchierare tutto il tempo, i gestori si lamentano perché perdono incassi e i produttori del film si lamentano perché la fuga di uno dei loro personaggi dà scandalo e potrebbe rovinare i loro affari. Intanto, al di fuori del cinema, l’inesperto Tom, che non sa nulla del mondo reale, diventa protagonista di una serie di gag divertenti e raffinate, quali solo Allen poteva concepire. Ad esempio, quando bacia Cecilia, Tom si aspetta che ci sia “la dissolvenza”.
Tom, che è appunto l’incarnazione (anzi la pseudo incarnazione virtuale) del tipico uomo ideale da romanzo rosa, ama Cecilia in maniera sincera e appassionata, non è capace di compiere una sola cattiva azione e ha sempre un aspetto impeccabile («è questo uno dei vantaggi di essere immaginario», dice). Ma quest’uomo dei sogni, che si profonde continuamente in mielose dichiarazioni d’amore per Cecilia, appare anche vagamente stucchevole. In generale, i sogni ad occhi aperti e i personaggi che li abitano alla lunga stancano. Essendo infatti nostre idee, non hanno mistero. Inoltre, i sogni non modificano la realtà. Anche se è entrato nella realtà, Tom non riesce a diventare reale.
In conclusione, nella visione di Woody Allen sogno e realtà rimangono l’uno di fronte all’altra, come due mondi separati e ugualmente privi di speranza. Il mondo reale è segnato dal male fisico e morale mentre il mondo dei sogni, oltre ad essere un po’ ridicolo, è privo di realtà ed è incapace di incidere nella realtà. Chi passa tutto il suo tempo a sognare ad occhi aperti, non si impegnerà per rendere la realtà che lo circonda un posto più abitabile. Ma la scena finale del film, che è una delle scene più amare di tutti i tempi, sembra suggerire che l’unica possibile gioia su questa terra sia la gioia illusoria del sogno (e vengono in mente le “illusioni” di Giacomo Leopardi, nichilista nel senso più nobile del termine).
Attraverso i suoi film, Woody Allen delinea una visione moderatamente nichilista (se così si può chiamarla) secondo cui solo la passione sessuale, sebbene non sia meno illusoria delle immagini che appaiono e compaiono sullo schermo di un cinema, può dare alla vita un po’ di senso. E quando una passione finisce, se ne può accedere subito un’altra (è questo il “messaggio” di Tutti dicono I love you, film di Allen del 1996). Ma alla fine, la sequenza delle illusioni e delle delusioni si arresta di fronte alla morte, che appare come la fine di tutto. Allen stesso ha più volte dichiarato che cerca di lavorare senza tregua solo per non pensare al fatto che dovrà morire. E a giudicare dal fatto che nella sua carriera ci ha donato la bellezza di quarantacinque film, quasi tutti di alto livello, la morte deve fargli davvero molta paura.
Ma oltre al nichilismo, forse ad insaputa dello stesso autore, nel film c’è pure l’intuizione del senso religioso. Tom è sì incapace di diventare reale ma è comunque capace di dare a Cecilia tutto l’amore che lei non ha mai potuto ricevere da nessuno. È stata lei, col suo desiderio inappagato di amore, a estrarre Tom dallo schermo e a dargli una apparenza reale. Il dramma della vita è che nessuno riesce a ricevere tutto l’amore di cui ha bisogno e nessuno riesce a darlo agli altri. Chi può dare all’uomo questo amore totale e incondizionato, se non Dio? A noi, quest’uomo che scende dal mondo dei sogni per entrare nel mondo reale ci fa pensare ad un altro uomo, che scese dal cielo e poi ne ascese.

The Zero Theorem di Terry Gilliam è un film straordinario, sebbene è lontano dall’essere un capolavoro assoluto. Terry Gilliam riprende il discorso distopico che aveva iniziato nel 1985 con Brazil e lo aggiorna. La società immaginaria in cui si svolge la vicenda del film del 2013 sembra essere la stessa in cui si svolgeva la vicenda del film del 1985, ma parecchi anni dopo. Se infatti la società di Brazil si collocava «da qualche parte nel XX secolo», invece quella di The Zero Theorem si svolge in un futuro a noi prossimo, fin troppo simile al presente, o forse in un presente parallelo. In questo mondo bizzarro, le tecnologie informatiche saturano ogni spazio e risucchiano nell’universo virtuale della rete i fragili io delle persone, che non se ne distaccano neanche quando camminano per strada (sono letteralmente inseguite da messaggi pubblicitari virtuali). Ma sebbene più avanzate, complicate e bizzarre, le apparecchiature informatiche che appaiono nel film sono le stesse che già ci circondano da ogni parte e che impegnano la maggior parte del tempo della nostra giornata. Non passiamo più tempo sui social-network che nel mondo reale, anche quando camminiamo per strada?
Dal punto di vista estetico, le scenografie di The Zero Theorem sono costruite sulla base dei principi dell’estetica post-moderna, che impone accostamenti eclettici fra stili diversi. Come in Blade Runner, film postmoderno per eccellenza, in The Zero Theorm edifici nuovi stanno accanto ad edifici antichi e fatiscenti, tecnologie nuove stanno accanto ad oggetti ed arredamenti demodé. Certo, non si può pretendere che la visione futuristica di The Zero Theorem, film a basso costo, possa avere la stessa grandiosa magnificenza che aveva la visone di Blade Runner, senza contare che nel 1982 i contrasti post-moderni erano nuovi e quindi apparivano sorprendenti, mentre oggi appaiono un po’ convenzionali.
Come in Brazil, la maggior parte dei personaggi secondari appaiono grotteschi, alcuni perfino caricaturali. Figli di una società il cui unico valore è l’efficienza nel produrre e nel consumare, sono quasi sempre intenti a fare cose stupide e a perdersi in chiacchiere insensate. Per quanto riguarda Brazil, come dimenticare la madre di Sam, che cianciava di regali di Natale e di chirurgia estetica portando in testa un inverosimile ed eloquente cappellino a forma di scarpa? Se il protagonista di Brazil lavorava in un gigantesco e labirintico ente pubblico, in The Zero Theorem Qohen (Christoph Waltz) lavora per la Mancom, una corporation legata al settore informatico. Il potente e inarrivabile capo della Mancom (Matt Damon) obbliga Qohen a lavorare alla soluzione del misterioso “teorema zero”, che ha a che fare col secondo principio della termodinamica. È difficile capire che cosa sia esattamente questo teorema e in che maniera possa favorire gli affari della Mancom, ma in realtà non serve capirlo. Quello che importa, è che nel corso del film lo “zero” diventa sempre più invadente, fino a rivelarsi come il significato di tutto. Nella visione di Gilliam, non solo l’universo fisico ma anche la vita individuale è soggetta all’entropia, che discioglie tutti gli accadimenti in un caos senza storia e senza destino. Quindi, l’unica cosa sensata da fare è fuggire da questo caos insensato e rifugiarsi nei sogni, che le tecnologie virtuali possono amplificare.
Ma oltre a questo messaggio radicalmente nichilista (che effettivamente appare troppo palese, quindi cerebrale) c’è anche qui, come nel film di Allen, una inconsapevole intuizione del divino. In maniera significativa, Qohen abita in una vecchia chiesa sconsacrata, adornata da antichi affreschi, in cui elementi di arredamento, oggetti di ogni genere e rifiuti si affastellano col massimo disordine (implicito il richiamo alla casa di J. F. Sebastian di Blade Runner). In quella che era la casa del Signore, ma da cui il Signore è stato “sfrattato”, Qohen non riesce ad avere fede in nulla ma vorrebbe tornare ad averla. Egli, che si riferisce a sé stesso con un impersonale “noi”, che non sopporta la compagnia di nessuno e che non riesce più a provare piacere per nessuna cosa, ha quasi paura di uscire dalla sua casa-chiesa e di starne lontano anche solo per un’ora. Infatti, vive aspettando una misteriosa telefonata sul suo telefono fisso. In passato infatti una persona misteriosa, gli aveva promesso per telefono che, in un momento imprecisato del futuro, lo avrebbe richiamato per rivelargli l’unica cosa che Qohen desidera conoscere: il senso della sua vita. Nell’interminabile attesa di questa telefonata, qualcosa succede: un ragazzo e una giovane donna entrano imprevedibilmente nel recinto della sua solitudine e riescono a fargli riscoprire, almeno in parte, il piacere dell’amicizia e la gioia dell’amore. Non è di un discorso filosofico sul senso della vita, ma di una amicizia concreta, che il senso lo porti materialmente, che abbiamo bisogno.
Articoli correlati
17 commenti
I commenti sono chiusi.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!



Giovanna Jacob -“Da bravo laicista sinistrese. Michele interpreta marxisticamente il jihadismo come “reazione” del proletariato del Terzo Mondo allo (immaginario) sfruttamento politico-economico che subirebbe da parte dell’Occidente.”
Giovanna Jacob, non creda di poter inquadrare così facilmente i miei pensieri. Laicista è una definizione che mi può competere (in quanto credo nel fatto che nessuna religione debba avere ingerenza nella cultura, nella politica e nelle libertà dei cittadini di una nazione), ma non sono “sinistrese”.
Inoltre non ho affermato che questo sia il mio punto di vista. Ho solo citato una delle motivazioni che viene spesso fatta frullare nelle teste di coloro che credono di combattere una “Santa e Giusta Jihad” contro “l’Occidente del Demonio”. Non è forse una novità che, come qui da noi molti si prodighino per dipingere loro come il Demonio in persona, lo stesso si faccia anche dall’altra parte della barricata. E se le ragioni per muovere una “guerra” sono sempre di natura politica o economica per quanto riguarda coloro che muovono le fila, sono molti i giovani o gli ingenui che si bevono questa storiellina della lotta contro “l’ingerenza occidentale”. Raramente una persona è convinta di combattere per una cattiva causa… la presunzione umana è sempre quella di essere dalla parte del “Giusto”. Questa illusione appartiene anche ai “jihadisti”.
Giovanna Jacob, sulla questione ebraica non si registrano persecuzioni nei confronti degli ebrei da parte dei cristiani. Prima dell’avvio della Prima Crociata, nel 1096, si verificarono ben pochi episodi di vero e proprio antiebraismo popolare . In tutta Europa si insediarono colonie ebraiche, specialmente all’interno dell’impero carolingio,e gli ebrei furono molto attivi come mercanti, funzionari, medici, artigiani e persino proprietari terrieri . A livello ufficiale, compresi vescovi e rabbini, i rapporti tra Ebrei e Gentili erano improntati alla tolleranza, e talvolta persino alla cordialità. E di questo va reso atto.
GIOVANNA JACOB – David G. Dalin (autore di “La leggenda nera del papa di Hitler”, Piemme) sostengono che i paesi in cui gli ebrei si sono sempre trovati meglio, fra tutti i paesi del mondo, sono i paesi cattolici (Roma la chiamano addirittura “il paradiso degli ebrei”).
Per onestà storica però citiamo anche un altro paradiso degli ebrei, che fu la Spagna Moresca.
Cito il libro Storia dell’Olocausto di Klaus P.Fischer, ma in generale è fatto storicamente risaputo:
“Fu proprio nella Spagna moresca che gli Ebrei trovarono uno dei pochi paradisi della loro storia lunga e travagliata, anche se questo paradiso non sarebbe sopravvissuto alla riconquista cristiana della Spagna, nel XV Secolo.”
Ovviamente non si deve nemmeno scadere nel mito di una “convivencia” andalusa idilliaca e utopica.
Il massacro della popolazione ebraica di Granada del 1066 vale giusto come aneddoto antiutopistico.
Come vede, Giovanna Jacob, non sono incline verso alcuna tifoseria di parte. Quello che infatti rimprovero ai più sono le partigianerie di parte: una conscia o inconscia attitudine a volere dipingere la propria tifoseria sempre dei colori più belli possibili (anche a costo di edulcolare palesi sbagli, difetti e mancanze del passato), mentre in un modo o nell’altro si cerca di far passare “l’altra parte” (qualunque essa sia) come quella culturalmente “inferiore” o “sbagliata” rispetto alla nostra, “l’unica vera e giusta, sempre e comunque”.
Io al massimo posso difettare di tanto in tanto in termini di conoscenze storiche, ma ci tengo sempre alla verità storica (ammesso che essa sia oggettivamente possibile), anche a costo di dover cambiare completamente idea preconcetta. Quindi consulterò anche le sue fonti, essendo mia abitudine “ascoltare il suono di qualsiasi campana”.
Riguardo quello che so attualmente posso continuare dicendo che o scatto decisivo nella direzione dell’odio popolare verso gli ebrei si ebbe , come abbiamo già osservato , con la I Crociata , nel 1096 . Prima di procedere al loro viaggio in Terrasanta per cacciarne gli infedeli , bande di predoni fanatici massacrarono circa diecimila ebrei innocenti nella Francia e nella Germania settentrionali , accendendo quell’odio irrazionale per gli ebrei che si sarebbe in seguito ripetuto sotto l’impatto delle varie crisi che i cristiani non furono capaci di risolvere . Particolarmente insolita , nel 1096 e nelle successive crociate o rivolte dell’Europa medioevale , fu la natura “chimerica” dell’odio che era riversato sugli ebrei , un odio che era interamente fondato su un numero crescente di convinzioni delusionali a proposito degli ebrei e della loro malvagità . Le autorità secolari ed ecclesiastiche si opposero ufficialmente a questi scoppi di violenza popolare , ma la loro intrinseca ostilità agli ebrei le rese distanti e ambigue nei momenti di crisi , e quindi incapaci di – o non disposte a – arginare la marea di atti omicidi antiebraici . Il papato oscillava tra l’opinione espressa da Gregorio I , il quale insisteva che “i non credenti dovessero essere trattati con gentilezza e persuasi con ragionamenti chiari e presentati in modo gradevole”, opinione poi riaffermata in bolle papali in cui si affermava che “gli ebrei avevano diritto a vivere nelle società cristiane”, e i pronunciamenti più stridenti di papi come Innocenzo III (chi si rivede!) o dei Conelli Laterani, che dichiararono gli ebrei schiavi dei cristiani (Concilio Laterano III , 1179) o li segregarono socialmente , costringendoli a vestirsi in modo diverso e definendoli “blasfematori del nome cristiano” (Concilio Laterano IV , 1215) .
Senza sporcarsi le mani , le autorità secolari ed ecclesiastiche , proibirono agli ebrei di possedere terra, li esclusero dalle corporazioni e li confinarono in occupazioni disprezzate e marginali come il prestito di denaro , la vendita ambulante e il commercio di seconda mano.
Ecco cosa scrive sugli ebrei uno degli antichi Padri della Chiesa, Gregorio di Nissa
“Assassini del Signore, uccisori dei profeti, essi si oppongono alla grazia, ripudiano la fede dei loro padri. Soci del Demonio, razza di vipere, delatori, calunniatori, oscuratori delle menti, fermento farisaico, Sinedrio del Demonio, maledetti, detestati, nemici di tutto ciò che è bello”. [fonte: The History of Anti-Semitism, Vol I, New York 1965, p. 25. L. Poliakov]
Non sostengo l’idea che la Chiesa cattolica sia stata promotrice continua e assidua di idee antisemlite (che però risalgono indietro fino appunto ai tempi di Gregorio di Nissa e di Sant’Agostino), ma sicuramente un pregiudizio verso ciò che si può definire “Altro” (l’ebreo,”l’eretico”, il “saraceno”, il diverso in generale…) fa integralmente parte della cultura cattolica nell’arco dei secoli. E questo non gli ha certo permesso di avere una visione “lucida”, “imparziale” e “onesta” dei fatti. Ecco perché forse anche il cattolico dovrebbe saper mettere in discussione i propri pregiudizi storici. Ma come chiunque altro. Infatti quella dell’alterare la percezione dei fatti e della storia a favore della propria “partigianeria” è una costante dell’intero genere umano, indipendentemente da qualsiasi credo o cultura di appartenenza.
MICHELE- Cito il libro Storia dell’Olocausto di Klaus P.Fischer, ma in generale è fatto storicamente risaputo: “Fu proprio nella Spagna moresca che gli Ebrei trovarono uno dei pochi paradisi della loro storia lunga e travagliata, anche se questo paradiso non sarebbe sopravvissuto alla riconquista cristiana della Spagna, nel XV Secolo.”
IO – Mi dispiace, ma non è per “partigianeria se sono costretta a segnalare che il mito della Spagna moresca e anche della Sicilia “tollerante” è appunto un mito, anch’esso fabbricato dalla storiografia anticattolica (c’era da dimostrare che, se i cristiani erano oscurantisti e violenti, i non cristiani erano tutti evoluti e civilizzati). Sono costretta anche a ricordarle un fatto molto spiacevole: il profeta per primo passò attraverso la spada TUTTI gli ebrei di Medina e vendette come schiavi donne e bambini. E infatti i testi della sua religione sono pieni di incitamento all’odio verso gli ebrei. Qualcuno ha segnalato che sui testi scolastici dell’Arabia Saudita è scritto che la volontà di Allah è fare perire tutti gli ebrei fino all’ultimo e arriverà il giorno in cui anche gli alberi diranno ai musulmani: “Vieni qui, dietro di me c’è un ebreo che si sta nascondendo”. Già immagino l’obiezione: l’odio verso gli ebrei è effetto della politica di Israele. Direi di no: i brani anti ebraici contenuti nei testi scolastici sono tratti dai testi sacri ossia risalgono al settimo secolo. Ai palestinesi viene insegnato, fin da bambini, che gli ebrei sono “maiali” da squartare. Che pace si può fare con un popolo che ti vuole annientare? Come si può credere alla buona fede di gente che, per rivendicare i suoi “diritti”, entra nelle case e sgozza le madri di sei figli, come è accaduto di recente?
MICHELE – Come vede, Giovanna Jacob, non sono incline verso alcuna tifoseria di parte. Quello che infatti rimprovero ai più sono le partigianerie di parte: una conscia o inconscia attitudine a volere dipingere la propria tifoseria sempre dei colori più belli possibili (anche a costo di edulcolare palesi sbagli, difetti e mancanze del passato), mentre in un modo o nell’altro si cerca di far passare “l’altra parte” (qualunque essa sia) come quella culturalmente “inferiore” o “sbagliata” rispetto alla nostra, “l’unica vera e giusta, sempre e comunque”.
IO – Evidentemente lei non ha letto bene quello che ho scritto: “Se è vero che in tutti i paesi cristiani proliferavano leggende nere anti-ebraiche, che offrivano ai facinorosi il preteso per fare violenza agli ebrei, è altrettanto vero che tutti i papi le hanno combattute con risolutezza”. Ovviamente in un commento nonsi può scrivere un saggio, quindi è necessaria estrema sintesi. Ma appunto nella prima parte della frase ho specificato: “proliferavano leggende nere anti-ebraiche, che offrivano ai facinorosi il preteso per fare violenza agli ebrei”. Quindi non sto edulcorando un bel niente. Proprio noi credenti nel peccato originale sappiamo che tutti gli uomini sono peccatori, anche i fedeli cattolici. I santi sono pochi. Dunque anche nel popolo cattolico prolifera violenza e peccato. Ma il gioco degli anti-cattolici è quello di puntare i riflettori della propaganda sui peccati dei cattolici, ingigantirli oltre misura, lascando completamente in ombra gli enormi meriti. Tutte le cose che lei racconta (leggende del sangue, crociati che si sono scagliati contro gli ebrei prima che contro i mori) le conosciamo bene: fanno parte del lato oscuro della razza umana. Ma invece di soffermarsi in continuazione su questi episodi, occorre uno sguardo di insieme: mettendo su una bilancia i peccat da una parte e i meriti dall’altra, ebbene la bilancia pende dalla parte dei meriti, anche riguardo alla questione ebraica: se lo dicono anche gli stessi ebrei, perché non credere loro? Senza dubbio i pronunciamenti di papi e santi contano più delle dicerie del popolino ignorante.
MICHELE – “Il papato oscillava tra l’opinione espressa da Gregorio I , il quale insisteva che “i non credenti dovessero essere trattati con gentilezza e persuasi con ragionamenti chiari e presentati in modo gradevole”, opinione poi riaffermata in bolle papali in cui si affermava che “gli ebrei avevano diritto a vivere nelle società cristiane”, e i pronunciamenti più stridenti di papi come Innocenzo III (chi si rivede!) o dei Conelli Laterani, che dichiararono gli ebrei schiavi dei cristiani (Concilio Laterano III , 1179) o li segregarono socialmente , costringendoli a vestirsi in modo diverso e definendoli “blasfematori del nome cristiano” (Concilio Laterano IV , 1215)”.
IO – Anche qui, si sta usando la tecnica del riflettore: ma che cattivi questi cristiani, che segregavano gli ebrei e li costringevano a svolgere mansioni marginali! E no, mettiamo in luce bene che cosa c’era dietro. Dietro c’era il Talmud e testi anticristiani che circolavano nelle comunità ebraiche. Ad esempio, c’era un libro in cui Cristo veniva descritto come un mago ciarlatano e la Madonna come una prostituta. E mi dispiace davvero dovere dire quello che mai vorrei dire, e cioè che il Talmud (testo complicatissimo che non è mai stato interamente tradotto) invita gli ebrei ad essere onesti solo con gli altri ebrei e anche peggio (ma non voglio addentrami oltre, perché la questione è troppo scottante). Tanto per capire come stanno le cose, basti sapere che ancora oggi in Israele gli ebrei ortodossi (per fortuna isolati dalla maggioranza degli israeliani, che è laica) trattano con odio e disprezzo i cristiani. Ad esempio, qualche giorno fa hanno fatto trovare scritte piene di insulti e minacce di morte ai cristiani sui muri di una chiesa. E mi taccio.
MICHELE – Non sostengo l’idea che la Chiesa cattolica sia stata promotrice continua e assidua di idee antisemlite (che però risalgono indietro fino appunto ai tempi di Gregorio di Nissa e di Sant’Agostino), ma sicuramente un pregiudizio verso ciò che si può definire “Altro” (l’ebreo,”l’eretico”, il “saraceno”, il diverso in generale…) fa integralmente parte della cultura cattolica nell’arco dei secoli.
IO – Mi sembra una considerazione vaga e generica. Tutti gruppi umani hanno pregiudizi verso gli altri. Basti pensare solo ai pregiudizi reciproci fra popoli europei. Anche qui, però, bisogna considerare i meriti oltre ai peccati. Ebbene, i cattolici per storia e cultura hanno sempre mostrato la capacità di accogliere i diversi meglio degli altri (non è un caso se la cultura eugenetica razzista non ebbe fortuna nei paesi più cattolici: infatti i papi condannavano il razzismo dal 500 perché Paolo aveva detto “Non c’è più né giudeo né greco…”). Ma oltre al vago pregiudizio, c’è anche l’istinto di autodifesa: i “pregiudizi” maturati dai cattolici verso ebrei, saraceni e eretici erano ben motivati. Degli ebrei ho detto. Degli eretici catari non bisogna dimenticare che devastarono il nord Italia e il mezzogiorno francese (anche qui, i documenti storici concordano, e si può smentirli solo a costo di complesse teorie del complotto) mentre i saraceni, molto semplicemente, fecero razzie e violenze innominabili lungo le coste europee per tutto l’alto Medioevo. Poi finalmente iniziarono le crociate.
Giusto per intenderci, questo è il pensiero medio di questi sedicenti “catari” moderni.
Se il commento non verrà pubblicato posso ben comprenderlo, perché quello che riporto è pieno di volgarità.
http://catarismo.iobloggo.com/cat/falsi-santi/248479
“Ecco le mostruose aberrazioni che sono salite ai cieli da Gerasa:
«L’amore tra l’uomo e la donna è una buona strada per vivere il Vangelo, cioè per incamminarsi con gioia sul percorso della santità»
Così si apprende che il Falso Profeta sostiene che per vivere il Vangelo bisogna copulare. Sì, avete inteso bene. Egli afferma che Cristo insegnò a commettere fornicazione. Egli confonde Cristo con il Serpente! Così istiga i mariti a inserire il fa**o nella va**na delle mogli, a stantuffare fino a far uscire la sb**ra, e questo atto immondissimo viene da lui ritenuto “santità” e “benedetto da Dio”. Il Dio di cui parla è il Signore delle Mosche, è Satana. E’ l’Antico Serpente che ha dato il potere alla Bestia della Terra. Cristo non benedisse la copula, la maledisse. Cristo affermò senza mezzi termini che l’uomo che concupisce sua moglie è un adultero. E’ una mostruosità affermare che l’uomo e la donna che commettono fornicazione nel matrimonio possano incamminarsi con gioia sul percorso della santità, e il Falso Profeta che sostiene simili scelleratezze è ancor più malvagio di Aleister Crowley.”
Per inciso, per chi non lo avesse capito, il personaggio demonizzato in questione è l’attuale Papa.
Rispondo alle accuse di “delazione”: la “delazione” nella lingua italiana indica la comunicazione di reati alle Autorità competenti. Può anche avere significato di fare la spia, di essere un infiltrato o un traditore.
Rigetto tali pompose accuse…
1. In primis non appartengo e non mi riconosco in tale “chiesa dell’odio e della demonizzazione del prossimo”, quindi non vi è alcun “fare la spia”. Il fare la spia nella rete virtuale inoltre implica eventualmente la divulgazione di fonti private (come per esempio il contenuto di una chat privata, di un gruppo segreto o di un forum privato)… riportare fonti di qualsiasi tipo liberamente disponibili non è “delazione”. Altrimenti lo sarebbe anche riportare quello che c’è scritto su una pagina di Wikipedia
2. In secondo luogo, il fatto che questa pagina sia “notoriamente revisionista” o che abbia una visione fortemente “di parte” non costituisce deterrente, perché
3. Esattamente come un musulmano non è un cattivo musulmano nel segnalare una cellula di al-Qaida o dell’ISIS, o semplicemente nel voler sottolineare e prendere le distanze dal terrorismo, allo stesso modo è giusto prendere le distanze e notificare l’enorme distanza che separa alcuni gruppi estremisti da quelle che sono le cronache storiche. Perché qui la peggiore pubblicità esistente sul catarismo è proprio quella proveniente da questo genere di siti. E’ quindi giusto che la gente possa conoscere e distinguere le differenze, esattamente come lo è distinguere un satanista acido da uno puramente intellettuale (altrimenti dovremmo confondere la pericolosità di un Charles Manson con quella di un Giosuè Carducci)
4. Scotoma. La mente vede quello che vuole vedere. E’ giusto che la gente possa analizzare le fonti di prima mano. Se poi chi esamina è vittima di pregiudizi, non è colpa o responsabilità di chi mette a disposizione le fonti.
5. Se si gestisce un blog pubblico o se si va a gridare a tutti i venti che Benigni è il demonio, che Bergoglio è l’Anticristo e che l’amore tra uomo è donna è bestemmia, immagino non vi sia alcun problema nel fatto che il suo pensiero sia divulgato e diffuso. Se io scrivessi su un blog pubblico che i pigmei sono animali e non esseri umani, non dovrei avere problemi con il fatto che tale mia affermazione venga resa pubblica, se la penso veramente. Tanto non siamo mica più ai tempi dell’Inquisizione con le torture ed i roghi. Nessuno qui viene bruciato vivo. Al massimo viene giustamente criticato per il suo pensiero. O ingiustamente criticato. Resta il fatto che oggi si attacca e ci si difende con la lingua, almeno fino a quando abbiamo la libertà di pensiero e di parola. E’ vero che sicuramente su un sito come questo mi troverei in disaccordo con 99% delle idee circa temi quali la Storia, l’eutanasia, l’aborto, i diritti delle coppie di fatto, i diritti delle coppie omosessuali, la libertà sessuale, la libertà di pensiero e di religione. E non stimo affatto il passato della Chiesa cattolica, a mio parere piena di sangue, ingiustizie e un totale tradimento del messaggio di pace cristiano (per parecchi secoli tranquillamente tradito). Sicuramente siamo in disaccordo. Però nel 2016 mi trovo sicuramente più vicino a chiunque tenga in conto un minimo di valori di tolleranza verso il prossimo, e non la demonizzazione fanatica del prossimo. A me interessa la tolleranza, non importa se cattolica, catara, atea, laica, buddista, agnostica, di destra o di sinistra. E non c’è da temere circa il fatto che simili articoli possano essere attaccati da gente di parte di questo sito. Nessuna preoccupazione, lo sarebbero tranquillamente su qualsiasi altro sito di qualsiasi altra corrente di pensiero diversa.
Stiamo vivendo un profondo ritorno dei fanatismi da medioevo. Fanatismi nell’alimentazione (vi sono nuove correnti alimentari che manifestano una intolleranza e un fanatismo degni di una religione), fanatismi e deliri religiosi, nostalgie per idee politiche estremiste, fanatismi dogmatici di ogni genere.
Che vi sia da prendere coscienza di questo fenomeno e di questo problema, credo ci si possa concordare indipendentemente dal proprio credo spirituale, filosofico o ideologico.
Posso intromettermi, Michele?
Secondo la sottoscritta non stiamo vivendo affatto un profondo ritorno dei “fanatismi da medioevo”; semplicemente perchè i ” fanatismi da medioevo” -e mi dispiace che il Medioevo porti alla ribalta solo il suo lato negativo, sempre e comunque- ci sono sempre stati: solo che non c’è stato, in passato, il modo di manifestarli, palesarli, dacchè non c’erano -allora- i media che ci sono ora a disposizione. Tutto qui: nulla di nuovo sotto il sole. E ci saranno sempre -forse che qualcuno crede il contrario?
E -parere personale- il “problema” che lei vede accentuato in modo particolare oggi come oggi, resterà “problema” sino a quando l’uomo non si deciderà davvero di dar retta a Colui che gli dà l’essere e la vita -Diocreatore; dar retta significa convertirsi=cambiare dentro, dare l’opportunità a noi stessi di divenire nuove creature, lasciarci plasmare dal Solo in grado di cavarne fuori qualcosa di veramente Bello -con la maiuscola: più affidabili -certo!, se saremmo come Lui è sparirebbero proprio tutte le negatività che sonnecchiano nell’uomo vecchio (mettiamoci pure dentro tutto: vizi, cattiverie, “orge, ubriachezze” (S. Paolo -Galati 5,16) e diverremmo potenzialmente capaci di creare una nuova umanità, sicuramente più Buona. Ma io la relego tra le possibili utopie, ammenochè….Non ci si decida tutti per il grande Si’ a Dio.
Io credo anche nei miracoli, quindi…..
Grazie.
MICHELE – «E’ presso i cristiani che si diffonde la famosa “Accusa del sangue” nei confronti degli ebrei, insieme a miti quali il rapimento di bambini cristiani ad opera loro per “innominabili” sacrifici. »
IO – Gli ebrei Jonathan Elukin (autore di “Living Together, Living Apart: Rethinking Jewish-Christian Relations in the Middle Ages”) e David G. Dalin (autore di “La leggenda nera del papa di Hitler”, Piemme) sostengono che i paesi in cui gli ebrei si sono sempre trovati meglio, fra tutti i paesi del mondo, sono i paesi cattolici (Roma la chiamano addirittura “il paradiso degli ebrei”). Se è vero che in tutti i paesi cristiani proliferavano leggende nere anti-ebraiche, che offrivano ai facinorosi il preteso per fare violenza agli ebrei, è altrettanto vero che tutti i papi le hanno combattute con risolutezza. La tremenda “accusa del sangue” fu condannata per la prima volta Innocenzo IV (bollaLachrymabilem Judaeorum, 1247) e poi fu nuovamente e ripetutamente condannata da molti altri papi (Gregorio X, Martino V, Nicola V e Paolo III e Clemente XIV). La leggenda del grande complotto degli ebrei, che avrebbe avuto enorme fortuna nel XIX, era già stata condannata solennemente da Ulberto da Romans, priore generale dei domenicani, al concilio di Lione del 1274. Durante la Seconda guerra mondiale molti cattolici, per ordine del Papa, si prodigarono enormemente per strappare il maggior numero possibile di ebrei dalle grinfie dei nazisti (lo hanno riconosciuto pubblicamente molte importanti personalità ebraiche, fra cui Golda Meir). Infine, chi volesse sapere come e perché i “marranos” furono espulsi dalla Spagna nel 1492, può leggere “La regina diffamata” di Jean Dumont.
MICHELE – «E posso dire qualcosa di ancora più “spinto”. Lo “jihadista” è nel concreto più pericoloso in assoluto. Insomma, ti vuole morto, vuole ucciderti, vuole tagliarti la testa, arriva se necessario anche a farsi zompare in aria. Ma cosa vuole? Nella sua distorta e malata mente egli è convinto di lottare per la “libertà” dall’oppressione occidentale. Combatte per imporre la sua religione, perché è stoltamente convinto che un mondo sotto la tirannia del suo Dio sarebbe un mondo migliore. »
IO – Da bravo laicista sinistrese. Michele interpreta marxisticamente il jihadismo come “reazione” del proletariato del Terzo Mondo allo (immaginario) sfruttamento politico-economico che subirebbe da parte dell’Occidente. Ho smontato per benino questa interpretazione qui:
https://www.tempi.it/vittime-colpevoli-carnefici-innocenti#.Vp-MdirhDIV
MICHELE – «Sui cosiddetti catari o gnostici si sono fatte circolare ogni genere di voci, a volte persino in totale contrasto tra loro. Li si è accusati per esempio di rifiutare il sesso. E poi di fare le orge. I denigratori non si sono nemmeno curati di far circolare delle false voci che fossero almeno coerenti tra loro. (…) La mia critica quindi non è verso i dualisti storici, ma verso questi soggetti che pretendono di prendere le difese del catarismo pur mettendo in pratica proprio quel genere di comportamenti e atteggiamenti che vengono attribuiti ai catari del passato. Come difendere i catari del passato confermando in prima persona tutti i luoghi comuni che vengono solitamente loro attribuiti. (…) E se la gente pensa che, se questi sono i “catari” moderni, allora forse non erano nemmeno tanto “santi” quelli del medioevo. E’ solo grazie a questi “catari” moderni che perdura ogni possibile pregiudizio sulla spiritualità catara. »
IO – Michele continua a fare il gioco sporco: dice che i cattolici avrebbero calunniato il catarismo e che di conseguenza i catari moderni si sarebbero conformati a queste calunnie. No, qui se c’è qualcuno che calunnia è proprio Michele: calunnia spudoratamente i cattolici. Caro Dottor Sottile, di grazia, vorrebbe dirci lei in quali testi avrebbe appreso l’autentica spiritualità catara, considerando che i testi originali sono stati tutti (giustamente) distrutti? Ha forse studiato Simone Weil, che si era inventata il catarismo dei suoi sogni? Caro Dottor Sottile, di grazia: ritiene che tutti i cattolici senza distinzione dei secoli XII e XIII si sarebbero messi d’accordo – in stile mega complotto mondiale rettilianbabilonesegiudaicomassonico – per raccontare balle sui catari per ingannare i posteri? Eh no, perché, come ho detto, dei catari abbiamo solo testimonianze storiche indirette dei contemporanei, i quali parlano nero su bianco di saccheggi, aggressioni, devastazioni ad opera dei “pacifici” catari. Si sono inventati tutto? Oppure sono statigli storici cattolici “revisionisti” a falsificare con le potenti tecniche della Cia (le stesse usate per falsificare i filmati del finto sbarco lunare) tutti i documenti medievali relativi ai catari, facendoli passare per autentici documenti medievali consumati dal tempo? Siamo tutti orecchi, Dottor Sottile, ci dica! E ci spieghi perché anche storici anticattolici di fede protestante hanno ammesso, sia pure controvoglia, che la crociata contro i catari ha salvato l’Europa dalla catastrofe.
Henry Charles Lea, autore di una anticattolica “Storia dell’Inquisizione nel Medio Evo”, ha scritto: «Se la credenza dei catari fosse riuscita a reclutare la maggioranza dei fedeli, essa avrebbe riportato l’Europa ai tempi selvaggi primitivi». Il protestante, Paul Sabatier, il celebre biografo di san Francesco, ha scritto: «Il papato non è stato sempre dalla parte della reazione e dell’oscurantismo: quando sbaragliò i catari, la sua vittoria fu quella del buon senso e della ragione. Non dobbiamo permettere che le persecuzioni sopportate da eretici come questi ce li renda affascinanti al punto da modificare il nostro giudizio radicalmente negativo».
MICHELE – «Esattamente come gli estremisti jihadisti rendono più difficile il rapporto tra musulmani e non musulmani. E non posso affatto biasimarlo. Per tale ragione i moderati HANNO L’OBBLIGO di prendere le distanze dagli estremisti e di sottolineare le differenze tra moderati e fanatici, tra ciò che è la vera religione (catara, cattolica, islamica oppure orientale che sia) e ciò che è solo la deriva portata avanti dai fanatici senza rispetto e amore del prossimo. »
IO – A momenti Michele viene a dirci che anche l’estremismo jihadista-stragista è effetto delle calunnie contro l’islam inventate dai cristiani… Quali calunnie???!!!?? A me risulta che dall’ultimo dei preti al papa, tutte le autorità ecclesiastiche non facciano altro che invitare al “dialogo” e alla “accoglienza”. Lo stesso Massimo Introvigne, esegeta ufficiale del papa, non fa che ripetere che bisogna distinguere fra un islam moderato e un islam fanatico e che bisogna fare di tutto per dialogare con l’islam moderato, rafforzarlo e invitarlo ad isolare i fanatici. Infatti, secondo Introvigne e secondo il papa il vero islam è quello moderato, mentre quello estremista è un islam distorto che tradirebbe il messaggio del profeta.
Adesso, lascio ad altri di discutere quale sia il vero islam. Io mi limito a registrare i fatti. Ebbene, i fatti sono questi: è dal’11 settembre che dialoghiamo con i “moderati” e trattiamo i musulmani con ogni riguardo ed è dall’11 settembre che le cose non fanno che peggiorare. Vi invito a leggere questo articolo lucidissimo, scritto da un cosiddetto “oggettivista”, ossia un ateo professo seguace della filosofa russa Ayn Rand:
http://www.nationalinterest.org/feature/moderate-islam-isnt-working-14693?page=show
MICHELE – «E non stimo affatto il passato della Chiesa cattolica, a mio parere piena di sangue, ingiustizie e un totale tradimento del messaggio di pace cristiano (per parecchi secoli tranquillamente tradito). »
IO – Scrive uno storico ateo di nome Leo Mulin: «Date retta a me, vecchio incredulo che se ne intende: il capolavoro della propaganda anti-cristiana è l’essere riusciti a creare nei cristiani, nei cattolici soprattutto, una cattiva coscienza; a instillargli l’imbarazzo, quando non la vergogna, per la loro storia. A furia di insistere, dalla riforma sino ad oggi, ce l’hanno fatta a convincervi di essere i responsabili di tutti o quasi i mali del mondo. Vi hanno paralizzato nell’autocritica masochista, per neutralizzare la critica di ciò che ha preso il vostro posto. Femministe, omosessuali, terzomondiali e terzomondisti, pacifisti, esponenti di tutte le minoranze, contestatori e scontenti di ogni risma, scienziati, umanisti, filosofi, ecologisti, animalisti, moralisti laici: da tutti vi siete lasciati presentare il conto, spesso truccato, senza quasi discutere. Non c’è problema o errore o sofferenza nella storia che non vi siano stati addebitati. E voi, così spesso ignoranti del vostro passato, avete finito per crederci, magari per dar loro manforte. Invece io (agnostico, ma storico che cerca di essere oggettivo) vi dico che dovete reagire, in nome della verità. Spesso, infatti, non è vero. E se qualcosa di vero c’è, è anche vero che, in un bilancio di venti secoli di cristianesimo, le luci prevalgono di gran lunga sulle ombre. Ma poi: perché non chiedere a vostra volta il conto a chi lo presenta a voi? Sono forse stati migliori i risultati di ciò che è venuto dopo? Da quali pulpiti ascoltate, contriti, certe prediche?»
Invito Michele a rileggere il mio articolo, in cui sfubalo una per una tutte le bufale pseudo-storiche contro la Chiesa:
https://www.tempi.it/occidente-prodigo-tornera-da-suo-padre#.Vp-CvCrhDIV
MICHELE – «Stiamo vivendo un profondo ritorno dei fanatismi da medioevo. Fanatismi nell’alimentazione (vi sono nuove correnti alimentari che manifestano una intolleranza e un fanatismo degni di una religione), fanatismi e deliri religiosi, nostalgie per idee politiche estremiste, fanatismi dogmatici di ogni genere. »
IO – E’ ancora diffuso, fra gli anti-cattolici, il vizietto di usare il termine “Medioevo” per indicare un’epoca oscura e oscurantista. In realtà il Medioevo cristianissimo è stata un’epoca luminosa in cui si edificavano cattedrali maestose (i cui segreti tecnici gli stessi illuministi faticarono a scoprire), si fecero crociate sacrosante contro chi voleva annientare la cristianità europea (musulmani e catari), le donne erano considerate pari agli uomini (vedi Matilda di Canossa, Isabela di Castiglia ed altre potenti) e nessuna strega fu bruciata (ma quando c… imparerete che la caccia alle streghe iniziò nel XVI sec. Nei paesi protestanti????!!!!???) e non c’erano suerstizioni magiche (il pensiero magico occultista sarebbe fiorito nel Rinascimento, specialmente attorno alla figura di Elisabetta d’Inghilterra, protettrice del vecchio mago Giordano Bruno).
Non mi stancherò mai di segnalare questi testi:
Régine Pernoud, “Medioevo, un secolare pregiudizio”, Bompiani 2001.
Régine Pernoud, “La donna al tempo delle cattedrali”, Rizzoli Bur storia.
Christopher Dawson, “Il cristianesimo e la formazione della civiltà occidentale”, Bur 1997, 2004.
Rodney Stark, “La vittoria della ragione”, Lindau 2005.
Rodney Stark, “A Gloria di Dio. Come il cristianesimo ha prodotto le eresie, la scienza, la caccia alle streghe e la fine della schiavitù”, Lindau 2011.
Rodney Stark, “La vittoria dell’Occidente. La negletta storia del trionfo della modernità”, Lindau 2014.
Rodney Stark, “Gli eserciti di Dio – Le vere ragioni delle crociate”, Lindau.
Thomas Woods, “Come la Chiesa cattolica ha costruito la civiltà occidentale”, Cantagalli 2007.
Robert Spencer, “Guida (politicamente scorretta) all’Islam e alle crociate”, Lindau.
Thomas Madden, “Le crociate. Una storia nuova”, Lindau 2005.
Jonathan Riley-Smith, “The Crusades: The Authoritative History of the War for the Holy Land”, Third edition 2005.
Paul Crawford, “Four Myths about the Crusades”, Intercollegiatesstudies institute, 2011
https://home.isi.org/four-myths-about-crusades
CONCLUSIONI. Stiamo attraversando un’epoca oscura e oscurantista in cui nemici spietati ci hanno dichiarato guerra. Invece di lottare contro i nemici, i laicisti continuano a calunniare i cattolici: “Voi siete peggio dei jihadisti, nella storia avete commesso atrocità peggiori di quelle commesse oggi dall’Isis”. Quindi la lotta contro queste calunnie di origine illuminista ha oggi una importanza fondamentale. Solo quando queste calunnie saranno state definitivamente polverizzate, avremmo qualche chance di iniziare a combattere seriamente contro i nemici.
Raider, conosco bene l’aneddoto storico riguardante l’Ucraina e infatti credo che buona parte della leggenda di “comunisti che mangiano i bambini” derivi da lì. A questo si aggiunge la leggenda metropolitana dei cinesi che secondo alcuni mangerebbero i bambini (si può ringraziare di questo l’artista cinese Zhu Yu… basta digitare “Zhu Yu bufala nei motori di ricerca). La verità ovviamente sta nel mezzo… appunto trattasi anche di periodi di tremenda carestia che hanno portato alcune persone, per disperazione, persino al cannibalismo. In Siberia se ne sono registrati casi già dai tempi degli zar, ben prima dell’arrivo del comunismo.
Ma quello che volevo far capire facendo quell’esempio era la propensione verso le “leggende” ed i pregiudizi che affligono da secoli i cattolici. Ovviamente i cattolici non sono certo gli unici al mondo ad avere questa propensione. Ogni categoria ha i suoi “miti”. Ma nel caso delle “eresie” bisogna anche ammettere che i cristiani ne hanno spettegolato di cose assurde. Se non piace citare il comunismo potrei citare i primi miti antisemiti messi in circolazione proprio dai cristiani… è presso i cristiani che si diffonde la famosa “Accusa del sangue” nei confronti degli ebrei, insieme a miti quali il rapimento di bambini cristiani ad opera loro per “innominabili” sacrifici. Sulle eresie la Chiesa le ha sempre sparate comunque grosse, giusto per il gusto del denigrare e diffamare… sui cosiddetti catari o gnostici si sono fatte circolare ogni genere di voci, a volte persino in totale contrasto tra loro. Li si è accusati per esempio di rifiutare il sesso. E poi di fare le orge. I denigratori non si sono nemmeno curati di far circolare delle false voci che fossero almeno coerenti tra loro. A voler dare retta a tutte si dovrebbe supporre che i catari facessero “orge di astinenza” o “astinenze fortemente copulose”… perdonatemi se sono scettico. Sull’argomento storiografico dico soltanto che la maggior parte degli studi seri sull’argomento non sono quelli che si trovano ovviamente sulle pagine dei cattolici fortemente tradizionalisti. Tutti gli studiosi seri sull’argomento parlano della “crociata contro gli albigesi” come di un massacro senza quartiere e soprattutto unilaterale. E all’obiezione che qualche abitante del luogo possa avere anche imbracciato un’arma contro gli invasori, rispondo come Manfredi nel film In nome del Papa Re: “ah! manco quella je volevi da?!”… Poi ad ogni modo se vi capita fatevi un viaggio nel mezzogiorno francese e chiedete a quella che è la memoria popolare del luogo… e non vi preoccupate, non sono catari: sono cattolici… ma manco a loro gli tornano i conti come vorrebbero farli tornare i cattolici revisionisti. Perché ovviamente c’è anche da distinguere tra cattolici storicamente onesti e cattolici troppo tradizionalisti e fermi sul punto che “la Chiesa è infallibile, non sbaglia mai a priori” per ammettere che qualcosa di ingiusto e sbagliato è stato fatto. Formalmente o sinceramente che sia, anche la Chiesa stessa “ha chiesto perdono” di quanto accaduto… ma tant’è che vi sono cattolici talmente tradizionalisti da voler raccontare la storia anche in modo diverso da come la ammette la Chiesa stessa, ma soprattutto da come la documentano gli storici e gli studiosi.
Non mi sono pronunciato contro il catarismo storico. Non mi sforzo di cambiare le opinioni ed i pregiudizi radicati, e al massimo posso solo dire quanto di più “scientifico” io possa raccomandare: mai vivere di pregiudizi e documentarsi approfonditamente in modo individuale e personale, senza dare retta a leggende urbane e “ipse dixit”. Se poi uno ritiene che il catarismo storico fosse pericoloso e distruttivo, libero di crederlo. La mia esperienza di documentazione personale è diversa, ma ben lungi da me il credere che abbia per forza ragione io. Posso solo dire che quando andavo a scuola dalle mie parti si diceva ci fosse una comunità di catari anticamente. La mia insegnante di religione raccontava di come la zona fosse stata devastata e distrutta dai catari stessi… è un racconto che mi ha sempre lasciato incredibilmente perplesso… un giorno delle persone si alzano e decidono di distruggersi la casa e di perseguitarsi e uccidersi da sole in modo cruento… molto plausibile davvero.
La mia unica perplessità è mossa verso quei “catari” per così dire “odierni” che vogliono da una parte difendere il pacifismo dei catari, e dall’altra parte mostrano se stessi come persone che continuamente maledicono e inveiscono contro il prossimo diffondendo questa dottrina dell’estinzionismo e della demonizzazione del prossimo. Non sono solito usare termini assoluti in quanto solitamente sono un “convinto” relativista, ma una simile visione del mondo è realmente Il Male. Una nuova forma di Male. Il classico “male” nasce solitamente dall’avidità umana, dall’egoismo, dalla crudeltà, dall’intolleranza. Molto spesso il “male” è solo una ricerca del “bene” fatta con metodi e convinzioni sbagliati. Espressioni classiche di “male” sono la ricerca del potere e del dominio, l’egoistico monopolio delle risorse e delle ricchezze, il perseguire l’ordine e la pace con la forza e la violenza. Per quanto limitatamente, con questo genere di “Male” è possibile ragionare, perché ogni essere umano, anche nel modo più distorto, esiste la ricerca delle stesse cose. Quando due eserciti di una guerra si scontrano, i soldati al fronte forse non sanno che il “nemico” dall’altra parte della barricata spera soltanto quanto lui di rivedere la sua famiglia, di avere la pace, di tornare a casa salvo. Bene o male se ci sentiamo male in mezzo alla strada, possiamo contare sull’idea che la nostra esistenza non può essere completamente indifferente a tutti. Nel bene o nel male persino un nemico onorevole, quando è tale, mantiene presente il fatto che tu sei un suo simile.
Anche con un tiranno puoi scendere a compromessi. Ma come puoi scendere a patti con un Male che ha un solo obiettivo: l’estinzione e la distruzione di ogni cosa? Non puoi ragionarci, non puoi ricevere da lui alcuna empatia (perché ti nega persino il riconoscimento di essere umano e di possedere un’anima). Non puoi trovare alcuna conciliazione con qualcuno che ti detesta o ti giudica male a priori per il fatto stesso che vivi e ti fai una famiglia. Non puoi trovare conciliazione o dialogo con qualcuno che avrà pace e sarà felice solo quando ogni forma di vita sarà estinta. Questo non è il classico “Male legale” che vuole semplicemente avere più ricchezza e potere. Questo è un “Male caotico” che “vuole solo veder bruciare il mondo”, come afferma il Joker nel film “Il cavaliere oscuro”.
”Certi uomini non cercano qualcosa di logico come i soldi, non si possono comprare né dominare, non ci si ragiona né ci si tratta. Certi uomini vogliono solo veder bruciare il mondo”
Ed è esattamente questo quello che sono questi sedicenti “catari” moderni (che ci tengo a distinguere da chi in realtà si considera tale, ma rivendica valori umani completamente diversi)… “vogliono solo veder bruciare il mondo”. Noi tutti compresi.
E posso dire qualcosa di ancora più “spinto”. Lo “jihadista” è nel concreto più pericoloso in assoluto. Insomma, ti vuole morto, vuole ucciderti, vuole tagliarti la testa, arriva se necessario anche a farsi zompare in aria. Ma cosa vuole? Nella sua distorta e malata mente egli è convinto di lottare per la “libertà” dall’oppressione occidentale. Combatte per imporre la sua religione, perché è stoltamente convinto che un mondo sotto la tirannia del suo Dio sarebbe un mondo migliore.
Ma in maniera astratta un simile pensiero “cataro”, secondo questa particolare visione di “catarismo”, è persino molto più pericoloso. Perché aspira al puro “nihil”, al puro niente. E non ci aspira per conto suo, lo auspica anche per tutti gli altri. Odia il “mondo” inteso sia come luogo fisico che come “altre genti” (“terriccio animato, privo di alcuna anima”) e non vede l’ora di vedere il mondo e tutti coloro che vi abitano bruciare insieme. Non credo sia mai stata formulata una visione più ostile di questa contro il genere umano ed il mondo.
Siano ben chiari due punti.
Il primo è che non giudico affatto negativamente il nichilismo esistenziale individuale.
E’ anzi molto spesso tipico di caratteri molto umani e sensibili provare sconforto verso l’esistenza e la crudeltà del mondo. Ed è comprensibile il nutrire una visione personale dell’esistenza molto amara e propensa verso il desiderio di annientamento.
Il secondo punto è che non critico affatto il catarismo storico e gli altri dualismi. Ho studiato abbastanza i dualismi del passato da ritenerli ben distanti da quanto si tramanda spesso sul loro conto. Giusto per fare un esempio, ci sono arrivati intatti i precetti comportamentali delle comunità manichee… e sappiamo che solo ai “perfetti” era fatto divieto alcuno di sposarsi e avere figli. La maggior parte del resto della comunità seguiva una regola differente che prescriveva solo la monogamia e la fedeltà al coniuge. Non vi troviamo alcun precetto che prescriva ai manichei di odiare e detestare il mondo. E soprattutto troviamo la prescrizione al divieto assoluto di compiere alcuna violenza verso il prossimo. Per chi non lo sapesse, le comunità “dualiste” erano divise in “credenti” e “perfetti”. Gli ultimi in un certo senso erano la “casta sacerdotale” della comunità, mentre i primi erano i “laici”, anche se il paragone è improprio. Sostenere che i manichei osteggiassero la vita sarebbe come ritenere antinatalisti i cattolici per via del voto di castità che fanno i loro sacerdoti.
La mia critica quindi non è verso i dualisti storici, ma verso questi soggetti che pretendono di prendere le difese del catarismo pur mettendo in pratica proprio quel genere di comportamenti e atteggiamenti che vengono attribuiti ai catari del passato. Come difendere i catari del passato confermando in prima persona tutti i luoghi comuni che vengono solitamente loro attribuiti.
Sia riguardo al primo punto che riguardo al secondo punto posso solo concludere dicendo che qualsiasi credo religioso o filosofico è degno di rispetto unicamente fino a quando rimane personale e rispettoso del diverso. Persino aspirare al “nihil” è un desiderio da rispettare fintanto che rimane uno stile di vita personale e tranquillo. La patologia scatta nel momento in cui si comincia ad anatemizzare e disprezzare il resto del mondo che non condivide la stessa via, quando si iniziano a scagliare maledizioni verso quelli che non la pensano come noi, quando persino le coppie che si sposano e hanno figli vengono anatemizzate come colpevoli di crimini imperdonabili passabili del giusto castigo a base di zolfo e fuoco. Non ci si può poi sorprendere o lamentare se poi circolano brutte opinioni e voci sul proprio conto. E se la gente pensa che, se questi sono i “catari” moderni, allora forse non erano nemmeno tanto “santi” quelli del medioevo. E’ solo grazie a questi “catari” moderni che perdura ogni possibile pregiudizio sulla spiritualità catara. Esattamente come gli estremisti jihadisti rendono più difficile il rapporto tra musulmani e non musulmani. E non posso affatto biasimarlo. Per tale ragione i moderati HANNO L’OBBLIGO di prendere le distanze dagli estremisti e di sottolineare le differenze tra moderati e fanatici, tra ciò che è la vera religione (catara, cattolica, islamica oppure orientale che sia) e ciò che è solo la deriva portata avanti dai fanatici senza rispetto e amore del prossimo.
In questo articolo ci sono molte inesattezze di cui non incolpo l’autore poiché questa è “cultura popolare”, cioè quel comune dire che si tramanda senza essersi minimamente documentati oltre il sentito dire.
In primo luogo è molto fuorviante parlare di “nichilismo orientale” riferendosi al manicheismo, dato che “l’oriente” di oggi indica qualcosa di ben più distante dai tempi del medioevo. Oltre al nichilismo occidentale (ben più noto e conosciuto nelle sue varie sottocorrenti) vi è anche un nichilismo russo e un nichilismo nipponico. Quindi per uno studioso di oggi sentire parlare di “nichilismo orientale” può portare a pensare a quello giapponese, che non comprende affatto in sé alcuna dicotomia materia-spirito. Anzi, in realtà la dicotomia materia-spirito non appartiene proprio al nichilismo. Sarebbe più appropriato parlare di anticosmismo riguardo a certe dottrine cosiddette “dualiste”.
Del tutto inappropriato l’accostamento tra jihadisti ed eresia catara. I catari e anche i manichei erano noti pacifisti. Fautori di un pacifismo talmente radicale da coinvolgere persino il rifiuto di danneggiare in alcun modo non solo la vita umana, ma persino quella animale e in certi casi persino quella vegetale (nel caso dei “perfetti” manichei). Se un accostamento è possibile, tale accostamento può essere fatto con il Jainismo.
Volendo rispondere a Vanya, in realtà i peggiori calunniatori dei catari medievali sono al giorno d’oggi proprio la maggior parte degli emulatori moderni di tali eresie. Cioè quelli che oggi si fregiano del titolo di catari del terzo millennio. Se da una parte vi sono pittoreschi personaggi figli della New Age che in gran parte si ridicolizzano da soli postulando e attribuendo ai catari fantasiosi miscugli tra teosofismo, miti cavallereschi, cristalloterapie e poco credibili “canalizzazioni”, da un altro lato ci sono ancor più inquietanti personaggi figli di quella che si potrebbe definire “New Age Oscura”… Se il comune newagezzaro mescola colombe, unicorni e arcobaleni a poco credibili “revival” dell’immaginario cataro, la sua controparte attinge alle varianti tenebrose della New Age, mescolando insieme temi complottistici classici come “l’imminente fine dei tempi”, la natura “demoniaca” di chiunque non vada loro a genio e l’immancabile progetto massonico-sionista per la conquista del mondo o della galassia. Questi personaggi sarebbero in fondo anche divertenti e innocui come la loro colorata controparte, se non fosse che questa variante tenebrosa tende a fare pesanti e non innocue insinuazioni. Alcune di queste pesanti insinuazioni riguardano l’affermare che gli esseri umani diversi da loro (dalla loro setta) non siano veri esseri umani, ma “demoni incarnati”, accusa che rinforzano puntualmente contro chiunque manifesti un modo di pensare diverso da loro. Sostengono che i bambini in tenera età siano “creature demoniache” (evidentemente loro si generano spontaneamente dal terreno già adulti, in quanto una simile affermazione implicherebbe che anche loro siano della stessa natura, supponendo che siano stati bambini anche loro), lanciano anatemi pieni di odio verso il prossimo augurando loro le pene dell’inferno, invocano a gran voce che in qualche modo il mondo venga al più presto annientato, di fatto augurando la morte e la devastazione di ogni forma di vita dell’universo. Sulla rete è possibile visitare un sito su questa visione del catarismo, si chiama Rinascita Catara, ed esprime esattamente questi concetti, con un linguaggio molto più “colorito” di quello da me adoperato.
Chiaramente un jihadista è concretamente molto più pericoloso. Ma allo stesso tempo bisogna ammettere che è difficile anche avere un qualsiasi tipo di dialogo con qualcuno che ritiene che tu non sia un essere umano, ma un demone senza anima. Difficile anche avere un qualsiasi tipo di dialogo con qualcuno che non vuole ucciderti, ma che spera che tu muoia al più presto, insieme a lui e a qualsiasi altra forma di vita.
E la cosa bella è che in realtà di tutto questo non vi è alcuna traccia nella storia del catarismo medievale. Il catarismo medievale rimproverava ai cattolici proprio il tradimento dei valori principali del cristianesimo delle origini, che riguardavano ANCHE la non violenza e L’AMORE PER IL PROSSIMO. Quale amore per il prossimo resta possibile in una religione che invece considera il proprio prossimo un demone privo di anima? Quindi diciamo tranquillamente che i principali calunniatori del catarismo medievale sono proprio certuni che si definiscono tali al giorno d’oggi.
Certo che sei proprio bravo “Michele” GG.
Il peggiore calunniatore sei proprio tu, che non solo occhieggi malignamente i siti e i gruppi altrui, ma fornisci elementi preziosi ai revisionisti affinché possano malignare ancora meglio. Proprio i delatori come te fecero un grande comodo agli inquisitori!
Non sai che questi signori parlerebbero allo stesso modo anche della tua paginetta, Itinerari Ereticali, come del resto già è successo?!! Vergognati!!
In lingua italiana le “calunnie” sono accuse rivolte a terzi che corrispondono ad affermazioni false. Se c’è qualcosa di positivo nell’esistenza di internet rispetto ai faziosi interrogatori estorti con la tortura nel medioevo, è che ogni fonte corrisponde di proprio pugno all’autore che l’ha scritta, a meno che non si tratti di fake. Ogni utente è libero di consultare le fonti in prima persona e di farsi personalmente la propria idea. Come è normale aspettarsi, anche altri utenti hanno già avuto a che fare con questi “catari” e le presunte “calunnie” sono il semplice quotare punto per punto quello che essi stessi dicono. Non esiste calunnia nel riportare quello che lo stesso interessato afferma. Come ha fatto anche l’utente Giovanna.
Sul discorso storico, se ci si prende il disturbo di compiere uno studio onesto sull’argomento, emerge facilmente che i catari non erano affatto persone violente e distruttive. Il pacifismo cataro, che si spingeva fino al limite di non poter torcere il capo nemmeno ai polli, è riportato persino nelle fonti dei loro principali avversari. Comprendo invece che la pratica del suicidio volontario o assistito possa suscitare assoluta mal comprensione e molte “leggende” in seno alla cultura cattolica, sebbene esistano o siano esistite altre culture con questo rapporto differente nei confronti della morte (si pensi all’Europa precristiana o al rapporto con il suicidio o con l’eutanasia che hanno i giapponesi).
In realtà l’anticosmismo in sé non è necessariamente antisociale o socialmente pericoloso. Vi sono altre dottrine che possono in un certo senso essere definite anticosmiche e che tuttavia intrattengono rapporti benevoli con il prossimo. La dottrina buddista (escludendo lo zen) e l’induismo possono in un certo senso essere considerate dottrine “anticosmiche” e praticamente nessuno le accusa di essere distruttive o antisociali. Il discorso muta profondamente quando il tuo interlocutore ritiene che il proprio prossimo non sia nemmeno un proprio simile, quando ritiene che l’altro che non condivide la sua visione del mondo non sia un essere umano, ma un demone. Il discorso muta quando l’interlocutore afferma che i lattanti siano creature demoniache (e ribadisco la mia perplessità: coloro che muovono questa tesi si sono generati spontaneamente dal terreno senza essere mai stati bambini?) e scaglia continuamente anatemi e maledizioni contro il prossimo. Quando l’interlocutore auspica la fine della tua vitalità e dell’intero genere umano, invocando a gran voce che una qualche immane catastrofe spazzi via ogni germe di vita.
In tal caso il dialogo certo non è facile. E il pregiudizio diventa quasi spontaneo. Non è facile vedere di buon occhio qualcuno che ti maledice e che in ultima analisi auspica la tua morte e la fine di ogni tua discendenza. Il mettersi sul chi vive sorge spontaneo. Che una società civile si allarmi in tale direzione è più che ovvio. Solo in tal senso è possibile fare una analogia tra questo specifico genere di “catarismo” e gli jihadisti. Certo, ci sarebbe da specificare che i primi non torcerebbero mai un capello a nessuno rispetto ai secondi. Ma la diffidenza a tale riguardo è anche comprensibile. Un anticosmista pacifico che vuole solo vivere appartato dal resto del mondo non suscita necessariamente diffidenza. Anzi, sicuramente è possibile avere una visione anticosmica del mondo ed essere, forse in forza proprio di questo, ancora più benevoli e compassionevoli verso il prossimo. In realtà i catari medievali erano di questo genere, a quel che mi risulta. Ed il buddismo sviluppa la compassione proprio in tale visione.
Però se io fossi musulmano e volessi trasmettere l’idea che l’Islam è una religione di pace, di sicuro non lo farei imbracciando un fucile o minacciando la dannazione eterna per gli “infedeli”! Che poi è quello che hanno fatto anche i cattolici, a loro tempo.
Allo stesso modo come è possibile per un “cataro” moderno difendere l’immagine di un catarismo pacifico e socialmente accettabile del passato se egli stesso dimostra nel presente di essere tutt’altro che pacifico? Va bene che non viene fatto fisicamente del male a nessuno, ma già il fatto che simili “catari” maledicano il prossimo e auspichino, con tutta la veemenza di linguaggio possibile, il “fuoco eterno” e la morte loro e altrui certo non può rassicurare nessuno. E se qualcuno di essi avesse un’arma di distruzione di massa in grado di annientare la vita su tutto il pianeta, con l’idea fissa che la vita “sia il male” e debba essere annientata, non mi sentirei tanto sicuro del fatto che non la userebbe per ammazzare tutti. Il fatto è che tali “catari” sono in numero ancora esiguo. Ma quando una religione già in partenza “intollerante” cresce di numero, prima o poi produce le sue pecore nere che ragionano in termini di “abbiam fatto trenta, facciamo trentuno”. Lo vediamo con i jihadisti, che non sono che l’Islam portato alle estreme conseguenze. Le estreme conseguenze di una religione che crede nella conversione forzata. E quali sono le estreme conseguenze di una religione che dovesse credere che l’annientamento della vita sia l’unica salvezza? Non è difficile immaginarlo. Quindi avrei leggero spavento di una intera nazione convertita ad un simile culto (anche se fantageopoliticamente sarei curioso di vedere cosa farebbero con l’atomica in mano). Cosa tra l’altro paradossale, perché il rifiuto della natalità estinguerebbe ogni possibile nazione di questo genere in partenza (ci si chiede dunque come abbiano perdurato nel tempo intere nazioni convertite al dualismo… magia?).
Insomma, come ho già detto i peggiori calunniatori del catarismo del passato sono proprio quelli moderni.
Perché le possibilità sono solo due.
O i catari del passato NON erano come quelli sedicenti moderni che professano l’anticosmismo e l’odio del prossimo con così tanta veemenza e violenza verbale. E quindi sono in contraddizione con il loro stesso essere.
Oppure effettivamente il catarismo e dualismi analoghi del passato erano la fotocopia di quello moderno, e allora è giustificabile il fatto che siano sorti così tanti pregiudizi e leggende nere sul loro conto.
Perché non ti puoi aspettare di essere ben visto quando demonizzi, maledici il prossimo ed i suoi figli e gli auguri di estinguersi. Sicuramente il timore che “vogliano darti una mano” gli può venire spontaneo. Soprattutto se parliamo di una cultura piena di pregiudizi come quella cattolica (non dimentichiamo che per molti di loro i comunisti “mangiano i bambini!” ed i “massoni ebrei” congiurano contro di loro “per distruggere la Chiesa”!)
L’articolo di Giovanna Jacob è molto bello, offre molti spunti di riflessione, purtroppo colti malamente da Vanja, che sente minacciata o offesa a morte (eppure, fosse così, la cosa dovrebbe catarinicamente lusingarlo) da Giovanna Jacob, da Woody Allen e Da Terry Gillian la sua fede assoluta nel catarismo o la reputazione dei Catari, brave persone che vogliono che l’umanità si toilga di mezzo ai piedi – di chi? Dei bruchi?
Michele ha buon gioco a rilevare l’inconsistenza, prima che l’incoerenza, dei sostenitori in sede storiografica o attualizzante di un Catarismo che ritiene corrisponda alle calunnie sparse dai cristiani. Le controversie sul tema porterebbero lontano: cioè, ognuno a casa propria. Ma se per denigrare i cristiani gli basta come prova ripetere che credevano che i comunisti mangiassero i bambini – poteva citare quello che credevano i comunisti e il catarismo comunista, che risponde, se non lo riabilita, a analoghe pulsioni millenaristiche presetni in quel più remnoto fideismo -, be’: durante l’Holodomor ucraino si tornò al cannibalismo e il potere bolscevico che spingeva alla fame e alla morte per fame gli Ucraini più degli altri fece affiggere in Ucraina manifesti che esortavano i “compagni” a non cibarsi della propria prole – ché, si capisce, quella era di proprietà del Partito… Meglio non aggiungere altro, per non fare il gioco dei complottisti, anche non catarizzabili, che i catari alla Vanya non avrebbero da ringraziare, dato che benefattori dell’umanità che gliel’hanno fatta pagare cara, a gente inerme, non ne mencano nemmeno a discostarsi troppo dai confini geografici e temporali dell’éra staliniana.
Al postutto, dunque, meglio le distopie di Gillian e le metafore di Allen. E grazie a Giovanna Jacob per l’analisi così attenta di due film da rivedere.
Cara Giovanna Jacob, dato che sei una esperta e appassionata di horror e affini, perché non scrivi un articolo sulla fenomenologia del troll ?
Qui hai un esempio della nostra trollona preferita ( anche perché è l’unica, sotto mentite spoglie per centinaia di volte, migliaia, ma è sempre lei ! ), nelle vesti di “Vanja “.
Una sua caratteristica , oltre alla sua totale disonestà, di cui accusa immancabilmente l’interlocutore, è quella della minaccia, più o meno velata : individua nei recessi del web qualche accenno del giornalista o del lettore su cui può speculare, e vai con la minaccia.
Credo che per persistere in questo atteggiamento inquietante, conti su una eventuale seminfermità mentale : quale giudice non gliela riconoscerebbe ?
Un’altra costante della trollona è la mole spaventosa di spaventose figuracce che rimedia in continuazione, volendo discutere con gente che ne capisce qualcosa, quando lei fa del copia e incolla la sua cifra stilistica. Ma tanto le rimbalza tutto, il giorno dopo ricomincia daccapo.
O forse, più che una studiosa come te, per quest’articolo sulla trollona, ci vorrebbe uno psichiatra !
Però , pensaci…più horror della trollona , chi c’è ?
( e stai attenta, che la trollona arriva ad importunare pesantemente le vittime che riesce ad identificare : l’ha raccontato lei stessa con molti particolari…se hai qualche pagina facebook pubblica, stai in campana, che può essere pericolosa , seppure, credo , e spero, solo virtualmente )
Signor Michele, leggerò con interesse il suo sito. La ringrazio anche di avere confermato la pessima impressione che ho avuto dei catari contemporanei, che anche a me hanno augurato pene eterne, che descrivono con sadica e bestiale dovizia di particolari.
Per il resto, le consiglio di integrare lo studio della filosofia .con lo studio della storia. Lo storico Christopher Dawson ha argomentato ad esempio che, secondo i suoi studi, la civiltà europea ha rischiato di soccombere prima dell’evo moderno per opera di tre diversi gruppi di nemici:
1) i musulmani, che assediarono l’Europa per tutto il Medioevo, (continui attacchi prima da Sicilia e Andalusia poi dalla Turchia, più saccheggi sistematici lungo le coste);
2) danesi Vikinghi, che Dawson descrive come i più violenti fra tutti i barbari che già avevano devastato ‘Europa a ondate successive (i danesi distrussero l’impero carolingio disseminando la Francia di cadaveri);
3) i catari -albigesi.
Diffusi nel sud della Francia con l’attivo sostegno di alcuni principi locali, che facevano il doppio gioco politico, i catari miravano esplicitamente alla distruzione della Chiesa. Inoltre, le vorrei fare notare che, dopo la sacrosanta (per me) crociata contro questi terroristi ante-litteram, furono distrutti tutti i testi originali di detta eresia. Evidentemente non solo alle autorità ma anche alla gente comune quella eresia era parsa talmente spaventosa, talmente distruttiva, che pensarono fosse necessario non conservarne neppure traccia. Quindi oggi del contenuto dottrinario dell’eresia catara abbiamo solo informazioni indirette, dedotte da testimonianze coeve. Proprio in quanto non abbiamo i testi originali, negli ultimi due secoli molti hanno ricostruito in maniera fantasiosa la dottrina catara, fornendone una visione irenica ed edulcorata in funzione anticattolica. E così, anche grazie alla “catara” Simone Weil, è nata la leggenda pseudo-storica in cui catari buoni, pacifici, ecologisti e non-violenti (praticamente Ghandhi ante-litteram) sono massacrati da cattolici assetati di sangue. In realtà, a leggere bene le coeve testimonianze indirette, risulta che I CATARI NON ERANO AFFATTO NON VIOLENTI. Per brevità, copia-incollo un brano di Vittorio Messori apparso sul Timone:
“Pure l’atteggiamento del papa, Innocenzo III, che giunse alla fine alla decisione di impiegare la forza, fu a lungo determinato dalla convinzione che fosse possibile ragionare, convincere, ricondurre alla fede. Ci si provarono anche grandi santi, come Bernardo e Domenico. Come ammette Daniel Rops, «la pazienza della Chiesa fu ammirevole e, secondo alcuni, addirittura eccessiva». La risposta catara fu intollerante e violenta, molti missionari furono uccisi, il clero cattolico spogliato e brutalizzato. A Béziers, per esempio, la città della strage, i canonici della cattedrale avevano dovuto fortificare la cattedrale per resistere ai continui assalti degli eretici. Le cose precipitarono proprio per un gesto di violenza estrema: nel gennaio del 1208 il conte di Tolosa, protettore degli albigesi, fece assassinare il legato del Papa, inviato per un’ambasceria che portasse a un accordo e alla pace. Fu a questo punto che Innocenzo III proclamò la famosa “crociata” che ebbe sin troppo successo a causa (anche qui!) di motivazioni politiche: ”
Aggiungo che non solo a Beziers ma in tutti i luoghi in cui erano diffusi i catari facevano violenza a chiunque volesse rimanere fedele alla Chiesa di Roma. Gli unici che (ipocritamente) si astenevano dalla violenza erano i “perfetti”, che avevano ruolo di autorità ed elargivano il consolamentum ai fedeli prima di farli suicidare. Inoltre, i catari avversavano a tal punto la maternità che invitavano le puerpere neoconvertite a lasciare morire di fame i figli.
Dunque, c’è un abisso fra l’eresia catara come è stata reinventata da storici anticattolici (e come la presenta lei, con foga laicista) e l’eresia catara come si presentava nella storia concreta, come la videro i suoi contemporanei. Dalle fonti indirette che abbiamo, risulta inequivocabilmente che tale eresia… era molto simile alla credenza mortifera, violenta, intollerante e potenzialmente stragista (pure lei si chiede che cosa ci farebbero i catari con la bomba atomica) professata dai catari new age di oggi.
Infine, una precisazione sul termine “nichilismo”. Dunque, il mio non è un articolo sul nichilismo sull’eresia catara ma sul cinema, non so se se ne è accorto. Al nichilismo ho dedicato solo poche parole introduttive, che mi servivano a mettere a fuoco il tema del nichilismo esistenziale, comune a molti scrittori e artisti. Quindi non mi serviva fare tante distinzioni, fra le diverse qualità di nichilismo orientale: e chiissene frega!!! Per dirla tutta, il termine “nichilismo orientale” l’ho usato io in maniera originale, è farina del mio sacco. L’ho usto per indicare quello che alcuni storici del Medioevo, fra cui Stark e Dawson, indicano col termine “spiritualismo orientale” o termini simili, sempre per riferirsi alle correnti di pensiero che di origina gnostica che giunsero in Europa dal vicino Medio Oriente (non dal Giappone!!!!) in epoca tardo antica. Anche qui era inutile e del tutto Ot mettersi a distinguere fra filosofia di Platone, platonismo, neooplatonismo di Plotino, gnosi, manicheismo, catarismo e qualche decina di altre correnti e sette eretiche medievali: e chissene frega!!! Quello che importava mettere a fuoco subito, è che l’odio spiritualista per la carne (che pure lei riconosce in queste correnti) è intrinsecamente nichilista.
Poi lei ci tene a sottolineare più volte che il jihadismo non ha niente a che fare con l’eresia catara. tante grazie, già lo sapevamo! Io non ho mai creduto che i jihadisti possano essere entrati in possesso dei testi perduti dell’eresia catara, oppure dei testi manichei, o dei testi di Plotino. Credo che ignorino anche Nietzsche e Sartre. Più che altro credo che la maggioranza di loro abbiano letto più o meno un solo libro e lo sappiano pure a memoria (non dirò quale). Ma ci sono categorie del pensiero e atteggiamenti morali che sono universali: si ripresentano in diverse forme in tutte le culture, anche se le culture non hanno contatti fra loro. Dunque, senza stare lì a ipotizzare jihadisti persi nella biblioteca di Alessandria, dobbiamo riconoscere che nella loro rozza weltanschauung si riproduca un pensiero anti-materialista che ha molte analogie con quello dei catari. A proposito: non è farina del mio sacco. E’ stato Carlo Panella, studioso non certo sospetto di simpatie cattoliche, a ipotizzare che di recente l’islam sia stato contagiato dal manicheismo e dalla gnosi. Secondo me sbaglia: non c’è stato un contagio diretto. Semplicemente nell’islam sono già presenti fin dall’inizio suggestioni di tipo tardo- antico che di recente son diventate più palesi.
Infine, vorrei accennare a quella che secondo me è una delle principali malattie del pensiero moderno: il nominalismo ossia la tendenza a fare infinite distinzioni e quindi l’incapacità di avere una visione sintetica d’insieme. Così gli studiosi ci opprimono con infinite distinzioni fra duecento diverse accezioni della parola “nichilismo” e fra i duecento tipo di nichilismo presenti da qui al Giappone facendoci perdere la visione d’insieme: nichilismo significa odiare la realtà così come è. Su questa base, ognuno ci aggiunge tanti “accidenti”: i catari ci aggiungono il suicidio (e l’omicidio), Nietzsche ci aggiunge l’eterno ritorno e il superominismo, i poeti invece non ci aggiungono nulla: continuano a chiedere, sperando che qualcuno risponda, la risposta ala domanda di felicità del loro cuore.
Già solo gli studi del cardinal Julien Ries su Manichei e Catari vi farebbero vergognare di tutte le corbellerie ideologiche e storiche presenti in quest’articolo, figuriamoci quelli degli storici non cattolici (non di parte). Siete rimasti uguali dai tempi di Alano di Lilla!!
Disonesti e calunniatori. I terroristi erano Simon De Monfort e i suoi sgherri, non i Catari.
Studiate!!
La famosa frase attribuita al legato pontificio Arnaud Amaury (« Caedite eos! Novit enim Dominus qui sunt eius ») è stata riconosciuta come una “leggenda metropolitana” già negli anni Settanta dagli storici del medioevo. La “autorevole” fonte prima di questa frase sarebbe infatti uno scritto satirico del sedicesimo secolo (ne parla Régine Pernoud in “Medioevo un secolare pregiudizio”). Per il resto, la guerra contro i catari aveva motivazioni laiche che appaiono valide anche alla luce del diritto moderno. In breve, i catari non si limitavano a seguire in maniera personale la loro fede, rispettando le leggi: erano persone violente che facevano violenza a chi non la pensava come loro. Breve riassunto del contenuto della fede catara: il corpo è il male e lo spirito è il bene. Prima di liberare il loro spirito attraverso la privazione forzata del cibo e dell’acqua, i catari passavano il tempo a “liberare” lo spirito degli altri – bambini compresi- dalla ignobile prigione corporea. La loro foga omicida si dirigeva soprattutto verso quanti decidevano di rifiutare la loro fede e rimanere attaccati al papa. Dove arrivava la fede catara, si moltiplicavano omicidi, suicidi, incendi e devastazioni di campi e bestiame (per bloccare la produzione di cibo). Esasperati, i signori feudali delle terre toccate dalla pesta catara decisero di reagire con la forza. Il papa dapprima tentò di dissuaderli dall’usare le armi, e mandò i predicatori domenicani di Domenico di Guzman a dialogare con i catari. Nonostante le energie profuse dai domenicani, la peste continuava ad espandersi e quindi, per farla breve, i signori chiesero e ottennero dalla Chiesa il permesso di passare alle vie di fatto contro gli eretici. E fu guerra. Domanda: voi avreste preferito che una fede così oscura e mortifera continuasse ad espandersi, fino a desertificare tutta l’Europa? Non so, chiedo.
P. S. Ho avuto a che fare con catari contemporanei (perché ce ne sno anche oggi, spero pochi) e fanno davvero paura. A futura memoria, ho copiato alcune loro affermazioni diffuse su internet.
“L’uomo come creatura di carne è a immagine e a somiglianza di Satana. Dio ha creato soltanto gli Angeli e lo Spirito. Non si è mai compromesso con la materia e con la carne. Tanto voi cattolici non potete mettere a tacere la Verità, perché seguite l’iniquità e l’ignoranza. Voi credete che tutto sia opera di Dio, e così facendo equiparato lo Spirito alla merda. Siete voi i veri eretici e avete tradito Cristo e il suo Insegnamento.”
“Amore e Pace si otterranno solo con l’abbandono del matrimonio. Cos’è la tua “verità”? Un coacervo di sperma, di mestruo, di aborti, di sangue. Fornicazione, adulterio santificato, idoli, simulacri. Tutto questo è la tua “verità”? Cristo non parlò mai di questi orrori, ma li condannò con fermezza.”
“Tranquillo, non ce l’ho con i materialisti atei, perché non arrecano gran danno. Ce l’ho invece la Chiesa di Roma, che non ha nulla di spirituale pur dichiarandosi tale. Infatti i sacramenti di tale Chiesa sono materialisti e implicano adorazione della materia. Il loro battesimo avviene tramite l’acqua, il matrimonio non è altro che l’adorazione di una latrina carnale, la transustanziazione si basa sulla blasfema intenzione di trasformare Dio in materia e rinchiuderlo in una pisside. Atei e agnostici sono soltanto pagani e si può essere loro amici. Invece chi ha travisato l’Insegnamento rappresenta il Male.”
“Non nascondo il mio scopo. Combattere contro la procreazione e il matrimonio, che sono corruzione e vermina, e favorire l’estinzione volontaria dell’umanità.
La menzogna è quella che sparge la maligna Chiesa di Roma, che vuole coltivare un allevamento di polli per il Banchetto dei Demoni. I Buoni Uomini sono gli originari Cristiani, mentre i cattolici sono apostati e deviati, che sotto Costantino e Papa Silvestro hanno scelto di servire il Male.”
Signora Giovanna Jacob,
ma la storia dove la studia, su Kattoliko.it?
Di citazioni cattoliche moderne e passate da far paura potrei citarne anch’io, e a bizzeffe!! Già questo sito si commenta da solo.
Ma limitandomi alla storia di quei tempi, i devastatori selvaggi furono proprio i crociati, e questo si può evincere da decine e decine di fonti serie.
Siete come i negazionisti dell’Olocausto!!
Vale la pena riportare una sola frase del Manuale degli inquisitori di Nicolau Eymerich (il “vangelo” dell’Inquisizione per secoli): “Bisogna ricordare che lo scopo principale del processo e della condanna a morte non è salvare l’anima del reo, ma… terrorizzare il popolo”.