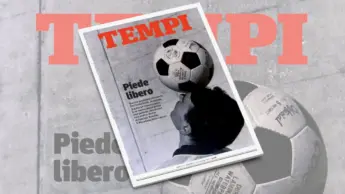
La religione oppio dei popoli e la pretesa di dettare noi le regole dell’esistenza
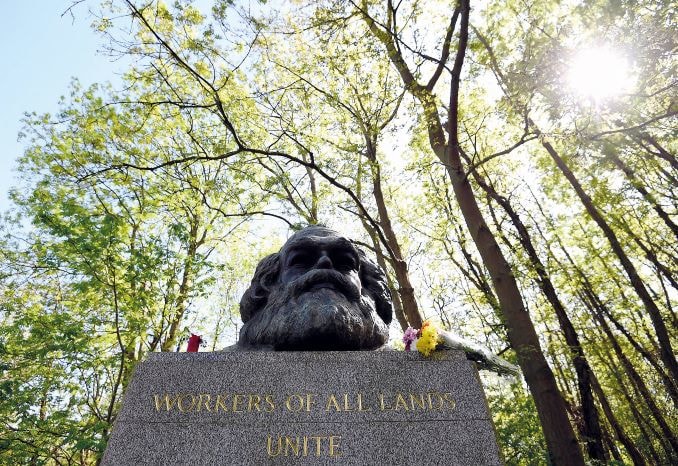
Articolo tratto dal numero di settembre 2020 di Tempi. Questo contenuto è riservato agli abbonati: grazie al tuo abbonamento puoi scegliere se sfogliare la versione digitale del mensile o accedere online ai singoli contenuti del numero.
Su Foreign Affairs, autorevole rivista americana dedicata alle relazioni internazionali – politiche, economiche e culturali – nel numero di settembre-ottobre uscito l’8 agosto scorso, è pubblicato un articolo dal titolo “Giving up on God. The Global Decline of Religion” (“Rinunciare a Dio. Il Declino Globale della Religione”). L’autore, Ronald Inglehart, è un anziano (1934) politologo e sociologo statunitense, che si è occupato a fondo delle trasformazioni culturali e religiose delle società. La sua biografia e competenza sono documentate in internet, che riporta la sua abbondante produzione di libri e di studi.
Gli studi sulla religione si occupano di un periodo assai vasto e ricco di mutamenti, che va indietro di circa quarant’anni da oggi. Inglehart parte dalla considerazione che i primi anni di questo secolo sembravano favorevoli al diffondersi della religione, che riempiva il vuoto lasciato dal crollo del comunismo, era propagandata dall’elezione del presidente George W. Bush, che non faceva mistero della sua intensa fede evangelica, si manifestava potentemente e violentemente nell’attacco alle Torri Gemelle. Tuttavia, un’analisi di 49 paesi, circa il 60 per cento della popolazione mondiale, con dati disponibili dal 1981 al 2007, metteva in evidenza che, nonostante in 33 nazioni la religiosità apparisse in aumento, in quelle ad alto reddito era chiaramente in diminuzione.
Il declino è diventato vertiginoso negli anni successivi fino ad adesso. In una scala da uno a dieci che classifica il credo religioso da “Per nulla importante” a “Molto importante”, ben 43 dei 49 paesi considerati sono diventati meno religiosi. Esemplificativamente, gli Stati Uniti, che nel 2007 raggiungevano un punteggio medio di 8,2, nell’ultima indagine del 2017 sono scesi a 4,6. Pure la Chiesa cattolica americana è profondamente in crisi. Secondo un’indagine del Pew Research Center – famoso centro studi “indipendente”, dedicato a sondaggi applicati all’analisi sociale – il 92 per cento degli adulti Usa è consapevole degli abusi sessuali commessi dai preti e l’80 per cento pensa che continuino tuttora. Per tale ragione il 27 per cento dei cattolici interrogati dice di aver ridotto la frequenza alla Messa.
Infine Inglehart si sofferma su quella che lui ritiene la forza più importante dietro la secolarizzazione: «Il mutamento delle norme che governano la fertilità umana». Riporta i risultati del World Values Survey, una ricerca condotta da scienziati di tutto il mondo, iniziata anch’essa nel 1981, sui valori che caratterizzano la vita delle persone e delle società in un centinaio di paesi. Anche qui viene usata una scala da uno a dieci per pesare il grado di accettazione di divorzio, aborto e omosessualità. Il livello di punteggio critico è 5,5: punteggi più bassi indicano che la maggioranza di una nazione è legata a visioni più “tradizionali e conservatrici”; punteggi superiori indicano una visione più “liberale, centrata sulla libertà di scelta individuale”. Agli inizi degli anni Ottanta la maggioranza dei paesi indagati sosteneva regole “pro-fertilità”, anche tra quelli a reddito elevato: si andava da punteggi medi di 3,44 in Spagna, a 3,49 negli Stati Uniti, 3,50 in Giappone, 4,14 nel Regno Unito e 5,35 in Svezia. Nel 2019 il quadro è profondamente cambiato: 5,86 negli Stati Uniti, 6,17 in Giappone, 6,74 in Spagna (!), 6,90 nel Regno Unito e ben 8,49 in Svezia.
Una vecchia idea di Marx
Inglehart sembra pensare che i cambiamenti della morale sessuale siano a capo del distacco dalla religione, sentita come insopportabile costrizione delle donne in casa a fare figli e degli omosessuali nel nascondimento della loro inclinazione. La religione avrebbe perso la sua forza coercitiva di fronte a una vita resa progressivamente più sicura, più lunga, meno condizionata dalla fame, dalla malattia e dalla violenza. D’altra parte, con il venir meno della religione le società non sono scoppiate, come allertavano i conservatori sul collasso della coesione sociale e della pubblica moralità. Anzi i paesi meno religiosi sono inequivocabilmente meno corrotti di quelli religiosi. Non che la religione produca più corruzione, è semplicemente indicatore di minor sviluppo civile ed economico. Già Karl Marx, Max Weber ed Emile Durkheim – grandi pensatori progressisti dell’Ottocento e primo Novecento – avevano predetto che la diffusione della conoscenza scientifica avrebbe espulso la religione dal mondo. Ciò non è successo perché la religione è esperienza più “emozionale” che “cognitiva” (razionale), così che l’incertezza e le difficoltà dell’esistenza tengono attaccate ancora molte persone a Dio, ma la strada è quella: la caduta della pratica religiosa, la svendita delle chiese, diventate deserte e inutili, la debolezza del clero sono conferme continuamente riportate dai media.
Inoltre Inglehart non dimentica di sottolineare, alla fine, che le religioni tradizionali sono pericolosamente divisive nella «contemporanea società globalizzata». Il futuro tuttavia non è assicurato contro il ritorno della religione perché pandemie come quella del Covid, aumentando l’incertezza esistenziale, possono ancora sospingere le persone a rifugiarsi in Dio.
Mettere Dio in secondo piano
Mi sono soffermato sull’articolo di Inglehart perché mi sembra riassumere egregiamente quelle che sono idee correnti delle élite intellettuali dell’Occidente, diffuse al popolo, che le assorbe alquanto passivamente. Non si tratta infatti dell’insorgenza di un ateismo militante, ma di un disimpegno da Dio, che appare come problema e scocciatura in più, in una vita condotta secondo quanto piace, senza tanti ostacoli o rimorsi. In tal senso vale l’accenno di Inglehart alla conquista della libertà sessuale come principale fattore anti-religioso. Temo però che l’autore scambi la conseguenza con la causa. L’uomo non si è allontanato da Dio per poter fare quel che vuole, ma è per la sensazione e la pretesa di poter fare quello che vuole che ha messo Dio in secondo piano. Come dice Benedetto XVI nella recente intervista riportata nel libro biografico Ein leben (Una vita), del giornalista tedesco Peter Seewald, si sta stabilendo «una dittatura mondiale di ideologie apparentemente umanistiche», che «scomunica socialmente» chi non le riconosce. È il lungo processo attraverso cui l’uomo tende a sostituirsi a Dio, come riassume magistralmente Luigi Giussani nel libretto La coscienza religiosa dell’uomo moderno (Jaca Book, 1985).
È l’uomo, non più Dio, che stabilisce le regole dell’esistenza e della natura, perché ritiene di possederle se non ora, nel futuro: la scienza ha fatto progressi da gigante, la lotta alle malattie è più efficace, le società sono in continuo sviluppo, addirittura quelle più avanzate sono meno corrotte e gravate da crimini. La religione è il retaggio di quelli che sono indietro, ancora in balia della fame, delle malattie e delle morti premature, oppure di quelli che non riescono a cavalcare le difficoltà e le contraddizioni della vita. In fondo Dio è l’esito dell’ansia di una catastrofe impendente. Appunto, uno degli effetti del Covid potrebbe essere il ritorno della religione.
Larghi nei modi, stretti nelle regole
La lettura della religione come risposta, tendenzialmente alienata, alla debolezza umana, «oppio dei popoli» secondo Karl Marx, è vecchia e, per quanto forse più di prima attuale, è alquanto scontata e superficiale. Il ritardo di morte e malattia, non elimina né queste, né la fragilità e l’inconsistenza umana, così come il progresso di scienza e tecnica non riesce a prevedere e bloccare alluvioni, terremoti e pandemie. Le regole che l’uomo si dà, prendendo possesso del criterio della vita, sono complicate e piene di contraddizioni, rendono la vita difficile anche quando vogliono farla facile. Si pensi alla più volte citata sessualità. Quanto più è promossa la sua “disibinizione”, con rimozione di quelli che sono ritenuti complessi, condizionamenti e pregiudizi, tanto più se ne avverte la pericolosità con moltiplicazione dei controlli nel comportamento, dell’enfasi con cui sono sottolineate le trasgressioni. Ma questo potrebbe essere ancora comprensibile: se si è larghi nel modo e nei contenuti dell’atteggiamento, bisogna essere molto stretti nelle regole. Quello che non è comprensibile, o meglio che si rifiuta di comprendere, è che il tentativo di dominio e possesso delle cose non rende la vita più felice. Sto parlando della vita delle persone di successo, come di quelle comuni, anch’esse più fortunate di una volta. Se è vero che nelle società progredite diminuiscono corruzione, furti e omicidi, è vero che aumentano separazioni, malattie mentali, aborti, eutanasia e suicidi.
Non voglio celebrare il buon tempo antico. Non sono in grado di fare paragoni attendibili, se non con la mia giovinezza, in cui, rispetto ai giovani di oggi, mi pare che le cose avessero un gusto maggiore. Potrei avere torto e la situazione di oggi potrebbe essere migliore di quella di allora, ma, leggendo i giornali e ascoltando la televisione, c’è ancora molta infelicità.
Un altro mondo in questo mondo
Le regole che gli uomini si danno autonomamente per vivere, alla vita non bastano. La vita non ci sta dentro, perché l’uomo non se la dà da solo, non la conosce abbastanza, né ultimamente la possiede. La vita la dà e la fa Dio. Ecco, la religione dovrebbe insegnare come questo avviene, tutti i giorni. Se è vero che la religione aiuta ad affrontare le disgrazie, bisogna tenere conto che non c’è disgrazia più grande di una vita senza senso, non vissuta, insensibile alla realtà e agli altri. Per rimediare a questo Dio si è fatto uomo, è intervenuto nel mondo e ha corretto la religione con la fede, la possibilità di vedere e credere nella quotidianità di un’umanità cambiata e più vera. «Un altro mondo in questo mondo», disse il seminarista Giussani al compagno Manfredini (futuro arcivescovo di Bologna), che contemplava stupefatto il Mistero dell’Incarnazione.
Foto Ansa
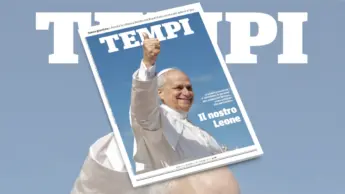


0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!