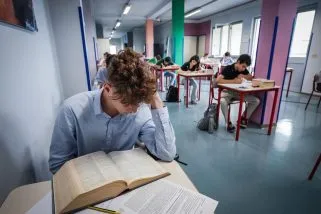
Dante e Kadare. O della malinconia per quella grandezza di cui siamo tutti fatti
Pubblichiamo quasi integralmente un articolo uscito sul quotidiano albanese «Gazeta Shqiptari» che è uscito oggi sull’Osservatore Romano.
Un buon amico, albanese e armeno, mi ha regalato due libri di Kadare, L’Assedio e Dante, il dramma dell’assedio ottomano a una fortezza albanese e la storia della ricezione di Dante in Albania. Per uno di quei casi che sono sicuro piacerebbero all’autore, ho letto il primo in inglese mentre soggiornavo a New York in aprile e il secondo in francese, sull’altra riva dell’Adriatico, nella splendida piccola Termoli, dove vivo da qualche anno. Questo intreccio di lingue, città, storie e mari ha già a che fare con la suggestiva poetica di Kadare che i due libri mi hanno dischiuso ed è forse la nota più acuta dell’interesse e della malinconia che Kadare ispira.
Ai motivi che fanno nascere e l’uno e l’altra è dedicato questo mio articolo. Cominciamo dalla malinconia. È la malinconia che è legata a filo doppio alla storia e ai luoghi. Il Dante di Kadare non è una spiegazione, non è un saggio, non è un’invenzione. È una storia d’amore e d’odio, quasi un romanzo passionale, di Dante e d’Albania. E il romanzo sull’assedio albanese è di nuovo una storia di amore e d’odio, di nuovo una passione, di impero ottomano e d’Albania. Pasolini soleva dire che ogni uomo scrive sempre lo stesso libro e gira sempre lo stesso film. C’è molto di vero in quest’espressione: ciascuno ha un suo centro, una sua nota dominante, e quanto più questa nota è universale tanto più egli riesce a comunicare con tutti.
La nota dominante di Kadare, almeno per come l’ho scoperta io, ammirato neofita, si può dire con un verso del poeta Rebora: «Oh per l’umano divenir possente/certezza ineluttabile del vero/ordisci, ordisci de’ tuoi fili il panno/che saldamente nel tessuto è storia/e nel disegno eternamente è Dio:/ma così, cieco e ignavo,/tra morte e morte vil ritmo fuggente,/anch’io ti avrò fatto; anch’io». Da che cosa scaturisce la malinconia? È sempre una differenza di potenziale tra la piccolezza o la sofferenza di ciò che si vive e il destino grande per il quale si avverte di essere fatti.
Ma la malinconia di Kadare è un amore. Non è lo scetticismo borioso degli intellettuali razionalisti per i quali tutto deve essere chiarito con l’uso deduttivo della ragione, universale e senza appartenenza, per tutti ma senza tempo. E non è il cinismo o il nichilismo di chi pensa che non ci sia nessun destino. Kadare parla sempre del destino, che scriva di Albania, di Dante o di ottomani. È il mistero di questo destino che genera la differenza di potenziale su cui la malinconia cresce: sentiamo di essere fatti per la felicità e per la grandezza ed esse non sembrano aver luogo qui nella storia. Sentiamo di essere fatti per la felicità, e lo sentiamo innanzi tutto attraverso i luoghi e persone che amiamo.
La felicità è sempre particolare, legata a facce e panorami, a lingue e a costumi. La felicità deve passare attraverso quel tipo di roccia e quel tipo di lingua e deve essere per quella faccia di donna tanto amata, di figlio disgraziato e benvoluto a un tempo. Non esiste la felicità per tutti se non è per qualcuno. Eppure questa vita sembra sempre rimandare il momento nel quale la grandezza avverrà, la felicità si realizzerà. Il compimento sembra impossibile e alle volte disperatamente assente o impossibile, come il ritorno di Dante nella sua Firenze, come la libertà della lingua e del popolo albanese dagli ottomani o dal regime comunista, come il riunirsi di tante vite spezzate da emigrazione disperata. La vita è fatta per essere felice e, invece, spesso il destino incombe inquietante e persino minaccioso.
O peggio ancora, indifferente, come il cielo che Tursun Pasha guarda prima del disperato atto suicida. Kadare però non pensa che questa incomprensibilità del destino significhi rinunciare al desiderio, e neanche alla fatica che questo desiderio comporta: i suoi personaggi, inventati o storici, vivono il desiderio del compiersi di questo destino e la lontananza dalla sua realizzazione. La vivono in modo diverso, ottomani e cristiani, ma il destino, lontano o vicino che sia, è l’orizzonte di ciascuno.
Dove e come si vive questo infinito paradosso dell’essere umano, fatto per la felicità e costretto a lottare infinitamente per essa senza mai raggiungerla? Per Kadare non c’è dubbio: nella storia, a cominciare da quella della propria terra, del proprio popolo, del proprio linguaggio. Kadare mostra che un grande poeta è sempre “un vivente fra morti” e un vivente ha una patria, un paesaggio e una lingua a cui appartiene con tutto se stesso.
Non c’è Dante senza Firenze e italiano, e non c’è Kadare senza Albania. Sembra un principio esclusivo e invece è l’inizio di una vera universalità, molto diversa da quella illuminista. Quanto più uno appartiene a qualcuno e a qualcosa, ed è sicuro dell’amore dominante della sua vita, tanto più è capace di leggere e capire gli altri, di vivere sotto qualsiasi cielo e in qualsiasi situazione: è quando si sa per chi si lotta che non si ha paura di partire. Così il destino di Kadare non è il Fato oscuro e imparziale che governa la filosofia dei soldati musulmani che assediano il castello albanese, ma è l’ideale al quale la libertà dell’uomo collabora, anche in esilio come il povero Dante, anche nel carcere di Pound o di Koliqi, anche nell’inferno del comunismo. L’ideale tarda a realizzarsi e certe terre, come l’Albania, paiono testimoni di un infinito martirio.
Ma Kadare non pensa che il martirio sia inutile o disperato, ne soffre la tristezza ma senza disperazione. Nel tessuto è storia e nel disegno eternamente è Dio. Siamo noi uomini che lottiamo per fare la storia, e sembra che tutto finisca male; eppure ci sono inaspettati tornanti buoni, e al fondo — sembra dire Kadare — tutti questi nostri sacrifici devono avere un significato buono del quale, forse, quelle piccole svolte positive sono segno. Ed ecco dove nasce l’interesse. Il significato della storia, del tessuto e del disegno, si gioca nei cuori degli esseri umani singoli, è una storia di dettagli, perché è nei dettagli che si vede la grandezza e la piccolezza, la lotta per il destino o l’arrendersi al fato.
I cuori degli uomini da questo punto di vista sono uguali, senza distinzioni di lingua, di rango, di genere. La storia si gioca nella mente fatalistica di Tursun Pasha, a capo di una milizia infinita così come nei dialoghi da harem delle mogli scaltre e spaventate, nel grande Dante o nel grande Kastrioti come nella prostituta emigrata a Milano. L’interesse nasce perché il problema del rapporto tra la vita e l’ideale, il destino, è uguale per tutti, quindi anche per l’ultimo lettore, ovunque egli si trovi. Ciò non significa che i lettori siano monadi isolate e indifferenti. La comprensione di un autore come Dante o di una vicenda come quella della guerra con gli ottomani è di nuovo legata a un fenomeno particolare, quello del popolo.
I singoli formano un popolo quando vi è comunanza dei temi, delle domande, dei tentativi di risposta. E le storie di popoli, come dimostra la ricezione di Dante in terra albanese, sono anche storie di amicizie fra popoli.
Tutti i popoli di mare, e tanto più di questo mare, capiscono il ritorno a casa di Ulisse, il pianto dell’emigrante o dell’esule, la morte improvvisa, sovrastante e inspiegabile che solo il mare e la montagna sanno dare. Kadare illumina la vicinanza splendida delle ballate popolari — con i loro racconti e le loro raccomandazioni — alla sublime vicenda dantesca dei tre mondi celesti, la comunione profonda fra le domande piccole e grandi che fanno la vita di ciascuno di noi destinati all’oblio e dei versi che per sempre immortaleranno i personaggi danteschi. Proprio queste ultime rappresentano forse il luogo più suggestivo dell’intreccio di destino e storia quotidiana, di grandezza del nostro sentire e della piccolezza delle nostre storie che Kadare illustra mischiando le frasi di Dante con le nostre povere voci di mare: «che succede a Roma, guerra o pace? Partimmo da Durazzo e annegammo nel canale d’Otranto. Ricordati di me, che son la Pia. Siena mi fé, disfecemi Maremma. Accendi un cero per me al cimitero di Rmai. Ho reso l’anima pronunciando il nome di Maria». Sono le nostre storie piccole che creano la storia grande, quella tradizione per la quale battersi per un castello o per l’insegnamento di una lingua non è inutile anche se la vittoria non durerà; e tradurre la poesia di Dante è fondamentale anche se l’esito non si vedrà.
Come le aquile sulle rocce d’Albania, la poesia di Kadare vede l’orizzonte lontano e il dettaglio infinitesimale e oscuro. Ma l’uno non esiste senza l’altro. Nel tessuto è storia e nel disegno è Dio.



1 commento
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono chiusi.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!