
Un fuoco nella nostra notte

«Non so perché, ma non ho mai provato odio per i ricchi, né ho mai amato chi fa troppe prosopopee sul proprio passato povero./ Semplicemente penso che la gente dia troppa importanza a queste cose./ (…) Detesto chi dopo i vent’anni ha ancora l’ossessione della rivincita. (…) C’è un cantante famoso, con il quale ogni tanto vado a cena, che non fa altro che dirmi che lui era povero e che con il successo si è riscattato./ Ho deciso di non vederlo più, perché i suoi discorsi mi annoiano».
È grazie a proposizioni come queste, semplici, nette, fastidiose per chi ne è contraddetto, che ci si lega subito a un libro come Dimenticami dopodomani, Rubbettino Editore, ultimo lavoro di Andrea Di Consoli, che nei mesi scorsi è tornato a pubblicare dopo qualche anno su invito insistente dell’amico scrittore Mario Desiati. Il libro è stato presentato a Roma il 4 dicembre nell’ambito della Fiera “Più libri più liberi”.
Non è il titolo più bello che si potesse scegliere, e forse i titoli non sono il forte di Di Consoli, dato che anche la bella trasmissione televisiva Rai di cui è autore – e dove poeti intelligenti come Franco Arminio e Davide Rondoni discutono con profondità “aliena” rispetto al prodotto televisivo medio – si intitola, direi banalmente, “La biblioteca dei sentimenti”.
Lo dico con umiltà e mi chiedo “cosa non colgo?”, io che nei titoli cerco un certo “cuore” delle cose, e forse per questo libro, magari non meno banalmente, avrei scelto come titolo le parole con cui Piero Sansonetti intitolò un vivace giornale di qualche anno fa: Gli Altri. Perché la presenza degli altri, l’urgenza degli altri – così come sono, deludenti! – è per me il cuore di questo libro.
Un libro di “contestazione”
Illumina su questo la pagina 64, dove Di Consoli ricorda così un dialogo con la figlia Anna, adolescente delusa dai compagni.
«Stasera ho detto a mia figlia Anna che deve essere più indulgente con i suoi amici che la vita dà e toglie, /che una volta il male lo riceviamo e una volta lo facciamo./ E nonostante con gli anni mi sia un po’ chiuso e sia diventato più diffidente rispetto a quando ero giovane/sempre la spinta ad andare avanti mi arriva dagli altri.
(…) La cosa oscena è che gli altri sono terribilmente uguali a noi/ anche quando ci crediamo diversi e migliori. (…) Sii sempre come sei, ma non allontanarti mai dagli altri/ cercali soprattutto quando hai desiderio di allontanarti/ e di non parlare,/ perché sono gli altri che quando meno te lo aspetti sanno accendere un fuoco nella nostra notte, dare un senso a quest’avventura».
Non arriva come una predica o una lezione di educazione civica, questo invito all’indulgenza e all’uscita dal proprio orgoglio, ma è l’esito di una scoperta, di un bisogno di indulgenza per sé. «Sono una persona che conosce il dolore – ma anche la vergogna, la miseria umana e la colpa».
Del resto, in questo libro, una prosa lirica di momenti di vita e riflessioni, nulla arriva al lettore come lezione o moralismo. È proprio la coscienza della miseria umana, personale, a renderlo, d’altro canto, un libro di “contestazione”.
È una parola che forse non piacerà all’autore, perché è un libro che contesta senza volerlo fare, ma esprime la mia esperienza di lettore: questo è un libro di contestazione nel senso che demolisce gli ideali culturali e sociali del nostro tempo, non soltanto quelli che condanniamo con più facilità – fama, denaro, successo – ma anche quelli che tendiamo a esaltare, come il sentimento del riscatto, il primato, l’eroismo le belle utopie.
Utopia:
«Non ho nessuna dimestichezza con le utopie e le città del sole. Per me il socialismo è questo: alzare il telefono e chiedere a qualcuno che ne ha la possibilità di dare una mano a qualcun altro».
Eroismo:
«I morti del Carso non fanno piangere più nemmeno un discendente di quarta generazione, e tutto è dimenticato, innocuo: i pidocchi, il cognac per darsi coraggio, gli scarponi nel fango».
La “resa”
Ho letto Dimenticami dopodomani in pullman, di ritorno da un lungo viaggio, con un gruppo di diciottenni che hanno recitato i brevi capitoli ad alta voce, rapitissimi, perché si fa leggere e capire anche dai giovani, questa originale “prosa lirica”, dove ogni tanto «il settenario occupa il verso libero e la pausa si protende al punto giusto», come nota Desiati nell’introduzione. L’ho fatto perché è bello e commuove, ma anche per un motivo semplice, che definirei educativo: il fatto è che gli uomini non accettano di essere questa miseria che Di Consoli sbatte in faccia al lettore continuamente, e finiscono per identificarsi nel fare, nelle proprie costruzioni e nel proprio orgoglio. Sono i vincenti o gli illusi, perché poi ci sono i “vinti”, che sono la maggior parte e vivono, di solito a partire dall’età adulta, senza stimarsi.
E invece questo libretto disarmato, questo libretto della “resa” (altra “parola-cuore” del testo), senza risposte e spiragli, demolisce questi modelli vincenti con frasi come quella riportata all’inizio: «Penso che la gente dia troppa importanza a queste cose»; frasi disarmate che diventano disarmanti e ci fanno sentire, almeno un po’, che non possiamo essere solo questo. E che un qualche bene, forse, è meglio cercarlo fuori dal nostro io e dal nostro orgoglio, negli altri.
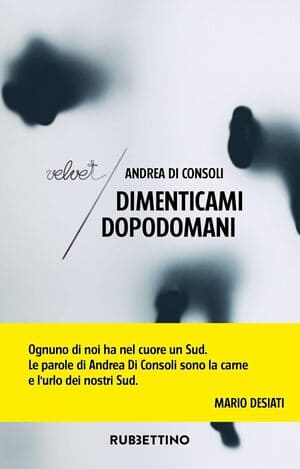
***
Disclaimer: grazie al programma di affiliazione Amazon, Tempi ottiene una piccola percentuale dei ricavi da acquisti idonei effettuati su amazon.it attraverso i link pubblicati in questa pagina, senza alcun sovrapprezzo per i lettori.



0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!