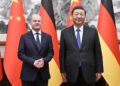Si può definire xenofobo e antieuropeista un paese di 8 milioni di abitanti dove un quarto della forza lavoro è costituita da stranieri, i forestieri rappresentano il 23,3 per cento della popolazione, e di essi i due terzi provengono da paesi dell’Unione Europea e dell’Efta? Sì, se il paese si chiama Svizzera e se il suo popolo approva a stretta maggioranza un referendum che stabilisce che sarà il governo elvetico a decidere il “contingente” di lavoratori stranieri nel paese anno per anno. O almeno questo è ciò che hanno fatto numerosi commentatori negli altri paesi europei, mentre i dirigenti dell’Unione Europea a Bruxelles hanno semplicemente minacciato rappresaglie.
Ma la Confederazione elvetica non è uno Stato sovrano, non ha il diritto di decidere chi entra in casa sua e come? No, dicono commentatori e commissari europei, la Svizzera ha firmato con Bruxelles l’accordo per la libera circolazione di merci, capitali e lavoratori, e deve mantenere l’impegno assunto. Se cambia idea, saltano per aria anche gli altri 200 accordi bilaterali che Berna ha concluso con l’Unione Europea negli ultimi 21 anni, perché tutti essi presentano una clausola detta “della ghigliottina”: se anche un solo accordo non viene rispettato, tutto il pacchetto decade.
«Il mercato unico non è un formaggio svizzero, non si può avere un mercato unico con dei buchi», ha dichiarato con umorismo tutto lussemburghese il commissario per la Giustizia e la Cittadinanza Viviane Reding. E il presidente della Commissione Barroso ha rincarato la dose: «I patti vanno rispettati, non negozieremo con la Svizzera sulla libera circolazione delle persone».
Già, ma c’è una cosa che a Bruxelles non si sono ricordati di tenere in considerazione. Si chiama democrazia, quel sistema politico dove, come spiega l’etimologia greca della parola, a esercitare il potere è il popolo. Era dal 2005 che un voto popolare non rimetteva in discussione disposizioni decise dall’alto dalle istituzioni di Bruxelles e approvate dai capi di Stato e di governo. Allora erano stati francesi e olandesi a bocciare per via referendaria il Trattato di Roma che ampliava i poteri dell’Unione e istituiva la Costituzione europea. È vero che poi nel 2008 gli irlandesi bocciarono il Trattato di Lisbona, versione emendata di quello di Roma, ma subito nel 2009 si rimangiarono la bocciatura. Con gli svizzeri sarà molto più dura.
I commentatori che non hanno voluto buttarla sulla xenofobia, per esempio il Financial Times, l’hanno buttata sugli indicatori economici per dire che comunque gli svizzeri si sono sbagliati. «Il 56 per cento circa delle esportazioni elvetiche è diretto nell’Unione Europea, che rappresenta dunque un mercato vitale. Se alla Svizzera venissero imposti dazi doganali, ciò causerebbe una danno economico. Inoltre il mercato svizzero del lavoro sarà altamente vulnerabile anche alla più piccola quota migratoria. La Svizzera ha solo 8 milioni di abitanti, un numero equivalente a meno del 2 per cento del totale della popolazione dell’Unione. E tuttavia è sede di cinque delle 50 più grandi aziende europee per quotazione di Borsa. Essa pertanto dipende pesantemente da immigrati Ue altamente qualificati per far funzionare tali attività».
 Questa però è solo la metà della verità: se è vero che l’Unione Europea assorbe il 56 per cento dell’export elvetico, è altrettanto vero che essa è l’origine dell’80 per cento delle importazioni svizzere: prima di far saltare la libera circolazione delle merci farebbe meglio a pensarci un po’ su, anche perché i paesi dell’Unione e la Svizzera sono membri del Wto, e i dazi unilaterali potrebbero essere denunciati come violazioni degli accordi di libero scambio in quella sede.
Questa però è solo la metà della verità: se è vero che l’Unione Europea assorbe il 56 per cento dell’export elvetico, è altrettanto vero che essa è l’origine dell’80 per cento delle importazioni svizzere: prima di far saltare la libera circolazione delle merci farebbe meglio a pensarci un po’ su, anche perché i paesi dell’Unione e la Svizzera sono membri del Wto, e i dazi unilaterali potrebbero essere denunciati come violazioni degli accordi di libero scambio in quella sede.
Invocare il fantasma di una minore crescita del Pil non è esattamente un argomento che possa riempire di incubi i sogni degli svizzeri: stiamo parlando di un paese con un reddito pro capite annuo di 82.730 dollari, il secondo al mondo dopo la Norvegia. Negli anni della crisi finanziaria e della recessione accompagnata dall’esplosione del debito pubblico nel resto dell’Europa, il debito svizzero è sceso dal 41,8 per cento del Pil nel 2008 al 35,3 per cento del 2013. Tutto merito degli accordi conclusi con l’Europa? Difficile sostenerlo: è dalla prima metà del XX secolo che la Confederazione attira lavoratori e capitali stranieri. E poi che razza di accordi avrebbero stretto gli svizzeri con l’Unione, se ad avere l’economia in salute alla fine sono solo loro e i tedeschi?
Un problema di occupazione
Ma sia pure: le quote all’immigrazione del lavoro straniero rischiano di compromettere il buon andamento dell’economia. Lo hanno sostenuto, e per questo hanno chiesto di votare “no” al referendum, le grandi banche, la Confindustria elvetica e tutti i partiti di governo tranne l’Unione democratica di centro (Udc), una formazione conservatrice che vanta la maggioranza relativa col 26,6 per cento dei voti.
Ora, per prima cosa va detto che non c’è solo la macroeconomia, ma anche la microeconomia, e quello che può essere un vantaggio generale a livello locale crea problemi. Il cantone che ha fatto pendere il risultato finale del referendum dalla parte del “sì” è stato il Ticino, dove l’applicazione degli accordi di Schengen, insieme al vecchio accordo italo-svizzero del 1976 sui frontalieri, ha effettivamente creato problemi economici a molti ticinesi.
In un mercato occupazionale da 240 mila posti di lavoro, gli italiani oggi ne occupano 60 mila, provocando un abbassamento dei livelli salariali e creando ansia: «Per noi ticinesi la libera circolazione significa che 3-4 milioni di lombardi e piemontesi, con la crisi attuale che vive l’Italia, premono alle frontiere e sono pronti a occupare i nostri 240 mila posti di lavoro», spiega Sergio Morisoli, deputato ticinese di un partito liberale. «È come se i 4 milioni di posti di lavoro della Lombardia entrassero nel mirino di 90 milioni di persone alle sue frontiere». A ciò si aggiunge il fenomeno dei “padroncini”, artigiani italiani che invadono il mercato ticinese dei servizi e mettono in crisi le imprese locali: «Ci sono centinaia di camioncini che ogni giorno varcano la frontiera, guidati da elettricisti, idraulici, tecnici vari che praticano una concorrenza scorrettissima», racconta Claudio Mesoniat, direttore del quotidiano ticinese Il Giornale del popolo. «Offrono i loro servizi a prezzi stracciati, perché non pagano le imposte qui in forza degli accordi con l’Europa, e non le pagano nemmeno in Italia perché sfuggono al fisco italiano». In Ticino persino i Verdi hanno appoggiato il “sì” al referendum, e abbiamo detto tutto.
Ma a parte la specificità ticinese, non si può dire che siano state motivazioni economiche a determinare il risultato del referendum. Il tasso di disoccupazione in Svizzera sta al 3,5 per cento. S’è parlato di qualità della vita, di treni sovraffollati e affitti alle stelle nelle principali città. Ma le città (Ginevra, Zurigo, Basilea) hanno votato “no”. A votare “sì”, oltre al Ticino, sono stati i cantoni rurali di lingua tedesca. Gente che ha «scelto l’identità piuttosto che la prosperità», come ha titolato Le Monde. Così il giornalista Antoine Menusier ha spiegato l’arcano: «Su queste questioni europee, fondamentali in termini identitari, è forte il timore della diluizione e pregnante il sentimento di superiorità democratica, ed è la campagna, soprattutto la campagna svizzero-tedesca, che dà la nota. O quel che ne tiene il posto: dei paesaggi di una bellezza opera del lavoro umano, dove si mescolano il romanticismo alpino e l’imperialismo “bio”».
Veniamo al punto: non è solo questione di identità, è questione di democrazia. L’incompatibilità fra il modello politico dell’Unione Europea, verticistico e votato a imporre l’uniformità, e quello svizzero, dal basso e concepito per tutelare le diversità, va accentuandosi col passare del tempo. Nel 2001 l’adesione all’Unione Europea fu respinta dal 76 per cento degli svizzeri in un referendum; secondo un sondaggio commissionato dalla tv di Stato nel 2012 i favorevoli erano scesi addirittura al 6 per cento. Secondo quello stesso sondaggio, i favorevoli ad aderire almeno allo Spazio economico europeo (See) sarebbero appena l’11 per cento: al referendum del 1992 il “no” al See vinse di un’incollatura, 50,3 per cento contro 49,7.
Le reazioni irritate e minacciose delle Reding e dei Barroso si spiegano soprattutto col “cattivo esempio” che la democrazia diretta svizzera dà agli altri popoli europei. Spiega Wolf Linder, ex direttore dell’Istituto di scienze politiche dell’università di Berna: «I diritti popolari sono sempre stati diritti di opposizione, soprattutto contro il governo e in questioni di politica interna. Oggi però assistiamo a un’internazionalizzazione della politica. Politica interna ed estera non possono più essere distinte con chiarezza. Per questo la settimana scorsa i cittadini svizzeri hanno scoperto un nuovo tipo di democrazia diretta. Possono opporsi al processo di globalizzazione e di europeizzazione. È una cosa che in nessun altro paese europeo è possibile fare. E poiché la politica dell’Unione Europea è soprattutto una politica delle élite, con forti carenze democratiche, non c’è da stupirsi che le persone di altri paesi facciano i complimenti alla Svizzera. È difficile introdurre la democrazia diretta, perché le élite politiche dovrebbero cedere una parte del loro potere decisionale».
Afferma Sergio Morisoli: «I successi della Svizzera non sono dovuti agli accordi bilaterali con l’Unione Europea, ma a due punti di forza, a due peculiarità che solo qui si trovano: democrazia diretta e federalismo fiscale. Perché la burocrazia svizzera funziona meglio di tutte le altre? Perché i politici fanno, prima o poi, quello che il popolo vuole? Perché qui la sovranità appartiene veramente al popolo, che la esercita direttamente, e perché grazie al federalismo fiscale (un terzo del gettito fiscale va ai comuni, un terzo ai cantoni e un terzo al governo federale, ndr) controllori e controllati sono vicinissimi. Il potere politico, il controllo della spesa, la sorveglianza sull’amministrazione in Svizzera sono decentratissimi, e così gli svizzeri vogliono che restino. Questo a Bruxelles proprio non lo capiscono».
Grazie a questo modello politico, «il cittadino medio svizzero è più politicamente competente del deputato medio del Bundestag tedesco», ha scritto il politologo tedesco Gerd Habermann. Il quale aggiunge: «Sia i cantoni sia i comuni dispongono di un potere reale, a cominciare dalla sovranità fiscale. La diversità viene concepita come un’opportunità, non come disparità indesiderata, da compensare con l’“armonizzazione”. Il grado estremo di suddivisione del governo, cioè la coerente applicazione del principio di conferire le competenze più importanti al livello più basso e di favorire il privato sul pubblico e le strutture informali su quelle formali, implica che il principio di sussidiarietà è praticato in Svizzera come in nessun altro luogo in Europa».
Qui siamo davvero agli antipodi del modello dell’Unione Europea, che si presenta come l’incarnazione dell’“unità nella diversità” e della sussidiarietà, ma ha ridotto l’una e l’altra a puri slogan privi di contenuto. In nome del mercato unico la diversità viene annullata in omogeneità attraverso l’“armonizzazione”, mentre la sussidiarietà si riduce a una ripartizione di competenze fra gli Stati nazionali e Bruxelles. Tutto – la scarsa democrazia, la concentrazione di potere burocratico, l’omologazione delle diversità – viene giustificato in nome dell’integrazione europea, fine supremo perché foriero di prosperità e diritti realizzati.
Altro che ostacolo
Ma proprio qui sta l’errore di prospettiva: la Svizzera non è un ostacolo all’integrazione europea, ma il modello di come avrebbe dovuto essere e non è stata. È un esempio di integrazione politica dal basso, fatta per proteggere le diversità e le libertà della singola persona e della sua comunità territoriale, laddove l’Unione è il modello di un’integrazione dall’alto, elitaria e antidemocratica, dove persone e comunità sono piegate a un’uniformità decisa dal vertice.
Come spiegava il filosofo elvetico Denis de Rougemont, la Svizzera è nata come un’unione di stati, costituita allo scopo di preservare l’autonomia delle città e delle comunità contadine affiliate: «Si associavano per difendere la loro diversità, il fondamento della loro solidarietà non era il potere collettivo, bensì l’autonomia del singolo». Fino alla fine della sua vita De Rougemont si è impegnato per un’integrazione europea fatta a partire dalle comunità e dalle regioni, come nel modello svizzero, e non dagli stati nazionali centralizzati che riproponevano il loro modello a Bruxelles. Non è stato ascoltato, e il risultato è ben sintetizzato da Habermann quando definisce l’Unione Europea attuale «dominio della pseudoprofessionalità burocratico-tecnica, unita a un lobbismo ben mascherato». La vera Unione Europea è la Svizzera. Ditelo agli orfani di De Gasperi, Schuman e Adenauer.